Numero Completo 03

Editoriale
Partiamo dalla fine: con questo numero chiudiamo il primo anno della rivista e almeno di un’intuizione iniziale abbiamo avuto conferma: per sopravvivere sul lungo periodo ci servono contributi all’attività dell’associazione, altrimenti detti abbonamenti alla rivista. Ne abbiamo raggranellati un po’, più di un centinaio, e altrettanti ce ne servono. Questo solo ci può garantire di uscire e quindi di approfondire e problematizzare in forma cartacea gli aspetti pratici di quel pensiero libertario e di quell’anarchismo costruttivo i cui intenti abbiamo delineato nell’editoriale del primo numero. Quindi, se apprezzate il nostro lavoro iniziale, provate a fare in modo di allargare il giro delle lettrici e dei lettori, indicando la rivista a chi pensate possa interessare.
Ritorniamo all’inizio: semi sotto la neve, dicevamo, ovvero pratiche ed esperienze libertarie nei più diversi campi basate su un metodo antiautoritario, collettivo, tendenzialmente egualitario. Semi sotto la neve, o gocce nel deserto, o tracce di umidità sotto qualche centimetro di un terreno, in senso reale e figurato, desertificato, potremmo dire. In antichità in diversi luoghi aridi, come in Salento, vi era l’uso, oggi ripreso da alcune associazioni e singoli, di costruire strutture in pietra «di condensazione», cioè in grado di riutilizzare l’aria umida ai fini della coltivazione. Metafore diverse, ma la sostanza non cambia.


Quelle che trovate in questo numero sono esperienze, così come nei primi due numeri, che denotano un fare ispirato a principi libertari, un cominciare qui e ora, in senso antiautoritario. Sono esempi di «anarchia come organizzazione», direbbe Colin Ward, sono – aggiungiamo noi – «pezzi» di anarchia, nella consapevolezza che, come amava dire Amedeo Bertolo, l’anarchia è un po’ come l’alcol puro, imbevibile in purezza, ma necessaria, se diluita nelle giuste dosi, a preparare bevande assai gustose. Bene, la finiamo con le metafore. Quel che intendiamo dire è che dalle pagine di questa rivista si va configurando – con tanti limiti, i nostri – una nuova anarchia, una anarchia che potremmo chiamare modulare. Il modulo è un elemento con caratteristiche comuni, che si adatta alle più diverse esigenze. Ci sono cioè elementi anarchici in «posti» reali e mentali i più disparati, ci sono elementi di metodo e di fine simili, declinati praticamente nelle maniere più diverse. Tali elementi sono, tra gli altri, la libertà, l’uguaglianza, la solidarietà, il fare da sé (in prima persona), il mutuo appoggio. Ciò indica come non vi sia, e non sia logicamente pensabile, una anarchia completa, o totale, o pura appunto, ma elementi anarchici in contesti apparentemente alieni o lontani dall’anarchia. E noi intendiamo trovarli, analizzarli, interrogarli, farli conoscere, come facciamo in questo numero con il trentennale progetto Wespe, un complesso di realtà autogestite a Neustadt an der Weinstrasse (Germania), con lo Spaccio popolare autogestito di Bologna e con la Scuola sperimentale di italiano Asnada a Milano.
Tanto altro trovate in questo numero: un approfondimento sulla critica situazione politica dei libertari in Russia, uno sul possibile utilizzo cosciente, autogestito e conviviale delle cosiddette tecnologie dell’informazione e della comunicazione, uno sull’autonomia zapatista; una pregnante conversazione con Riccardo Gatti, da anni impegnato nei soccorsi in mare ed ex presidente di Open Arms Italia; la traduzione di un articolo pubblicato nella rivista «Libre Pensamiento» di Madrid sui lavori insostenibili, o meglio sulla mutazione che ha subito il concetto di lavoro sino a diventare un’attività inutile, se non dannosa, per la società; un nuovo articolo del nostro collaboratore Felice Liperi sulla esplosione inevitabile del ‘68 dal punto di vista dei suoni e delle visioni che l’hanno caratterizzato; due radici, cioè profili storici di militanti e intellettuali che hanno ancora qualcosa, o molto, da dirci: in questo caso Mary Wollstonecraft e Martin Buber, visti da Francesco Berti e da Furio Aharon Biagini.
Infine, ma non per importanza, le illustrazioni: a curare questo numero, così come la copertina, è Alketa Delishaj (Scutari, 1982), a cui si aggiungono i due ritratti di Roberto De Grandis, che insieme a Guido Candela si occupa, numero dopo numero, di trovare artisti e artiste i cui tratti arricchiscono questa nostra modesta pubblicazione. A tutti loro, così come a Pier Paolo Del Bianco, le cui illustrazioni avete trovato nel n. 2, il nostro sincero ringraziamento.




La WESPE trent’anni dopo: retrospettiva di un progetto anarchico che ha molto da raccontare
Annalisa Bertolo
Arrivo alla stazione di Neustadt an der Weinstrasse (Germania) un sabato pomeriggio di aprile e ad aspettarmi ci sono Ede e Michael, due signori sorridenti sulla sessantina passata. Li riconosco perché, come mi hanno preavvisato, hanno con sé una bicicletta con un rimorchio che dà nell’occhio. In effetti li vedo subito, il carretto è coperto da un vistoso telo rosso e nero, vestigia di gloriosi tempi passati. Il rimorchio, ci dice subito Ede, ha trent’anni ed è perfettamente funzionante. Lo producevano negli anni Novanta, alla Wespe, lui con dei colleghi che si erano messi a farlo professionalmente, però poi non ha funzionato, costava troppo.
Per me è molto emozionante rimettere piede in questa cittadina tedesca, dopo trent’anni. Ero venuta nel novembre del ‘91, su invito di Horst Stowasser, per conoscere il progetto Wespe e per farne un articolo. Horst Stowasser (1951-2009) è stato un pensatore anarchico, autore di diversi libri, pubblicista, nonché ispiratore dell’importante progetto Wespe.
Ede e Michael ci scortano a piedi nel centro della bella cittadina, contornata dalle vigne del Reno, fino all’Ökohof, una ex fabbrica di mobili acquistata all’epoca e tutt’ora gestita dalla loro associazione, che ospita una casa di mattoni molto bella con giardino, un ristorante e diversi annessi.
Su un lungo cartellone appeso al muro della casa si legge: «Vivere e lavorare equamente a prezzi sostenibili dal 1989 – Wespe: associazione che promuove l’ecologia e l’autogestione». E una bella vespa disegnata, simbolo del progetto.
«Vivere e lavorare equamente a prezzi sostenibili dal 1989 - Wespe: associazione che promuove l’ecologia e l’autogestione»


Dagli articoli che avevo letto prima di partire sapevo già che il progetto ambizioso, partecipato e politicamente impegnato che avevo trovato nel suo pieno fulgore la prima volta che ero venuta a Neustadt, non esiste più. In realtà non esiste più già da tanti anni.
Ugualmente mi interessava incontrare persone che ne avevano fatto parte, capire cosa fosse successo, quali sono i meccanismi che fanno fallire le migliori e più idealistiche intenzioni, cosa rimane oggi di tutto questo.
Dopo un secondo giro in città, dove visitiamo due realtà econo miche ancora esistenti e floride, che erano state colonne portanti del progetto Wespe e cioè la libreria Quodlibet e il negozio di alimentari biologico Abraxas, torniamo nella casa di Michael che abita proprio nell’Ökohof, in un appartamento condiviso al secondo piano. Nell’Ökohof ci sono appartamenti abitati, c’è la sede di Anarchiv, l’archivio storico delle pubblicazioni interna zionali anarchiche, fondato da Horst Stowasser e ancora attivo e poi ci sono diversi spazi affittati attualmente ad esterni, un ri storante, degli studi grafici, un parrucchiere e una casa per gli apprendisti falegnami in viaggio (antica tradizione tedesca).
Ma che cos’è la Wespe oggi e cos’è stata in passato?
Wespe, acronimo di « Werk selbstverwalteter Projekte und Ein richtungen» (Officina di progetti autogestiti) è il nome della pri ma associazione che si creò a Neustadt alla fine degli anni Ot tanta e che radunava alcune realtà alternative e autogestite della sinistra locale. C’era dunque un fermento in questa cittadina, un sostrato politico e di esperienze autogestite, base perfetta per sperimentare il famoso «Projekt A» («Das Projekt A» 2019), il progetto elaborato da Horst Stowasser e diventato poi un libro che circolava con successo in quegli anni nel mondo libertario tedesco.
Nel suo «Projekt A» Horst desiderava portare l’anarchismo nella realtà, dargli una chance concreta, avvicinarlo alle persone comuni.
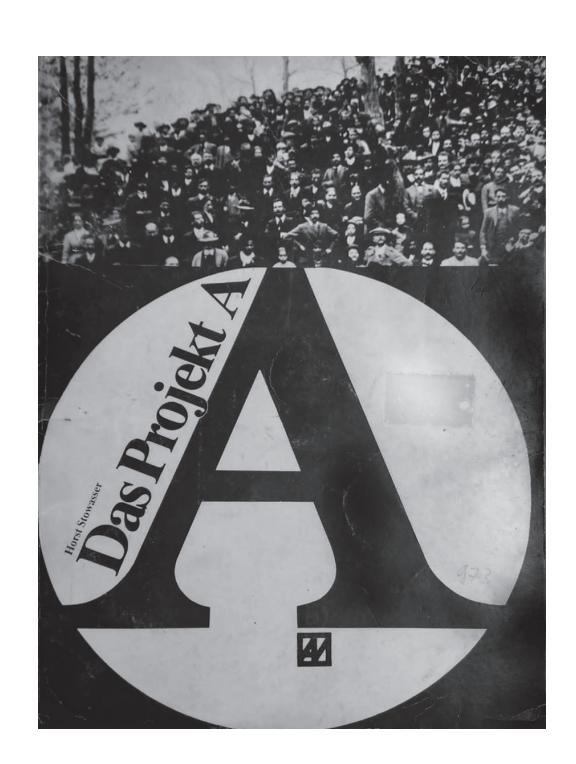
«Era il tentativo di ancorare l’anarchismo nel quotidiano, sot traendolo alle scuole di pensiero e al ghetto politico, come un normale modello di vita per le persone comuni, anche per quelle che non si interessano di politica. L’idea era di far nascere dei così detti ‘progetti doppi’, cioè affiancare una realtà economica che porta soldi a una culturale, sociale o politica, che li utilizza. Far nascere e sviluppare ditte e progetti economici autogestiti e in mutuo appoggio tra loro, non gerarchici ed ecologici e con i guadagni supportare le iniziative culturali e sociali e tutti quei progetti che non si sostengono da soli. Tutto ciò combinato con case collettive o comuni, singoli e famiglie. Ciascuno secondo la propria inclinazione, senza ‘felicità forzata’. Ognuno poteva sce gliere il proprio modello abitativo e di vita, creando un grande laboratorio sociale diversificato. E questo possibilmente in una piccola o media città dove la gente si conosce, per poter pian





piano coinvolgere la cittadinanza e ‘contaminarla’, con l’esempio, con il successo e con la qualità della vita e non con costrutti ideologici. Cosa che avrebbe potuto giovare al ‘marchio’ anarchico» (Stowasser 2005).
L’idea era ambiziosa e fu sperimentata in tre città diverse. Ebbe un certo sviluppo però solo a Neustadt, che divenne presto, integrando la Wespe e mantenendo questo nome, un modello vivente del Projekt A. E Horst Stowasser si trasferì lì a vivere.
Nei suoi migliori anni (i primi anni Novanta) la Wespe contava 12 imprese collettive autogestite
Nei suoi migliori anni (i primi anni Novanta) la Wespe contava 12 imprese collettive autogestite (tra cui un negozio di materiali ecologici da costruzione, una falegnameria, l’officina delle biciclette, la libreria, la bottega di prodotti alimentari biologici, un laboratorio di analisi biologiche, una ditta di impianti elettrici che
costruì il primo pannello solare in città) e l’Ökohof, un terreno in centro città che ospitava una ex fabbrica di mobili, acquistato collettivamente e sottratto agli interessi della speculazione del mercato. L’Ökohof doveva diventare (e in parte lo fece) il cuore del progetto, con spazi abitativi condivisi, una struttura ricettiva per gli ospiti con un caffè culturale, una sala per concerti, incontri, riunioni. C’erano pubblicazioni interne, per condividere temi, discussioni e decisioni e bollettini esterni, che si rivolgevano alla cittadinanza di Neustadt.
La Wespe, per come la conobbi io, fu un’esperienza comunitario-cooperativa che coinvolse, con diverse gradazioni, un centinaio di persone. Non una microcomunità di «alternativi», chiusi nel bozzolo della loro diversità: quella che si sviluppò a Neustadt fu un’esperienza di segno libertario ed ecologista radicata e proiettata nella società circostante.
Scrivevo allora: «Mi sorprendono l’impeccabile organizzazione e la ’lussuosità’ di certe imprese: strutture e macchinari moderni ed efficienti, locali spaziosi e ben tenuti, vetrine invitanti […]. In tal modo WESPE allunga i suoi tentacoli, si fa conoscere, propaganda la propria esistenza e le proprie istanze, coinvolge, offre servizi […]. Non meno importanti dal punto di vista ‘socializzante’ sono gli incontri collettivi: le feste. Ciò che non manca, ci confessa Horst, è lo spirito festaiolo e goliardico e ogni occasione è buona per festeggiare, commemorare, inaugurare. Come dicevo la funzione di
Ciò che non manca, ci confessa Horst, è lo spirito festaiolo e goliardico e ogni occasione è buona per festeggiare, commemorare, inaugurare
questa componente non è soltanto quella evasiva (fondamentale comunque in ogni progetto di vita): le feste diventano luogo di incontro, scambio, conoscenza, discussioni, consolidamento dei rapporti… sia tra i componenti stessi della WESPE, sia tra loro e gli ‘avventori’ esterni» (Bertolo 1992).
Dopo pochi anni, però, quella che sembrava la realizzazione di una utopia concreta in qualche modo fallì e si sfaldò. La causa scatenante pare fu un conflitto molto acceso all’interno del collettivo, che seguì l’organizzazione di un concerto di un gruppo musicale famoso, il cui cantante era stato accusato di violenze su una donna. Una parte del gruppo non voleva in nessun modo ospitare il gruppo e così, dopo il concerto, ci fu una pesante spaccatura che non si rimarginò più.
Ma le vere cause si erano lentamente annidiate in seno al progetto da tempo, sempre secondo Horst: «Probabilmente furono due soprattutto le cause del fallimento: la prima, più esterna, fu dovuta al fatto che il progetto era cominciato negli anni Ottanta, proprio nel periodo in cui il movimento alternativo tedesco si stava ritirando. Abbiamo cominciato in controtendenza ed era difficile trovare dei proseliti. Le persone non erano più molto interessate alle pratiche di autogestione, per loro era troppo faticoso. Miravano al posto fisso e al salario garantito. La libertà richiede invece molto impegno.
Il secondo motivo, a mio avviso, ben più imbarazzante, riguarda il fatto che quando il progetto iniziò a godere di un certo successo, arrivarono i ‘puritani’ in massa, i seguaci della dottri-




na pura. Criticarono il progetto dall’inizio alla fine, perché per loro non era abbastanza radicale o sufficientemente anarchico. Era troppo borghese, non abbastanza rivoluzionario. E rimasero finché non rovinarono tutto, potendo finalmente avere ragione» (Stowasser 2005).
Conversando con i nostri ospiti viene fuori un’immagine molto complessa di quello che può essere stato questo esperimento politico e sociale e anche dei motivi per cui non ha funzionato o ha funzionato in parte. Ede, che c’era fin dall’inizio, ne parla con affetto e nostalgia, per lui è stata l’occasione di sperimentare un’utopia, di rendere concreti degli ideali, ma ricorda anche la fatica, la difficoltà di tenere insieme le varie visioni, di coniugare vita privata e vita collettiva, di lavorare tantissimo per far funzionare i progetti e le imprese e trovare anche il tempo per riunioni, discussioni e decisioni collettive.
Michael, invece, durante gli «anni d’oro» della Wespe non aveva avuto il desiderio di partecipare, non si sentiva in linea con certe durezze o estremismi, però in un secondo momento ha voluto raccogliere il testimone di quell’esperienza e ne ha capito le potenzialità. Ora si occupa dell’Anarchiv.
E oggi cosa rimane?
Oggi la Wespe esiste ancora soltanto nella forma di una associazione che conta una ventina scarsa di associati e che amministra l’Ökohof e una associazione culturale, la «Wespennest» (nido di vespe), che organizza eventi culturali.
I due negozi citati all’inizio, la libreria e l’alimentari biologico, esistono ancora come realtà attive e conosciute in città, con una gestione non gerarchica a livello della dirigenza, ma con dipendenti stipendiati. Non fanno più parte di un progetto politico più grande e collettivo, ma rimane ugualmente forte la connessione, la rete sociale e umana di persone che si conoscono da una vita, che hanno lottato insieme per costruire qualcosa di diverso, che si aiutano e si sostengono se necessario.
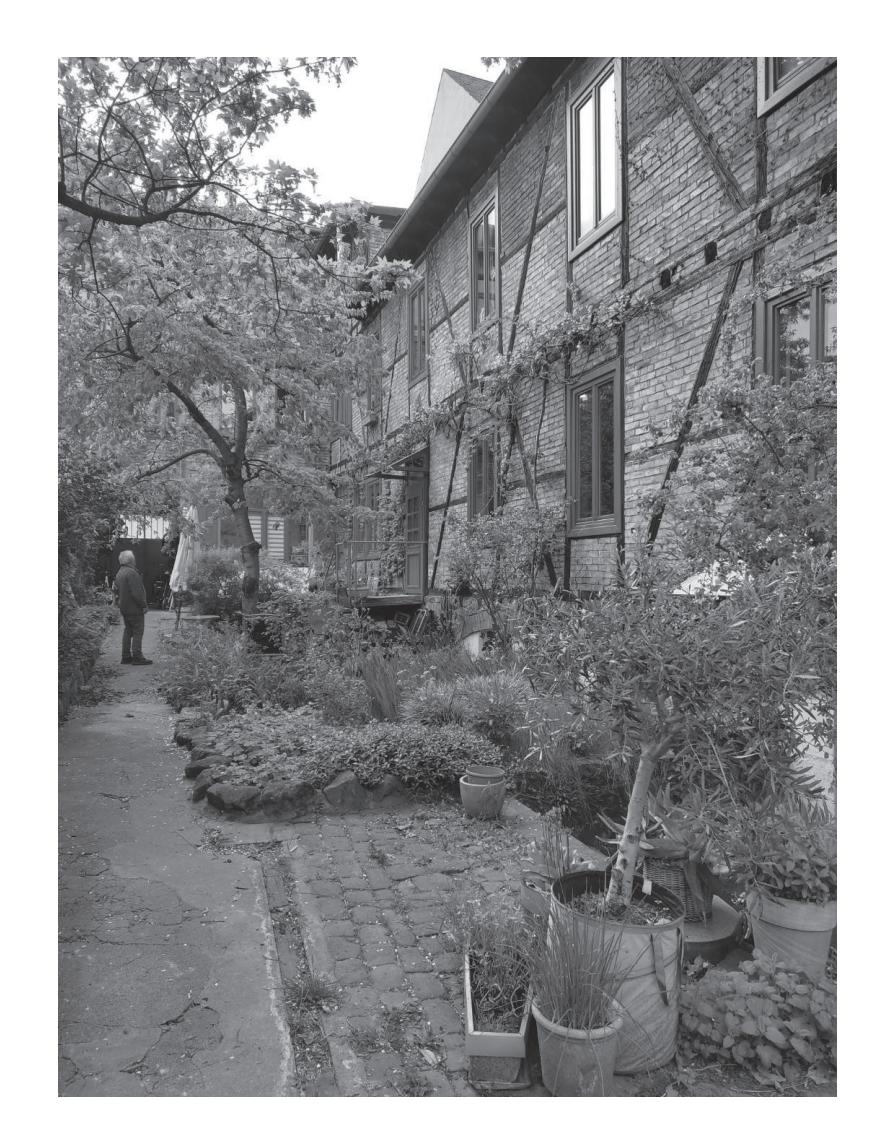
Sembra molto poco, ma Ede e Michael non nascondono un certo orgoglio nell’affermare: «troviamo già ambizioso tentare di preservare questo spazio fuori dal mercato. Un terreno con un immobile in una posizione così centrale troverebbe subito un investitore. Vorremmo mantenere questo luogo come luogo di incontro, di



cultura, in cui non vi siano strutture gerarchiche, sarebbe già tanto riuscire a farlo. Ed è anche molto bello, è un’oasi in centro città. In genere ciò che è bello appartiene a qualcuno che ha tanti soldi. Che possano essere ancora accessibili gli spazi belli nelle città è ormai qualcosa di esotico. Questo progetto ha potuto sopravvivere solo grazie al fatto che l’associazione aveva a suo tempo acquistato il terreno e così abbiamo potuto salvarlo dal capitalismo, ossia che diventasse terreno per centri commerciali o parcheggi».
Ormai anche il bilancio economico della amministrazione dell’Ökohof è in attivo, sono state pagate le ultime rate di mutuo e si può pensare di investire in qualcosa di nuovo.
Questo progetto ha potuto sopravvivere solo grazie al fatto che l’associazione aveva a suo tempo acquistato il terreno e così abbiamo potuto salvarlo dal capitalismo
Questo è quanto rimane oggi della Wespe e a me rimane la dolcezza, la generosità e la simpatia di due persone che non si sono mai fermate nonostante gli insuccessi, che continuano a farsi domande sulla vita e su come possa essere possibile renderla degna di essere vissuta.
Mi rimane anche la certezza che non esiste IL progetto ideale, quello che una volta applicato funzio-
nerà perché è impeccabile. La tensione utopica anarchica deve rimanere un’idea a cui puntare, un’idea che pervade progetti e tentativi, un’idea che bisogna «sporcare» con le difficoltà, gli imprevisti, la complessità delle relazioni e dell’umano e le sfide dei cambiamenti storici, sociali e ambientali.
Me ne vado da Neustadt con la voglia di tornare e con la sensazione che qualcosa rinascerà, i semi sono stati a lungo quiescenti e ora sta arrivando il loro momento di germinare di nuovo.
«Dopo tanti anni finalmente abbiamo indetto un’assemblea straordinaria, un’assemblea in cui vogliamo occuparci in modo approfondito del futuro, di chi verrà dopo», dice Ede. Lo vedo pedalare verso casa col suo carretto rosso e nero e corro in stazione per non perdere il treno.

AnArchiv
L’Anarchiv è un archivio anarchico, come si può capire già dal nome: una biblioteca molto grande con monografie e libri, una raccolta anche di prodotti di varia natura, come volantini, resoconti di discussioni, adesivi, poster, film, musica e riviste. Il grosso è costituito da pubblicazioni anarchiche in lingua tedesca, ma si trovano anche libri provenienti da tutte le parti del mondo, tra cui anche esemplari molto rari e preziosi, reperti storici unici.


16 17
L’Anarchiv attira persone e gruppi che cercano contatti o che vogliono imparare dalle esperienze del passato o che vogliono mettersi in rete con altre realtà. Molti usano l’archivio per le loro ricerche, per pubblicazioni, tesi e dottorati.
È una vera e propria memoria del movimento anarchico, dal momento che l’anarchismo normalmente non trova spazio nel racconto storico ufficiale e questo tesoro di esperienze andrebbe perso se non ci fossero questi archivi (Stowasser 2005).
L’Anarchiv è un centro di documentazione fondato nel 1971 da Horst Stowasser e curato da lui fino alla sua morte. È tutt’ora attivo ed è aperto al pubblico.
Per contatti: info@anarchiv.de
Bibliografia
A. BERTOLO, «A Rivista Anarchica» n. 189, marzo 1992 «Das Projekt A», Horst-Stowasser-Institut e.V., Verlag Edition AV, 2019 H. STOWASSER, intrevista su «Graswurzel Revolution», dicembre 2005

Lo Spaccio popolare autogestito di Bologna Espe
A. Soto e Unghia
Il Gruppo informale di acquisto zapatista
Lo Spaccio popolare autogestito di Bologna è una delle attività svolte dal «Giaz», ovvero il Gruppo informale di acquisto zapatista. Vediamo quindi innanzitutto quale è stata la sua formazione e quali sono le sue caratteristiche.
Il «Giaz» si è costituito diversi anni fa ed è nato dalla scissione di un gruppo di compagne che formava il sottogruppo dello spazio sociale «Vag61» all’interno del «Gasbo», il Gruppo d’acquisto solidale di Bologna, per differenze di vedute sul senso della propria attività e della direzione che essa doveva assumere.
Un punto cruciale era il rapporto con i fornitori. Innanzitutto non erano condivisi i criteri con cui venivano scelti. Coloro i quali avrebbero poi formato il «Giaz» criticavano il fatto che il «Gasbo» decidesse di servirsi di un produttore solo sulla base di tre fattori: la comodità (cioè il fatto che il produttore fosse a km0), il biologico (cioè che il produttore avesse una certificazione biologica), gli sconti (ovvero la possibilità di spuntare un prezzo più basso lavorando sui grandi numeri), dando altresì valore al lavoro del produttore. Così si mette a critica la formazione del prezzo di un bene agroalimentare e/o di un trasformato, ben consci del fatto che solo un’alleanza tra chi produce e chi co-produce può portare a un prezzo equo. In questo modo si possono rendere partecipi anche le fasce di popolazione a basso reddito. Le «giazziste» sostenevano invece che fosse importante anche un altro fattore, cioè quello umano, relazionale, tra produttore e consumatore. Anzi, enfatizzando la necessità di una relazione più stretta, fu avanzata la proposta di sostituire a «consumatore»




il termine «coproduttore» come già avveniva all’interno dei mercati dell’associazione «Campi Aperti» (associazione che sostiene l’agricoltura biologica e locale, le cui origini risalgono alla fine degli anni Novanta e che è oggi molto radicata in città), luoghi in cui le «giazziste» ancor oggi amano incontrarsi.
Insomma il «Gasbo» viaggiava col pilota automatico, era efficiente, ma individuava i produttori in maniera un poco superficiale e non coglieva le contraddizioni dell’economia solidale che stava diventando un’economia di nicchia. Nella Mailing List di «Gasbo» passava un po’ di tutto, tra cui suggestioni, articoli, pensieri anche critici sulla realtà intorno a noi, ma il confronto e il dibattito all’interno di un mondo virtuale già faceva intravedere le sue criticità. Il palesarsi della possibilità di percorrere strade altre non da soli, ma con un gruppo di compagne che condividevano valori e sogni, ha portato al costituirsi del «Giaz», in cui il termine zapatista
indica una necessità di condivisione paritaria e di ricerca di senso di comunità e, soprattutto, il mettere le persone davanti ai soldi. Era il 2014. Così è nata una cosa bellissima, qualcosa di più di un gruppo d’acquisto, un’amicizia tra compagne che è durata e si è rafforzata nel tempo ed è oggi forte e attiva.
Così è nata una cosa bellissima, qualcosa di più di un gruppo d’acquisto, un’amicizia tra compagne che è durata e si è rafforzata nel tempo ed è oggi forte e attiva
Dal Giaz allo Spa: lo Spaccio popolare autogestito
Da questa esperienza nel 2016 nasce lo «Spa», cioè lo Spaccio popolare autogestito, esperienza che rimane strettamente collegata al «Giaz». Lo «Spa» è innanzitutto un luogo fisico, ospitato una volta a settimana nei locali del circolo anarchico Berneri, dove relazionarsi, condividere saperi e pensieri, in cui vi è un dibattito vero, non solo via web. Si organizza attraverso assemblee mensili che utilizzano il metodo del consenso; viene proposto un ordine del giorno condiviso, la riunione è anche un bel momento conviviale, si mangia insieme, si beve insieme, non ci sono tempistiche troppo rigide.
Lo «Spa» ha scelto di fare quel che, secondo i suoi fondatori, doveva fare un gruppo d’acquisto diverso dal normale, cioè non solo acquistare un prodotto e distribuirlo senza rincaro, ma anche aggiungervi un ragionamento e una conseguente pratica critica degli involucri e degli imballaggi (cioè fare a meno di ogni forma di packaging) e una riflessione sul concetto di prossimità. Pur continuando a ritenere importante la questione del km0, ovvero la prossimità geografica del produttore o trasformatore dell’alimento, a questo si affianca un altro criterio: quello dell’affinità ideale e pratica, cioè il cercare di creare una condivisione politica di quanto si va facendo.
Il lavoro che lo «Spa» fa sul costo è il seguente: provare a far pensare alle persone che vengono allo Spaccio quanto tempo sia stato dedicato al prodotto che sta sul banchetto e, di conseguenza, da un punto di vista economico, quale sia il prezzo di vendita sostenibile per chi produce. Ci spieghiamo: se per





raccogliere 100 kg di zucchine un agricoltore impiega otto ore, non può essere che le zucchine costino al consumatore 50 cents o 1 euro al chilo, che è il prezzo che la grande distribuzione organizzata impone al produttore quando costui decide, o è costretto, a «collaborare» con essa, cioè ad andare negli scaffali del supermercato.
Lo «Spa» lavora in maniera differente rispetto alla grande distribuzione. Non impone, né propone, i prezzi di vendita, è il produttore che decide quanto far pagare: il rapporto di fiducia tra produttore e «Spa» è fondamentale. Fa così perché ha via via assunto consapevolezza di come funziona una azienda agricola, e del lavoro – inteso in senso lato – che vi è dietro ogni prodotto. Dietro un prezzo c’è tutto un mondo di rapporti sociali
Dietro un prezzo c’è tutto un mondo di rapporti sociali e umani, con l’ambiente e quindi di inquinamento o di rispetto della terra
e umani, con l’ambiente e quindi di inquinamento o di rispetto della terra. Bisogna scegliere se stare dalla parte dello 0,99 sempre e comunque, quando poi magari ci si trova immersi in una dinamica di consumismo che fa spendere un sacco di soldi, oppure se consumare meno e meglio, dando un alto valore al cibo e cioè a chi lo lavora e all’ambiente.
Per questo chi anima lo «Spa» va a conoscere, o a trovare, chi produce, a vedere coi propri occhi, a farsi raccontare le difficoltà che si incontrano se si fa la scelta di essere fornitore di un gruppo d’acquisto e non della grande distribuzione, se si decide quindi di lavorare con volumi di produzione più bassi ma che rispettano i cicli della terra e che richiedono cura, attenzione, dedizione. Questo è quel che vuol dire nella pratica sottoporre a critica il diktat della crescita economica e del profitto e privilegiare un ragionamento più complesso, che preveda tempi lunghi e che sia ecologico, cioè che pensi come prioritario il mantenimento della fertilità del suolo che le colture intensive e l’uso smodato della chimica tendono invece a impoverire.
Spesso si sostiene che il supermercato sia comodo, ed è per questo che abitualmente oggi, nelle nostre società, si va proprio al supermercato a fare la spesa. Ma cosa vuol dire «comodo»? Cioè cosa implica questa comodità per il consumatore? Orari lunghi o lunghissimi per chi vi lavora, magazzini aperti h24, camion che girano in lungo e in largo per l’Italia a ogni ora del giorno e della notte. In altri termini, il supposto risparmio di tempo e denaro per alcuni comporta tutta una serie di conseguenze negative sulla vita di molti altri.
Lo «Spa» vuole rendere più acuta la sensibilità riguardo al cibo, alla sua produzione, al suo costo. Ha fatto un tentativo di replicare questo discorso con l’artigianato, ma lì la sensibilità a riguardo è ancora troppo bassa e in troppi ci facciamo abbindolare da produttori che sono in grado di offrire un prodotto a prezzi bassi e per questo del tutto insostenibili da un punto di vista sociale e ambientale.





La logistica partecipata
Ad Anzola Emilia, vicino a Bologna, c’è il polo logistico della coop più grande dell’Emilia Romagna. Un luogo del tutto insostenibile, dal punto di vista ambientale, avendo cementificato ettari di terreno agricolo, e sociale, poiché produce sfruttamento bestiale, tanto che numerosi sono state e sono le lotte sindacali e gli scioperi in questo settore.
Ciò ha fatto scattare un campanello d’allarme in molti partecipanti allo «Spa», che hanno cominciato ad analizzare più da vicino la situazione. Capendo che la logistica è uno degli anelli deboli della grande distribuzione ed è luogo in cui ci sono le peggiori condizioni di lavoro, pressoché schiavistiche, con orari assurdi, carichi fuori da ogni regola. Si lavora tanto, in modo pesante e male. Chi organizza lo «Spa» non intendeva più alimentare questo meccanismo, voleva fare qualcosa oltre a supportare chi sul luogo di lavoro si organizza sindacalmente per rivendicare i propri diritti e la propria dignità. Dunque si sono chiesti se c’era la possibilità di autogestire anche la logistica, cioè di prendersi carico di un settore in cui lo sfruttamento bestiale è causa diretta del prezzo ridotto che troviamo nello scaffale del supermercato; di smettere cioè di alimentare l’idra capitalista, per dirla con gli zapatisti.
Si poneva anche il problema, basilare, di non far aumentare eccessivamente i costi di trasporto e quindi il prezzo del prodotto che arriva sul banchetto dello «Spa». Lo Spaccio popolare non ha prodotti di nicchia, non è non vuole essere una bottega del centro, ci viene gente che per la stragrande maggioranza vive con meno di 1200 euro al mese.
La risposta che si sono via via dati è che sì, ci si può autorganizzare anche nel campo della logistica. Inizialmente hanno utilizzato i viaggi che facevano i partecipanti al «Giaz», viaggi di lavoro in vari punti d’Italia, chiedendo di fare alcune deviazioni, di prendere dal produttore il carico che lo «Spa» aveva ordinato e di portarlo a Bologna.
Poi la logistica si è allargata e in un incontro di Genuino Clandestino – al cui interno quello della logistica è sempre stato in realtà argomento divisivo – gli organizzatori dello «Spa» hanno incontrato un compagno, Michele, agricoltore e produttore della Bergamasca che crede anch’egli nell’importanza di fare rete in modo da unire territori lontani e per chiudere quel cerchio che permetta di non andare più al supermercato per soddisfare le proprie esigenze alimentari.
Accanto a quelli, vicino allo «Spa», che andavano su e giù per l’Italia per lavoro, sono state organizzate quindi delle occasioni di autofinanziamento per dare vita a una cassa della logistica che andasse a pagare i costi vivi di chi, come Michele, si im-
I produttori che vengono allo «Spa» vendono quantità, più o meno grosse, dei loro prodotti, oppure barattano ciò che producono con ciò che c’è
pegnava ad andare a recuperare prodotti da diverse parti d’Italia. Poi, dal momento che ci sono rapporti stretti con diversi produttori, si è cominciato a invitarli allo «Spa» a portare, e presentare, i propri prodotti e a spiegare come lavorano. Questo ha permesso di rinsaldare legami, di crearne di nuovi e di far nascere la cambusa dello «Spa»: al momento arrivano prodotti dal nord e dal sud, dalla
Sicilia, dalla Calabria, dalla Campania, così come dalla Lombardia. I produttori che vengono allo «Spa» vendono quantità, più o meno grosse, dei loro prodotti, oppure barattano ciò che producono con ciò che c’è: ad esempio i produttori di «Ekidna» recentemente hanno barattato il loro olio extra vergine di oliva con riso, ceci, caffè di «Libertaria» e detersivi della «Viome», una realtà greca nata dall’occupazione di una fabbrica che i padroni volevano delocalizzare scappando anche con tutti i macchinari, ma di cui gli operai si sono reimpossessati. E così si crea rete.





I magazzini diffusi
Un altro aspetto curioso dello «Spa» è l’esistenza di magazzini diffusi. Cosa sono? Partiamo da due premesse: lo spazio, nei luoghi di socialità, è spesso un bene scarso. Per chi non ha denaro mancano spazi ordinati, puliti, abitabili. Questo vale anche per spazi dove stoccare il cibo.
Ecco quindi che gli organizzatori dello «Spa» hanno semplicemente messo a disposizione un po’ di spazio nelle proprie case, cantine o garages, creando così dei magazzini decentrati o diffusi. Basta un qualche scaffale in una dispensa o anche solo un ripiano del frigorifero per conservare dei pacchi di caffè o dei pezzi di parmigiano, ad esempio: uno spazio privato che conserva prodotti non privati. Con lo strumento informatico di un database condiviso (e non proprietario) ogni partecipante può sapere se e dove è conservato un determinato prodotto e farne richiesta. Dal punto di vista tecnico il funzionamento è legato alla mailing list: in ogni mail che gira nella lista dello «Spa» ci sono una serie di link a piè di pagina tra cui il collegamento al magazzino diffuso.

Il prefinanziamento
Lo «Spa» si è trovato da subito a fare i conti con la questione economica. Molto semplicemente il problema è questo: come avere una cambusa piena e un banchetto ricco di prodotti senza operare un ricarico di prezzo del singolo prodotto? E ancora: come fare questo pagando subito il produttore per gli alimenti che cede allo «Spa», senza farlo attendere che la sua merce sia comprata da qualche avventore dello
spaccio?
Una risposta è stata trovata nel prefinanziamento, ovvero un meccanismo di credito basato anch’esso sulla fiducia. Chi viene allo «Spa» può decidere di versare una quota a sua scelta, che poi viene scalata nei successivi acquisti. È diventata una pratica diffusa che funziona molto bene e che aiuta concretamente i produttori.
Un meccanismo di credito basato anch’esso sulla fiducia: chi viene allo «Spa» può decidere di versare una quota a sua scelta, che poi viene scalata nei successivi acquisti
Collaborazioni e ulteriori attività
Lo «Spa» collabora da circa un anno con «Arvaia», una cooperativa nel vero senso della parola, a cui i soci partecipano attivamente, la prima «CSA» (agricoltura sostenuta dalla comunità) in Italia. «Arvaia» fa una programmazione annuale delle colture e questa è una cosa importante, perché lo «Spa», oltre a essere diventato un punto di distribuzione di «Arvaia», ha a disposizione eccedenze di verdure che vengono utilizzate per cene condivise ma anche per essere gestite da un importante progetto di mutualismo nato nella primavera del 2020, in piena pandemia: la «Colonna solidale autogestita», che distribuisce gratuitamente beni di prima necessità, anche alimentari.



Un’ulteriore dinamica interna che merita un cenno è quella delle autoproduzioni, ovvero la trasformazione di prodotto agricoli che sono bei momenti di socialità e di convivialità e che aiutano tra l’altro a capire meglio il processo di formazione di un prezzo. Si potrebbe fare l’esempio della passata di pomodoro, la «Passamontagna», una tipica autoproduzione dello «Spa». Chi la fa, calcola che senza i costi del lavoro di trasformazione, costa il triplo di quello di un supermercato, pur riutilizzando tutte le bottiglie. Questo lavorando due quintali di pomodoro.
Ma oltre alla «mitica» «Passamontagna», allo «Spa» si trovano crauti, marmellate, cavolfiori sottaceto, marroni sotto grappa, crema di marroni al cacao, focacce, biscotti, distillati, ecc.
Una conclusione provvisoria
Tutto ciò per chi dà vita allo «Spa» è estremamente gratificante ma richiede fatica, tempo e soprattutto costanza nel tempo, il bene forse più prezioso, la cosa più difficile e importante
Tutto ciò per chi dà vita allo «Spa» è estremamente gratificante ma richiede fatica, tempo e soprattutto costanza nel tempo, il bene forse più prezioso, la cosa più difficile e importante. Questo perché se lo «Spa» smette di acquistare un prodotto rischia di mettere in crisi il produttore, che per la sua attività fa affidamento sugli acquisti costanti nel tempo. Un’altra difficoltà con la
quale i partecipanti si devono confrontare è quella di coinvolgere i ragazzi più giovani, che paiono a volte un po’ avulsi dalla comprensione dei meccanismi materiali del funzionamento dell’autorganizzazione. L’età delle persone più attive all’interno dello «Spa» supera i trenta anni, a volte anche di molto!
Al netto di ciò, l’attività dello «Spa» ci indica che non è la provvidenza, né lo Stato, né qualcuno di superiore ad aiutarci. Bisogna metterci del proprio per cambiare l’esistente. E si può cominciare da subito, qui e ora.
Un documento del «Giaz» Chi siamo?
Un Gruppo Informale di Acquisto Zapatista: facciamo ordini collettivi di prodotti, ma non siamo un «Gas».
L’insoddisfazione per ciò che già esiste ci spinge verso qualcos’altro, vogliamo portare le nostre scelte al di fuori dei limiti segnati dall’ordinario, perché: «cercando l’impossibile, l’uomo ha sempre realizzato e conosciuto il possibile, e coloro che si sono saggiamente limitati a ciò che sembrava possibile non sono mai avanzati di un sol passo».
Il diritto ai cibi e ai prodotti sani e ecologici per i ceti popolari è un progetto da concretizzare, non un enunciato di principio. La partecipazione reale di tutte, nei limiti e nelle forme che ognuna si riconosce, è un dato di fatto che non potrà essere messo in discussione.
Siamo aperte (non inclusive), siamo anticapitaliste, coscienti che il conflitto esiste (eccome) e che fino ad ora l’hanno praticato soprattutto le classi dominanti.
Il richiamo allo zapatismo nel nome che ci siamo date è per riportare all’immaginario quelle pratiche che in Chiapas hanno dimostrato che il capitalismo si può superare creando una Comunità che resiste, decide collettivamente, si autodetermina e autogestisce.
Il «Giaz» rifugge la massa che nega ogni conflitto e rifiuta l’abitudine! Non cerchiamo rassicurazione nel conformismo, combattiamo chi presidia la conservazione e non abbiamo paura del cambiamento. Cerchiamo un linguaggio nuovo, plastico, che sia in continua evoluzione perché il mercato ci ruba le parole, ma i principi sono e saranno sempre e solo Nostri.
Sappiamo che il nostro fine non è un capitalismo «buono», un sistema di dominio ammantato di finta economia sia essa «verde» o «etica». La grande ragnatela di internet diventa l’ambiente comune che costituisce l’insieme degli stimoli che riceviamo e sappiamo che stimoli simili portano a comportamenti simili, così come siamo consapevoli che il Web non è un luogo di libertà.




Privilegiamo il software libero ma ancor di più le relazioni umane perché capiamo ancora la differenza che intercorre tra «alimentare una popolazione» e «alimentare un computer».
Rifiutiamo le gerarchie, la ricerca del potere, teniamo assemblee formali ed informali in cui prendiamo decisioni in modo orizzontale, la consapevolezza e la conoscenza da parte di ognuna sono un elemento costitutivo e strutturale.
Perché lo facciamo?
La scommessa non è da poco: sostenere e piantare altri semi di piccole comunità post capitaliste. Amiamo aprire «crepe» in cui seminare il germe della solidarietà e del mutuo soccorso e contribuire al crollo del fortino degli sfruttatori.
L’utopia che coltiviamo è quella di un modello «altro» (il capitalismo non è l’unico sistema economico possibile) e il tentativo è gettare i semi per un futuro raccolto. Dopo un raccolto ne viene un altro.
Crediamo fermamente che gli zapatisti siano un esempio di popolo soggiogato, ma ricco di dignità, l’evidenza che un mondo diverso è possibile tanto in Chiapas quanto in pianura padana. Noi non costruiremo scuole o ospedali, certo, ma portiamo avanti lo Spaccio Popolare Autogestito al Circolo Anarchico Berneri «spacciando», senza ricarico, caffè scelto ed importato secondo reali criteri di solidarietà e sostegno alle comunità, torrefatto e distribuito da una realtà libertaria, zucchero sem terra, riso di un’azienda agricola a conduzione familiare delle campagne ferraresi, arance da realtà conflittuali siciliane e calabresi che rispettano terra e lavoratori uscendo dalle dinamiche di «sfruttamento criminale», passate di pomodoro (autoprodotte), pasta e saponi lavorati in fabbriche fallite, occupate e riavviate alla produzione dagli operai, e tanto altro ancora. Siamo in costante attenzione nella ricerca di nuove modalità e pratiche di gestione: dal progetto «magazzini diffusi», alla logistica partecipata favorendo costantemente socialità e condivisione.
Al fianco dei picchetti dei facchini, delle rivolte dei braccianti, dei presidi degli occupanti di case.
Al fianco degli oppressi e complici dei ribelli.
Al fianco dei giovani ai quali questa società non riserva futuro. Danzando, ridendo e deridendo il potere ma portando con noi anche la rabbia gioiosa degli ultimi.
Vogliamo rimboccarci le maniche, partecipando e proponendo in prima persona, senza deleghe e senza intermediazione. Perché è giusto e necessario provarci. «La vita è bella. Possano le generazioni future liberarla da ogni male, oppressione e violenza, e goderla in tutto il suo splendore».
Per saperne di più
https://we.riseup.net/giaz https://mastodon.bida.im/@spacciopopolareautogestito/ https://www.campiaperti.org https://www.arvaia.it/ https://colonnasolidale.org/ https://genuinoclandestino.it/






L’isola del tesoro.
Asnada - Scuola sperimentale di italiano L2 rivolta a stranieri, adolescenti e minori, rifugiati e richiedenti asilo, residenti a Milano
Maurizio Giannangeli
Il tesoro al centro dell’Isola
Al centro dell’«Isola», quartiere di Milano abitato un tempo da operai e artigiani, ora ricco di bar e locali alla moda non sempre economici, si trova la scuola «L’isola del tesoro», ospitata presso la sede della chiesa metodista di Milano, in via Luigi Porro Lambertenghi 28. Si tratta di una scuola rivolta a giovani migranti, di differente provenienza, minori non accompagnati e ricongiunti, richiedenti asilo, realizzata e sostenuta dall’associazione di promozione sociale «Asnada».
«Asnada» è un’associazione nata nell’ottobre del 2010, fondata da Sara Honegger, Valeria Ferloni, Federica Capobianco, Alexandra d’Onofrio e Margherita Trotta, che si occupa di «formazione per rifugiati, migranti, minori a Milano». Un progetto di scuola in cui migranti di varia nazionalità possono «prendere parola e partecipare così direttamente alla costruzione di un nuovo immaginario della migrazione e del radicamento». «Asnada» opera nell’ambito della «ricerca pedagogica sui gruppi eterogenei e sull’insegnamento della lingua quale strumento di pensiero collettivo, conflittuale, libero». «Attraverso scuole di lingua e azioni territoriali costruite insieme alle persone di origine straniera, operiamo per mettere al centro del nostro lavoro educativo e sociale una domanda di ricerca: come si fa a stare assieme avendo cura delle reciproche diversità?» (http://www.asnada.it).

«L’isola del tesoro» è una di quelle esperienze, promosse e realizzate da «Asnada», dove vengono messe in pratica le «strategie operative» consolidate nel tempo dall’associazione: «la costruzione di contesti di gruppo; la cura non assistenziale; la dimensione artigianale; l’individuazione di domande di ricerca e di obiettivi comuni; il sostegno a figure ponte, capaci di trasgredire
Si tratta di ragazzi/e che risiedono in zone dell’area metropolitana molto distanti; in questo modo il gruppo di adolescenti stranieri risulta diversificato e privo di sottogruppi preesistenti
l’appartenenza etnico-culturale; l’importanza delle lingue madri; la presa di parola pubblica».
Le esperienze di Maria Montessori, le tradizioni dell’attivismo pedagogico e della cooperazione educativa, a partire da Célestin Freinet, ne informano lo spirito, ma «L’isola
del tesoro» costruisce giorno per giorno il proprio procedere in modo sperimentale e fallibilista, con alcuni punti fermi frutto della propria esperienza e di alcuni dati di realtà, i quali, come vedremo, sono anche motivo di criticità.
L’associazione «Asnada» ha comunicato l’esistenza della propria offerta e del proprio progetto sia alle diverse comunità che sul territorio accolgono stranieri minori e adolescenti richiedenti asilo, sia al Comune di Milano, partecipando anche alla Rete cittadina per l’integrazione. Grazie a questi contatti ogni anno a settembre giungono le richieste di iscrizione che la scuola accoglie, sino a un massimo di trenta. Generalmente non accetta più di due o tre ragazzi/e da ogni singola comunità e/o famiglie. Si tratta di ragazzi/e che risiedono in zone dell’area metropolitana molto distanti; in questo modo il gruppo di adolescenti stranieri risulta diversificato e privo di sottogruppi preesistenti. I partecipanti frequentano la scuola per tre ore, dalle tre alle sei, tre pomeriggi a settimana, martedì, mercoledì e giovedì, da ottobre a maggio.


Le maestre e il lavoro di gruppo
Attualmente il gruppo de «L’isola del tesoro» è formato da quattro «maestre», come loro stesse amano nominarsi - Maria Boli, Anna Mandelli, Ilaria Negri e Gaia Rossi - e da circa trenta adolescenti di diversa provenienza. Ogni anno la composizione del gruppo è diversa, a causa del mutare dei flussi migratori e delle politiche sociali per l’integrazione e l’accoglienza di governi e amministrazioni.
Nella scuola per stranieri di «Asnada» varie equipe hanno dato vita a esperienze differenti, ma la centralità del lavoro di gruppo delle maestre, fondato sulla responsabilità nella proposizione e conduzione delle attività e sulla capacità di ascolto di ciò che portano a scuola i minori migranti, è rimasto invariato.
Le attività sono definite dall’equipe delle maestre e nascono sempre dall’attenta osservazione dei bisogni, delle difficoltà e resistenze che il gruppo esprime. È contemplata la possibilità di cambiamenti di rotta e i fallimenti sono esperienza da cui ripartire con rinnovate proposte. Ne è testimonianza il fatto che le attività non sono le stesse ogni giorno. I giorni non si ripetono con una scansione oraria di attività sempre uguali a se stesse, ma variano a seconda di ciò che l’equipe delle maestre ha osservato e il gruppo ha di volta in volta vissuto.
«L’isola del tesoro» non ha libri di testo e non è improntata a una visione pedagogica univoca. Si tratta semmai di costruire insieme, nel lavoro di equipe, una visione pedagogica mobile; a partire da come si osservano i comportamenti di ragazzi e ragazze, da come ci si dispone a parlare di loro e con loro, privilegiando uno sguardo attento a quanto nel gruppo ciascun adolescente porti proprie sensibilità, abilità e capacità già in atto. Ogni giorno l’equipe delle maestre si mette alla prova e, a seconda delle caratteristiche e particolarità del gruppo che si è formato quell’anno, assume la responsabilità di avanzare proposte di lavoro plausibili e interessati. L’obiettivo è quello di costruire insieme senso e pratica di una lingua comune.
Materiali come strumenti di negoziazione
Importante è anche il rapporto che esiste tra l’organizzazione delle attività e l’atteggiamento delle maestre nel proporla e condurla. La cura dell’equipe non è rivolta direttamente ai ragazzi e alle ragazze, ma si tratta piuttosto di una cura mediata. Le maestre non si dispongono in una posa diretta, materna, accudente, e nemmeno di inchiesta su fatti e circostanze personali. Evitano la relazione a due, di fatto sbilanciata, che si traduce quasi sempre nell’adulto che pone domande costringendo l’adolescente all’obbligo di una risposta più o meno imbarazzata. Per evitare simili squilibri, le maestre costruiscono il rapporto con ragazzi e ragazze attraverso la mediazione di «strumenti di negoziazione», di «materiali linguistici», progettati, preparati e disponibili, tra loro, sul tavolo. Oggetti, anche fisici, che possono essere occasione di esercizio e di uno studio che promuove la presa di parola autonoma.
Una particolare relazione educativa e di apprendimento
Al fine di disporre al meglio di strumenti e materiali, le maestre predispongono una struttura e un’organizzazione delle attività, sorta di «contratti sociali», all’interno dei quali, ragazze e ragazzi, possono trovare spazi di autonomia, di scelta e di li-
L’obiettivo è anche quello di sottrarsi a un insegnamento che «oscilla tra una problematica delle relazioni intersoggettive e una problematica dei contenuti oggettivi»
bertà di parola orientati al loro obiettivo: imparare la lingua italiana. L’obiettivo è anche quello di sottrarsi a un insegnamento che «oscilla tra una problematica delle relazioni intersoggettive e una problematica dei contenuti oggettivi» (De Certau 2007), ossia a quanto invece comunemente accade nei contesti di educazione e apprendimento che privilegiano la trasmissione dei contenuti e il giudizio sulla persona e non l’apprendimento attivo e incidentale.




Le maestre impiegano molto tempo nel decidere tempi e luoghi, come disporre i tavoli, le sedie, come organizzare il tavolo dei materiali. Ogni cassettino ha un nome, in modo che gli studenti e le studentesse possano prendere ciò che occorre e siano autonomi nell’accedere ai materiali e nell’utilizzarli. Grazie alla pubblicazione di un tabellone, ognuno/a è consapevole di quello che succede a scuola, quali sono le attività previste per quel giorno, quali i tempi, quale la distribuzione dei compiti.
Questa organizzazione aiuta le maestre a liberarsi dalla loro possibile conduzione carismatica, o dispotica, o materna, o direttiva, o dolce. Questa struttura, all’interno della quale anche le maestre sono tenute ai vincoli proposti e concordati, le libera da gran parte del potere che comunque esercitano e consente invece al potere di circolare. In questo modo si costruisce, con un movimento anche molto lento, una presenza del gruppo degli adolescenti stranieri che, con sempre maggiore consapevolezza e conoscenza del posto, dei tempi, delle attività da svolgere, come di alcuni obblighi (puntualità, mettere da parte il telefono, pulire i bagni, ecc.), si muove pian piano nella scuola non come gruppo di ospiti o clienti ma come partecipanti, come letteralmente «facenti parte».

Si tratta, probabilmente, di «riesumare dal sapere acquisito i processi reali che lo producono» e di attivare, socializzandolo subito, il sapere che si sta acquisendo in modo collettivo. Si tratta, probabilmente, di «promuovere nella scuola una gestione della socialità» e una presenza attiva dei soggetti coinvolti, grazie a cui «si sperimentano, per prove e errori, le forme oggettive e regolate che possono caratterizzare modalità di sapere alternative. Tali maniere di fare sono degli operatori di società. La producono. Non si tratta più qui di esprimere delle soggettività, ma di intraprendere lavori pratici di socialità» (De Certau 2007). In questo modo, ognuno/a ha libertà di muoversi e di esprimersi entro una cornice di regole condivise, con l’obiettivo specifico dell’appropriazione di competenze linguistiche di una lingua straniera, l’italiano, che lentamente si fa lingua comune.
In concreto: tempi, spazi, risorse, alcune criticità
«Ci vorrebbe più tempo».
Se è vero quanto detto sin qui, va anche detto che, in questa esperienza di scuola dove ne va di un processo di appropriazione che sia di pari passo della lingua e di se stessi/e, singolarmente e come pluralità, il tempo è questione decisiva in relazione agli esiti, sia per quanto riguarda il lavoro delle equipe delle maestre, sia per quanto riguarda la relazione nell’attività con i migranti. «L’isola del tesoro» si apre ai ragazzi e alle ragazze straniere martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio. Anna, Ilaria, Gaia e Maria dedicano il martedì mattina alla definizione della programmazione settimanale, e ogni martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio giungono a scuola almeno un’ora prima dell’arrivo dei migranti per predisporre arredi e materiali. Devono allestire lo spazio, costruire materiali specifici per le attività proposte che, come detto, sono ogni volta differenti; aprire dieci tavoli, spostare trenta sedie, quattro lavagne. Il tempo dedicato alla preparazione non è ancora, a detta loro, quello che dovrebbe essere per essere adeguato. Facendo i conti oscilla tra le quattro e le sei ore, tra programmazione didattica e allestimento, per complessive nove ore di lezione a settimana.




«In una scuola senza libri di testo le pareti sono il nostro libro». Anche lo spazio non è adeguato. Non tanto per l’ampiezza del salone, quanto perché, essendo ospiti, la possibilità di avere sempre materiali e arredi disponibili, spazi differenziati e diversamente attrezzati per varie attività pratiche che si vorrebbero anche «lavorative»; pareti tappezzate di cartelloni che indicano e riportano quanto c’è da fare o è stato fatto, anche banalmente alcune regole grammaticali, non è di fatto possibile.
La scuola dovrebbe potersi riempire del proprio operare, e il permanere di cose, oggetti, parole, memoria, è importante e utile alla costruzione di quel senso di appropriazione di lingua, di spazio e di sé, di cui si diceva. Riporre ogni giorno negli armadi quanto esercitato e prodotto non è tanto, o non solo, fatica e sottrazione di tempo - anch’esso esercizio di socialità - quanto è a rischio di oblio. Le maestre propongono e insieme ai ragazzi producono tantissimi materiali che restano poi stipati negli armadi. In questo modo la fatica vera diviene anche quella di valorizzare tutti gli apprendimenti e le scoperte fatte per sottrarle al loro definitivo svanire, fisicamente, negli armadi, nell’archivio.
«Asnada si iscrive a bandi e raccoglie fondi».
Le criticità di tempo e di spazio appena descritte, compresa quella di essere da sempre ospiti di altre realtà, probabilmente nascono dal fatto che le risorse sono poche e sono reperite attraverso bandi differenti, sia pubblici (statali e regionali), sia privati (fondazioni e altro). A seconda dell’entità dei fondi raccolti le maestre definiscono tempi e modi del proprio operare; quante ore a settimana potranno dedicare al loro lavo-
A seconda dell’entità dei fondi raccolti le maestre definiscono tempi e modi del proprio operare
ro di progettazione delle attività e come queste potranno essere concretamente realizzate con ragazzi e ragazze – per i/ le quali non vi è alcun onere economico - pattuendo con l’associazione «Asnada» il proprio impegno. Stante un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, sino a oggi le attuali maestre hanno definito l’offerta della scuola tenendo anche conto, alle condizioni date, della loro necessità di svolgere altri lavori: Anna lavora come educatrice in una scuola di Stato; Maria lavora in una scuola superiore di primo grado, studia ed è impegnata anche in altri progetti; anche Gaia ha un altro lavoro.
Per la costruzione di una lingua comune ogni giorno è un giorno diverso
Un cartoncino nero riporta le attività proposte per la giornata. Sul cartoncino delle targhette bianche rimovibili indicano quello che accadrà con indicato anche il tempo destinato a ciascun momento: arrivo; cerchio; laboratori; pausa; cerchio; saluti. Questa scansione non è la scansione di una giornata tipo, non esistono giornate tipo. Il tabellone indica proprio quel che dovrebbe accadere quel determinato giorno.




Si persegue un’educazione integrale, legata a un fare operativo e pratico, a attività lavorative in senso lato
Il giorno dopo, sul medesimo cartoncino, potranno essere presenti proposte del tutto differenti: uscite dedicate alla realizzazione di interviste; laboratori di falegnameria o di altro genere, perché si persegue un’educazione integrale, legata a un fare operativo e pratico, a attività lavorative in senso lato; attività in
piccoli gruppi omogenei, per livello, al fine di conseguire specifici obiettivi di apprendimento linguistico; attività in gruppo misto che favoriscano il mutuo aiuto; lezioni di grammatica della lingua italiana, utilizzando anche gli «strumenti» Montessori.
I laboratori di scrittura
I «laboratori» sono il cuore delle attività della scuola e nascono ogni volta da tracce di scrittura differenti. Un giorno la traccia è stata: «Cosa c’è, cosa voglio». La proposta: realizzare una sorta di autoritratto, prendendo spunto dalla canzone «Quello che non ho» di Fabrizio De André.
Con un pennarello indelebile ragazzi e ragazze ricalcano da una foto i lineamenti e i tratti principali del proprio volto, aggiungendo a esso, sollecitati dalla discussione e comprensione della traccia, i disegni di oggetti, animali, luoghi, quel che viene in mente.
Si scopre così «che lavorando con dei materiali e con le mani, sollecitati/e da uno spunto stimolante, si riesce a produrre un testo prima ancora di preoccuparsi di doverlo spiegare». «Dalle mani emergono pensieri, idee, cose che non si sapeva nemmeno di avere» e la parola circola più liberamente. Da quel disegno poi si costruiscono collettivamente delle micro narrazioni.
Così Jahid ha disegnato sul suo volto un orologio, delle forbici e un uccello e ha scritto: «Nella mia vita c’è l’orologio perché il tempo è importante, mi piacciono le forbici perché taglia tutto, c’è l’uccello perché mi piace guardarli bene».
Nei laboratori di solito si lavora per gruppi eterogenei dove i livelli di capacità linguistica si mischiano. Si promuove il mutuo aiuto e, attraverso scambi orizzontali diretti, mentre la lingua italiana circola nascono amicizie, complicità, collaborazioni. Un altro esempio di traccia di scrittura: «Una volta che hai perso qualcosa». Gli spunti offrono sempre una ampia gamma di possibilità. C’è chi racconta che ha perso l’autobus, e altri/e che hanno perso la madre. I
Nei laboratori di solito si lavora per gruppi eterogenei dove i livelli di capacità linguistica si mischiano. Si promuove il mutuo aiuto e, attraverso scambi orizzontali diretti, mentre la lingua italiana circola nascono amicizie, complicità, collaborazioni
diversi micro racconti, composti di poche parole, sono accolti e valorizzati alla pari, non giudicati migliori o peggiori per quanto raccontano. Così, insieme, si costruisce la «Lingua comune» con quello che ciascuno/a porta. Da chi ha detto «l’autobus» si prenderà e scriverà la parola autobus, e quella parola, scritta, lavorata, ricopiata da tutti/e, diventerà una delle parole che il gruppo fa propria. Così, lentamente, «autobus», «perso», «mamma», «morta», le parole emerse nei micro racconti vengono riutilizzate negli esercizi e rimesse in circolo attraverso altri piccoli testi o immagini, o altri materiali, divenendo lingua del gruppo.
Altre volte i gruppi nei laboratori linguistici possono essere differenziati per livello: analfabeti, intermedi, avanzati.
Una volta è stata realizzata un’intervista a una ragazza italo-marocchina. La registrazione è stata sbobinata e, isolato un passaggio dove la ragazza diceva «Da sola ho imparato a fare le foto», le maestre hanno chiesto ai componenti dei diversi gruppi di scrivere che cosa, nella loro vita, avessero imparato a fare da soli/e. Anche nel gruppo di analfabeti nella loro lingua madre, che faticavano a scrivere i loro nomi, è successo che, vista insieme la traccia, osservati con calma i tempi verbali, utilizzato il tempo necessario per scrivere le parole che le venivano in mente, Nadar abbia scritto: «piccolina cestino somalia», con alcuni lievi errori di ortografia.





A quel punto Nadar, nell’oralità, ha restituito al gruppo quelle parole con una frase intera e, insieme al gruppo, la frase è stata scritta alla lavagna inserendo i pezzi mancanti.
Non avere un libro di testo è faticoso e impone alle maestre di trovare spunti di scrittura che siano interessanti e così aperti da rendere possibile, a ognuno/a, di entrare in quella traccia e lavorare in gruppo lasciandosi attraversare dalla lingua, chi più in profondità e chi meno, e andrà bene lo stesso.
Una scuola non funzionale
Tutto ciò conferma nelle maestre un convincimento. Spesso, per gli analfabeti, o per i livelli molto bassi di lingua, si tende a pensare che non possano occuparsi di cose interessanti o alte, in quanto «non hanno lingua». Eppure anch’essi sono portatori di esperienze e di vita. Si tratta solo di trovare delle piccole leve che aprano a delle mini narrazioni, anche veramente molto semplici e, passando dalla lingua che incarnano, parole e frasi si radicheranno con maggiore profondità.
Oltre a ciò, Maria, Anna, Ilaria e Gaia, non rinunciano a un’altra convinzione: «Lo studente è degno di arrivare a conoscere
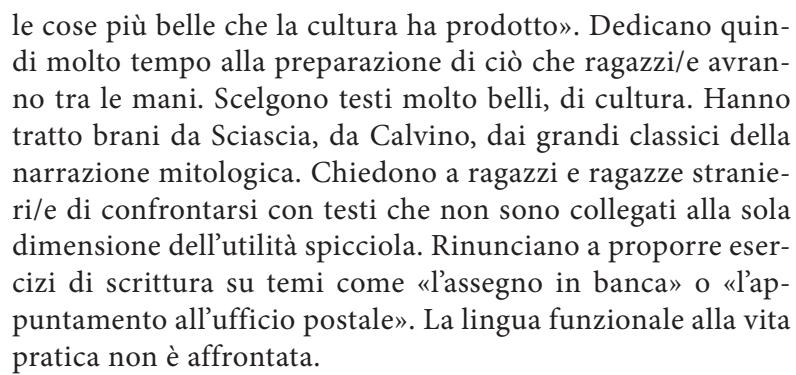
«L’isola del tesoro» non è una scuola funzionale alle certificazioni; rilascia un attestato di frequenza ma non una certificazione, che è quella che serve, che viene inserita nel curriculum. Non la rilascia
perché sono i CPIA (Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti) o altre strutture riconosciute che fanno i test e certificano il livello di competenza linguistica raggiunto. Il minore straniero frequenta quindi «L’isola del tesoro» come scuola di prima alfabetizzazione per poi andare ai CPIA, quando sarà in terza media, per fare l’esame che rilascia la certificazione.
«L’isola del tesoro» non è una scuola funzionale alle certificazioni; rilascia un attestato di frequenza ma non una certificazione, che è quella che serve, che viene inserita nel curriculum
Le parole del conflitto
Le tracce di scrittura spesso nascono dalla libera discussione tra gli stessi ragazzi e ragazze. Un tema che ha animato molto il gruppo nel cerchio è stato conflitto di genere nato dall’osservazione di alcuni ragazzi che «le femmine non possono tenere le gambe incrociate». Per di più, i maschi, si rifiutavano di lavare il bagno, perché lavoro che spetta alle femmine. Le maestre hanno allora proposto testi, documenti, foto e anche giochi legati al tema del lavoro sotto l’indice: «lavori da uomini», «lavori da donna».




Il laboratorio non mirava certo a convincerli o a indottrinarli, né a pacificare i conflitti, anzi, semmai a portarli in luce. Promuoveva momenti di parola in cui si apprende a stare tra persone che affermano pensieri diversi e contrapposti.
La presa di parola nel conflitto, in questo caso di genere, è divenuto l’obiettivo di mesi di lavoro. All’inizio è stato molto faticoso, poi, lentamente, i gruppi sono riusciti a sostenere dialoghi dove i componenti, pur esprimendo posizioni molto diverse, riuscivano a ascoltarsi e si sforzavano di trovare punti di mediazione. Nei fatti ora, anche i maschi puliscono il bagno quando è il loro turno e le ragazze continuano a incrociare liberamente le gambe.
Una scuola delle diversità - Prospettive
Il senso profondo di tutte le attività proposte nella scuola «L’isola del tesoro» è quello di far vivere ai giovani migranti l’esperienza di una «scuola delle diversità», nella quale costruire una lingua comune radicandola nelle coscienze di ognuno/a.
Una scuola che favorisce l’incontro e il confronto delle reciproche diversità, occasione dell’acquisizione di «strumenti necessari per la comprensione della cultura dell’altro e, di conseguenza, della propria». Le parole di Michel de Certeau, in questo caso, sono pertinenti: «L’esperienza di tale incontro [tra culture differenti ndr] è per noi prima di tutto una scuola della diversità, un’iniziazione a delle ’economie’ sociali di cui non coglieremo mai il segreto (sono estranee ai paradigmi che sono divenuti ufficialmente i nostri) e che nondimeno rivelano, nelle nostre società, aspetti di cui i nostri criteri decretano l’illegittimità» (De Certau 2007).
Diversi rapporti annuali di organismi che si occupano di flussi migratori tendono ad avvicinarsi alla inquietante proiezione di Norman Myers, dell’Università di Oxford (Brown 2008), che stimava la quantità di migranti ambientali nel 2050 intorno ai 200 milioni di persone (Legambiente 2021). Rispetto all’inevitabile aumento dei flussi migratori, anche «L’isola del tesoro», come molte scuole autogestite, rappresenta più che una speranza per un futuro migliore. Come scrive Jonathan Franzen, «ogni movimento verso una società più giusta e civile può essere considerato un’azione significativa per il clima» e un progetto di scuola come quello qui parzialmente descritto, ci «offre la speranza che il futuro, benché indubbiamente peggiore del presente, possa anche, in qualche modo, rivelarsi migliore. Soprattutto, […] dà speranza per l’oggi» (Franzen 2019). Di certo la società nel suo complesso dovrà inventare e costruire processi di sostegno concreto a quelle esperienze che si sforzano di costruire un nuovo e diverso patto sociale e dare così maggiore stabilità e continuità a processi reali di rinnovata convivenza civile. Un sostegno che non potrà che provenire dal basso, ossia da quegli stessi soggetti che di un nuovo e differente patto sociale sentono il desiderio e hanno necessità. Un patto più equo, capace di sovvertire l’immaginario sociale dominante e di instaurare un radicale processo di cambiamento della società, non più improntata al dominio e al profitto ma alla reciproca accoglienza, alla solidarietà e al mutuo aiuto, nell’ineludibile esercizio della costruzione di una casa e di una lingua comuni indispensabili al libero manifestarsi delle reciproche diversità.
Un sentito ringraziamento va a Maria Boli, Anna Mandelli, Ilaria Negri e Gaia Rossi, le «maestre», che si sono rese disponibili a un incontro di circa due ore. Ci hanno detto molto di più di quanto siamo qui riusciti a riportare. Ma, soprattutto, con la loro testimonianza hanno reso evidente che ognuno/a di noi può essere quel seme sotto la neve che può contribuire, al presente, a dare vita a relazioni sociali più solidali e giuste.
Bibliografia
F. BRANDONI (a cura di), I migranti ambientali. L’altra faccia della crisi climatica – Dossier 2021, Legambiente, 2021 (https://www.legambiente.it/ rapporti/i-migranti-ambientali-laltra-faccia-della-crisi-climatica/) O. BROWN, Migration and climate change, IOM, Ginevra 2008 M. DE CERTEAU, La presa di parola e altri scritti politici, Meltemi, Roma 2007 J. FRANZEN, E se smettessimo di fingere? Ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica, Einaudi, Torino 2019


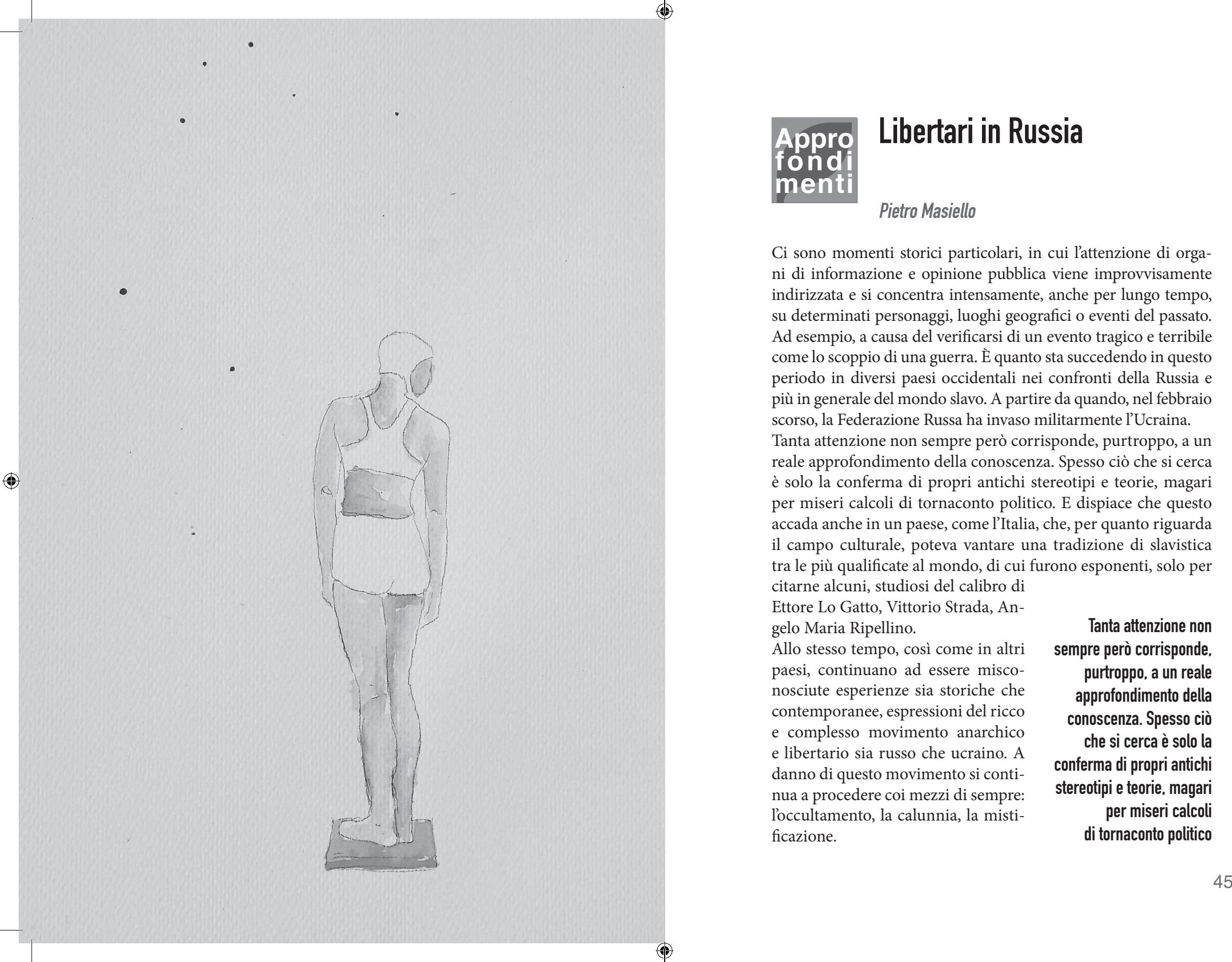

Libertari in Russia
Pietro Masiello
Ci sono momenti storici particolari, in cui l’attenzione di orga ni di informazione e opinione pubblica viene improvvisamente indirizzata e si concentra intensamente, anche per lungo tempo, su determinati personaggi, luoghi geografici o eventi del passato. Ad esempio, a causa del verificarsi di un evento tragico e terribile come lo scoppio di una guerra. È quanto sta succedendo in questo periodo in diversi paesi occidentali nei confronti della Russia e più in generale del mondo slavo. A partire da quando, nel febbraio scorso, la Federazione Russa ha invaso militarmente l’Ucraina.
Tanta attenzione non sempre però corrisponde, purtroppo, a un reale approfondimento della conoscenza. Spesso ciò che si cerca è solo la conferma di propri antichi stereotipi e teorie, magari per miseri calcoli di tornaconto politico. E dispiace che questo accada anche in un paese, come l’Italia, che, per quanto riguarda il campo culturale, poteva vantare una tradizione di slavistica tra le più qualificate al mondo, di cui furono esponenti, solo per
citarne alcuni, studiosi del calibro di Ettore Lo Gatto, Vittorio Strada, An gelo Maria Ripellino.
Allo stesso tempo, così come in altri paesi, continuano ad essere misco nosciute esperienze sia storiche che contemporanee, espressioni del ricco e complesso movimento anarchico e libertario sia russo che ucraino. A danno di questo movimento si conti nua a procedere coi mezzi di sempre: l’occultamento, la calunnia, la misti ficazione.
Tanta attenzione non sempre però corrisponde, purtroppo, a un reale approfondimento della conoscenza. Spesso ciò che si cerca è solo la conferma di propri antichi stereotipi e teorie, magari per miseri calcoli di tornaconto politico

Visioni distorte
Un caso emblematico è quello del «movimento makhnovista ucraino» (Châtelain 2012; Shubin 2012), una delle esperienze più importanti dell’anarchismo novecentesco, senza la cui conoscenza non è possibile nemmeno comprendere il corretto svolgimento dei fatti e delle dinamiche principali della Rivoluzione russa. Stiamo parlando di un movimento popolare che, guidato dal contadino Nestor Ivanovič Makhno, realizzò un vasto esperimento di gestione collettiva delle terre, basato sull’autogestione e non sul controllo autoritario e burocratico sovietico. Parallelamente, l’armata contadina makhnovista inflisse all’esercito «bianco» zarista delle sconfitte di enorme portata, senza le quali avremmo visto soccombere l’Armata Rossa bolscevica. Per tutto ringraziamento, i bolscevichi soffocarono nel sangue e nella persecuzione il movimento anarchico ucraino.
Ebbene, pare incredibile, ma ci sono testi di storia dell’Europa orientale e di storia della Russia, utilizzati in alcune delle principali Università italiane, dove il nome di Nestor Ivanovič Makhno non è nemmeno citato. In modo ancor più incredibile, si è costretti a leggere su un quotidiano con una storia come quella de «il Manifesto», la riproposizione di vecchie calunnie bolsceviche e poi staliniste contro gli anarchici del movimento makhnovista, come la falsa accusa di antisemitismo (Colombo 2018), ampiamente smentita da numerosi testimoni dell’epoca e dalle successive ricerche storiche, che hanno invece dimostrato l’impegno deciso di Makhno a difesa della popolazione ebraica.
Ma il movimento makhnovista è vittima anche della mistificazione nazionalista. Da anni ormai la figura di Nestor Ivanovič Makhno viene strumentalizzata dal potere ucraino che ne ha fatto, svilendola, un mito nazionale in chiave antirussa, occultando l’essenza anarchica e rivoluzionaria dei contadini makhnovisti. In Ucraina sono ormai innumerevoli gli esempi di monumenti, banconote, monete e francobolli, serie televisive e finanche marche di vodka dedicate a Batko Makhno, spacciato per eroe nazionalista.
Situazione attuale
Per venire all’oggi, va detto che, per quanto riguarda la Federazione Russa e i paesi orbitanti nella sfera di influenza russa, è difficile, se non quasi impossibile, poter descrivere in modo corretto ed esaustivo lo stato attuale sia del variegato movimento anarchico e libertario, che di situazioni riconducibili ad esperienze di «mutuo appoggio». Reperire informazioni attendibili da fonti dirette è quanto mai difficile, anche a causa della repressione ogni giorno crescente operata dal regime putiniano. Ma non si tratta solo di questo. Tra i militanti dei movimenti alternativi si stanno riproponendo tristi dinamiche già viste ai tempi della guerra nella ex-Jugoslavia. Lo stato di guerra e la recrudescenza della cecità causata dai nazionalismi hanno innescato una sorta di «richiamo della foresta identitario», che ha spinto diversi militanti libertari ad arruolarsi. Scelte tragicamente contraddittorie, difficilmente comprensibili se viste da lontano. Per analizzare le quali sarebbe forse troppo facile ricorrere al giudizio di Errico Malatesta («gli anarchici hanno dimenticato i propri princìpi») rispetto alla posizione di Kropotkin di fronte alla Prima Guerra Mondiale. Parallelamente però, ci giungono anche testimonianze documentate di coraggiose manifestazioni di opposizione alla guerra di matrice libertaria. Pervengono rivendicazioni di atti di sabotaggio nei confronti delle strutture militari per l’arruolamento, ma anche di interi plessi scolastici nei quali il corpo insegnante si sta rifiutando di utilizzare i nuovi testi scolastici approntati dal regime russo, in cui ad esempio la storia dell’Ucraina viene stravolta con la nuova narrazione orwelliana imposta da Putin. È quanto accade, ad esempio, nel distretto di Tver’, del quale era originario Bakunin. Nel cui paese natale, Priamukhino, un collettivo di attivisti libertari porta avanti da anni una meritoria opera di valorizzazione del suo pensiero con l’organizzazione di convegni internazionali e la promozione di una casa editrice per la diffusione di testi anarchici e libertari russi e internazionali.


Sul fronte della durissima repressione giudiziaria nei confronti di militanti anarchici russi, bisogna registrare il persistere di coraggiosi esempi dell’attività di comitati di solidarietà, controinformazione e assistenza legale. La situazione dei militanti in Bielorussia sarebbe al momento ancora peggiore. Alcuni anni fa il caso della persecuzione dell’attivista Alexander Kolchenko riuscì ad avere risonanza anche all’estero, con manifestazioni di fronte alle ambasciate russe e comunicati ripresi anche dai servizi informativi pubblici di vari paesi. Oggi - e sembra davvero paradossale nel momento in cui Putin è divenuto il nemico pubblico numero uno - la repressione nei confronti degli attivisti libertari viene completamente ignorata dai media occidentali.
È forse da alcuni siti e canali Telegram che è possibile ricavare autonomamente informazioni dirette sulla notevolmente complessa situazione russa e ucraina. Ne indichiamo alcuni, segnalatici da attivisti libertari russi e ucraini, anche con posizioni assai diversificate: ОВД-ИНФО (OVD NEWS), KOMiTET
Oggi la repressione nei confronti degli attivisti libertari viene completamente ignorata dai media occidentali
CПРОТИВУ (Resistance Committee), МЕДИАЗОНА (ZONA.MEDIA), RIOTS & RESISTANCE, АНТИВОЕННЫЙ-БОЛЬНИЧЧНЫЙ.
Sempre tenendo presenti le raccomandazioni che pose George Orwell al termine di Omaggio alla Catalogna sul discernimento da utilizzare nella lettura di materiali scritti in tempo di guerra.
Bibliografia
H. CHÂTELAIN, Nestor Machno, la rivoluzione anarchica in Ucraina, edizione italiana a cura del Centro studi libertari/Archivio Pinelli, Milano 2012 (DVD) visibile al canale youtube: https://www.youtube.com/watch?v=u_djvBJcZSo Y. COLOMBO, Una retrospettiva per «Tre colori della verità, «il Manifesto», Roma, 6 Settembre 2018
A.V. SHUBIN, Nestor Machno: bandiera nera sull’Ucraina. Guerriglia libertaria e rivoluzione contadina, Elèuthera, Milano 2022

Per un’informatica conviviale
Carlo Milani
I «semi sotto la neve» sono una metafora per indicare le esperienze libertarie e le pratiche mutualistiche.
Gli esempi sono tanti: ecovillaggi che cercano di organizzarsi in maniera antiautoritaria; collettivi di autogestione educativa; cooperative di autocostruzione; case editrici, librerie e riviste libertarie; collettivi artistici e gruppi di affinità di ogni genere, e chi più ne ha, più ne metta.
Tutte queste esperienze, in particolare nel mondo ad alta intensità tecnologica contemporaneo, devono fare i conti con le questioni della comunicazione e dell’informazione, e dell’organizzazione della comunicazione e dell’informazione. Quali sono le regole e gli strumenti per comunicare fra le persone che partecipano? E quali per comunicare verso l’esterno, alle esperienze affini, al resto del mondo? Come si fa a informarsi, a selezionare informazioni, a orientarsi nel diluvio di notizie, a far circolare quelle che si ritengono opportune?
Le «Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione» (TIC), spesso indicate come nuove tecnologie, non sono affatto nuove, visto che se ne parla da decenni e ci abbiamo a che fare quotidianamente da tanto tempo. Con tecnologie intendo l’incarnazione concreta, materiale, tangibile di teorie e procedure che sono dei «modi di fare», «modi di costruire», ovvero le «tecniche». Un dispositivo elettronico portatile, ad esempio uno smartphone equipaggiato con un sistema operativo Android (parecchi miliardi di dispositivi nel mondo), è quindi un oggetto tecnologico, frutto di specifiche tecniche (produttive, organizzative); queste tecniche sono ispirate da specifiche ideologie, convinzioni, credenze. In questo senso «la tecnica non è e non può essere neutrale»: le sue concretizzazioni tecnologiche incorporano sempre visioni




del mondo situate, parziali, definite storicamente, socialmente e psicologicamente. Inoltre tendono a far nascere ulteriori generazioni di tecnologie (e di umani che dicono di servirsene) che agiscono e re-agiscono in maniera poco consapevole, determinata in maniera preponderante dall’orientamento tecnico sottostante. Le macchine non sono tutte uguali: dipende da come vengono create al mondo, e perché, proprio come gli umani non sono tutti uguali, ma dipende da come vengono creati al mondo, educati, socializzati e perché.
Le macchine non sono tutte uguali: dipende da come vengono create al mondo, e perché, proprio come gli umani non sono tutti uguali, ma dipende da come vengono creati al mondo, educati, socializzati e perché
Dal punto di vista libertario, è fondamentale capire se è possibile selezionare e avere a che fare con tecnologie capaci di promuovere il mutuo appoggio, oppure se queste tecnologie sono inevitabilmente foriere di delega cognitiva, psichica, sociale e in ultima analisi contribuiscono alla strutturazione di un mondo gerarchico e autoritario, il mondo delle «Megamacchine tecnoburocratiche».
Questioni di scala? Appunti per un’informatica conviviale
La questione principale, se seguiamo il ragionamento di Ivan Illich, è la scala. In Tools for Conviviality («Strumenti per la convivialità», tradotto in italiano come La convivialità, 1973) sostiene che uno strumento conviviale è l’opposto di uno strumento industriale, e la scala fa la differenza. A suo parere, su scala globale possono esistere solo strumenti industriali oppressivi.
Ma allora, è possibile un’informatica conviviale, cioè che promuova la realizzazione della libertà individuale in seno a una società dotata di strumenti efficaci? Ci vogliono tecnologie appropriate, ma per poterle immaginare e realizzare è necessario correggere e ampliare la formulazione di Illich.
Innanzitutto, dobbiamo riconoscere che «un sistema tecnico di piccola scala può essere dispotico tanto quanto un sistema industriale globale»; anzi, può rivelarsi ancora più censorio e asfissiante per la libertà personale. Ad esempio, le dinamiche psicosociali oppressive tipiche di un piccolo paese, in cui la gente mormora e tutti sanno tutto di tutti, possono risultare amplificate da tecnologie di controllo e monitoraggio su piccola scala, riproducendo un universo concentrazionario in miniatura.
In altre parole, «la piccola scala non garantisce di per sé l’assenza di dominio», ed è logico che sia così, «altrimenti la libertà sarebbe un derivato automatico dell’organizzazione in piccoli gruppi». Un piccolo gruppo di esseri umani può nutrirsi di relazioni di co-dipendenza tossiche alimentate e anzi rese possibile da semplici tecnologie artigianali di dominio reciproco, come il rispetto di rituali di sottomissione. Rituali analogici o digitali non fa differenza, si tratta in ogni caso di ripetizioni che mirano a instaurare un ritmo di acquiescente sottomissione, contrita obbedienza, schizofrenico conformismo a norme alienate e alienanti. Senz’altro non c’è bisogno di tecnologie particolarmente sofisticate.
Invece di formulare teorie astrattamente perfette, tipiche del peggior intellettualismo ignaro della realtà, dobbiamo prendere atto della scala globale della tecnologia attuale, in particolare nella sua manifestazione più evidente che è la rete di Internet, e agire a partire da quel che esiste oggi, ampliando spazi di autonomia concreta. In questo senso, al di là della scala, è importante prendere in considerazione le relazioni di potere.
Infatti, nell’ambito delle tecnologie di Rete, la «scala» non è semplicemente monodimensionale, legata alla vicinanza di una risorsa. La valutazione in merito al potenziale conviviale, emancipatorio e liberatorio di una configurazione tecnosociale deve tenere conto anche di altre variabili, quali, ad esempio, l’asimmetria di potere degli attori coinvolti e quindi la loro capacità di determinare norme socialmente vincolanti.
Si pensi alla fornitura di servizi web per la gestione amministrativa di un’attività legata all’organizzazione di piccoli eventi cul-




turali (decine o centinaia di persone). In termini di relazioni di potere, per mantenere un’analoga capacità di intervenire nella definizione e applicazione di norme che regolano l’interazione reciproca (la definizione è tratta da Bertolo 1983), potrebbe essere accorto rivolgersi prioritariamente a organizzazioni di taglia analoga, abituate ad avere a che fare con problemi affini. Organizzazioni molto più grandi potrebbero considerare marginali questioni di piccola scala e inglobare organizzazioni più piccole come semplici ingranaggi (intercambiabili) nel loro sistema dominante.
Traduco in tecnologia corrente nel primo e secondo decennio del XXI secolo: propagandare le attività della propria associazione culturale tramite «Meta» (Facebook-Instagram-Whatsapp) e altri social di massa condurrà inevitabilmente a un asservimento alle procedure imposte dalla multinazionale, di omologazione dei messaggi e dei contenuti a standard predefiniti. Verranno inevitabilmente modificate, adeguandosi al sistema tecnocratico, l’organizzazione del lavoro, le modalità di relazione interne ed esterne all’organizzazione, le dinamiche psico-sociali.
Usare bene il social di massa comporterà un costante aggravio di lavoro. Per quanto riguarda il controllo dei dati e, più in generale, la prossimità della tecnologia agli utenti umani, determinerà senz’altro una perdita di controllo e una lontananza sempre più marcata per via della struttura stessa della multinazionale, che tende ad accentrare la gestione dei dati in pochi nodi (data center), sotto il controllo di procedure opache e di pochi tecnoburocrati apicali. A livello di modalità d’interazione tecnica, i software utilizzati saranno proprietari, quindi non modificabili né distribuibili a piacimento dalle persone come invece accade nei sistemi «F/LOSS» (Free/Libre Open Source Software). Ma anche se fossero «F/LOSS», il gigantismo intrinseco vanificherebbe lo sforzo di apertura, perché milioni e milioni di righe di codice che girano solo su macchine gigantesche ed estremamente potenti richiedono organizzazioni gerarchiche globali (le multinazionali) per essere gestite. Le relazioni tenderanno a strutturarsi in maniera automatizzata e spersonalizzata: da una parte, perché lo sforzo di apprendimento e messa in pratica delle nozioni necessarie a interagire con il sistema tende a moltiplicarsi senza fine; dall’altra, per via dell’introduzione sempre più massiccia di sistemi automatici di risposta, le cosiddette «Intelligenze Artificiali» (assistenti virtuali e via automatizzando), con cui gli umani devono fare sempre più spesso i conti (richieste di informazioni, reclami, ecc.).
Infine, dal punto di vista psicologico, ma anche di impatto sulla gratificazione fisiologica per l’attività svolta, implicherà una frustrazione crescente, perché il sistema è strutturato in modo che a investimenti crescenti (in termini economici ed energetici) corrispondano rendimenti decrescenti. Anzi, peggio ancora: a investimenti costanti corrispondono rendimenti decrescenti. Questa constatazione spiega perché il sentimento che arnesi, utensili e macchine servano per alleviare la fatica umana non abbia più realmente corso nel caso delle Megamacchine digitali.
L’argomentazione appena svolta è una semplice riedizione della necessaria armonia e coerenza tra fini e mezzi, enunciata in maniera esemplare da Errico Malatesta. A suo parere la lotta per
la libertà e l’uguaglianza deve essere condotta con strumenti libertari ed egualitari, ovvero l’emancipazione non può darsi mediante strumenti oppressivi. Attenzione però: non sono gli esseri tecnici di per sé, nella loro essenza, ad essere oppressivi, bensì le relazioni (e dunque le reti) che essi favoriscono in quanto creati e sviluppati come motori di evoluzioni tossiche di massa. Fin qui la pars denstruens. Più difficile, come sempre, è la pars construens.
Non sono gli esseri tecnici di per sé, nella loro essenza, ad essere oppressivi, bensì le relazioni (e dunque le reti) che essi favoriscono in quanto creati e sviluppati come motori di evoluzioni tossiche di massa



Prossimità, affinità, federazione
Già a inizio Novecento Malatesta sosteneva che «i mezzi condizionano i fini: per la libertà ci si deve battere con strumenti che già siano in se stessi libertà». Un secolo abbondante più tardi, possiamo fare un passo più in là, ancora con Amedeo Bertolo, che, invitato nel 2005 a riflettere sull’identità anarchica in vista di un dibattito che non si è mai tenuto, aggiungeva: «Credo che la coerenza mezzi-fini sia il minimo. Credo che si debba andare oltre. Non solo il fine non giustifica i mezzi, ma sono i mezzi che giustificano il fine». Bertolo parlava dell’anarchia come metodo, cerniera di collegamento fra mezzi e fini. Tradotto in termini tecnici: gli esseri tecnici con i quali ci accompagniamo devono poter giustificare il fine della libertà nell’uguaglianza. Come facciamo le cose, insieme agli strumenti che sono esseri tecnici, deve riuscire nell’impresa di spiegare, supportare e far germogliare il cosa facciamo.
Si tratta quindi di invertire il flusso dell’iniziativa, dal locale verso il globale, secondo un modello di federazione reticolare in grado di trarre il massimo vantaggio dalla struttura decentralizzata e federata di Internet. Non si tratta di effettuare investimenti a pioggia, ma di facilitare iniziative legate a questioni concrete, tangibili, quotidiane. Non si tratta di inseguire la prossima startup o app capace di rivoluzionare il mercato e la società: sarebbe l’ennesima «rivoluzione» nel senso deteriore del termine, cioè una modifica repentina e distruttiva che rende obsolete le competenze faticosamente accumulate e rafforza le disparità preesistenti.
Declinare l’autogestione in questo contesto è relativamente semplice. Si tratta di rendere meno farraginose le pratiche per dar vita a organizzazioni di prossimità, vicine alle persone, gestite dalle persone, esperte e meno esperte, valorizzando la diversità ancor prima dell’abilità. Infatti è più importante che persone diverse fra loro riescano a collaborare in vista di un obiettivo comune piuttosto che delegare agli esperti di turno per ottenere un risultato «migliore». Queste organizzazioni, strutturate con l’aiuto di esseri tecnici affini, possono federarsi e creare federazioni internazionali: la piccola scala è quindi un utile parametro se declinata nel senso della prossimità e dell’affinità fra esseri umani ed esseri tecnici che cooperano per costruire mondi comuni. Mondi che aspirano all’internazionalismo per loro stessa natura: perché la libertà, per essere davvero tale, tende a estendersi a ogni essere, vivente o meno.
Il concetto di prossimità va inteso in accezione ampia, seguendo i fili delle connessioni reticolari. La co-presenza in un ambiente disconnesso, non sintetico, non è una condizione sempre necessaria, anche se spesso è desiderabile. In questo senso, è senz’altro
caratterizzato da prossimità un gruppo di poche persone sparpagliate in diversi continenti che condividono pratiche e ideali; che cooperano in maniera regolare, che si confrontano e discutono e scambiano esperienze e servizi grazie al potere straordinario delle reti digitali globali.
Infatti persone collegate da una solida rete del genere, di cui si prendono cura, si sentono prossime, vicine fra loro anche se abitano realtà diLa piccola scala è quindi un utile parametro se declinata nel senso della prossimità e dell’affinità fra esseri umani ed esseri tecnici che cooperano per costruire mondi comuni
sconnesse del tutto diverse fra loro, anche se vivono a latitudini diverse e in fusi orari lontani. Questo perché in primo luogo mantengono l’un l’altro delle chiare tracce affettive (situazione psicoemotiva e sociale reciproca), ovvero sono al corrente della situazione degli altri. Dal punto di vista emotivo si riscontra una consonanza fatta di comuni entusiasmi, indignazioni, slanci e frustrazioni condivise; dissensi e conflitti tendono a essere generativi e non distruttivi. Dal punto di vista organizzativo, grazie alla concatenazione organizzata di procedure selezionate e sviluppate in maniera consapevole, insieme a esseri tecnici specifici, un gruppo del genere mutua le dinamiche dei gruppi di




affinità tradizionali, con i suoi rituali assembleari il più possibile snelliti e facilitati, le sue capacità di impedire la strutturazione di gerarchie fisse, le sue dinamiche interne virtuose e proiezioni esterne verso lo spazio pubblico, nel senso di proposta politica e culturale.
Certo, è più difficile rispetto ai modelli tradizionali di associazionismo e collaborazione, basati spesso sulla co-presenza disconnessa. Ma sappiamo per esperienza che incontrarsi di persona non è una garanzia di convivialità e tanto meno di emancipazione liberatoria: a volte i conflitti inespressi covano ed esplodono in maniera inaspettata proprio laddove ci si aspetterebbe concordia nella diversità reciproca. Il convenire assieme in uno spazio fisico tradizionale non è nemmeno l’inevitabile premessa di una rivolta generalizzata. Le piazze straripanti non sono garanzia di rivoluzione sociale imminente, anzi, possono segnalare i prodromi di un’involuzione autoritaria, perché al di là delle retoriche sulla «saggezza delle folle», come ci ricorda Elias Canetti in Massa e Potere (nell’originale titolo tedesco, Masse und Macht, si può tradurre anche come «Potenza»), la massa s’infiamma facilmente e tende a disperdersi quando l’incendio si è consumato. Non saranno individui stanchi e demotivati, che non hanno nulla da perdere, a dar vita a un grande collettivo solo perché si ritrovano insieme a sfogarsi.
Vuol dire imparare a cogliere la bellezza e la forza degli incontri online; imparare a mescolare, meticciare gli ambienti, convocando in uno spazio pubblico umani fisicamente lontani, ma politicamente vicini
Certo, è meraviglioso potersi incontrare di persona, ma spostarsi in continuazione da una città all’altra, da un continente all’altro è una follia in primo luogo ecologica (che fra l’altro implica un’infrastruttura globale di sfruttamento a tutti i livelli) a cui noi privilegiati abitanti del mondo globalizzato dobbiamo porre fine per decisione autonoma e non perché costretti dalla catastrofe ambientale in corso e dal senso di colpa. Questo non vuol dire rinunciare alla prossimità e persino all’intimità tout court; vuol dire invece riorganizzare tempi, modi e abitudini, insieme alle tecnologie che devono evolvere insieme a noi. Vuol dire imparare a cogliere la bellezza e la forza degli incontri online; imparare a mescolare, meticciare gli ambienti, convocando in uno spazio pubblico umani fisicamente lontani, ma politicamente vicini.
Possiamo allora riformulare la questione nei seguenti termini: quali sono le caratteristiche, i tratti, i caratteri che vengono selezionati nei sistemi tecnocratici? Quali comportamenti umani e quali reazioni tecniche favoriscono l’emersione di una gerarchia di dominio? Quali tratti e comportamenti favoriscono invece l’insorgere di dinamiche di mutuo appoggio e l’affermarsi del retaggio della libertà?
Ho cercato di ragionare su queste questioni nel saggio Tecnologie conviviali, di prossima pubblicazione per i tipi della casa editrice elèuthera. Si tratta di una rassegna, certamente non esaustiva, delle metodologie e delle esperienze esistenti, dei «semi sotto la neve» che possono aiutarci a evolvere relazioni di mutuo appoggio anche insieme alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Bibliografia
A. BERTOLO, Potere, autorità, dominio: una proposta di definizione, «Volontà», 1983 n. 2
E. CANETTI, Massa e potere [1960], Adelphi, Milano 2015
I. ILLICH, La convivialità [1973], Mondadori, Milano 1978
C. MILANI, Tecnologie conviviali, elèuthera, Milano 2022: di prossima pubblicazione




La terra e il collettivo, l’organizzazione economica zapatista
Andrea Mazzocco
Tierra y libertad, questo il motto con cui Emiliano Zapata guidò l’esercito di liberazione del sud nella rivoluzione messicana all’inizio del secolo scorso. Una rivoluzione tanto radicale nei presupposti, quanto effimera nei risultati, per la svilente riproduzione degli stessi meccanismi di potere anche dopo la destituzione del dittatore Porfirio Díaz. Sul finire dello stesso secolo compariva sulla scena mondiale l’Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) che, riprendendo gli stessi valori, rompeva in realtà con tutte le rivoluzioni novecentesche fino a quel momento osservate.
L’EZLN, nato come costola dei movimenti guerriglieri marxisti leninisti messicani, trae la sua forza proprio dal distaccarsi dall’ideologia originaria, per contaminarsi con la componente indigena, che ne rappresenta la quasi totalità dei membri. Uno degli effetti più evidenti di questa trasformazione la vediamo fin dalla loro prima uscita pubblica, nel levantamiento del primo gennaio 1994. Questo poiché apparve subito chiaro come la sollevazione armata non avesse come obiettivo la presa del potere e l’entrata trionfante a Città del Messico, anche se questa opzione non era stata scartata a priori, ma era stata condizionata al fatto che il popolo messicano intero avesse appoggiato la ribellione. L’obiettivo primario fu la liberazione dei territori indigeni del Chiapas e conseguentemente la redistribuzione della terra, premessa fondamentale all’amministrazione autonoma che vi sarebbe sorta. La stessa data del primo gennaio 1994 non fu scelta per caso, ma coincideva con l’entrata in vigore del trattato di libero commercio con Stati Uniti e Canada (NAFTA), identificato immediatamente come un accordo neoliberista che avrebbe dato il colpo di grazia soprattutto alla classe contadina indigena.
Rivendicazioni e aspirazioni collettive
La terra è il fulcro delle rivendicazioni indigene, perché rappresenta l’elemento centrale della riproduzione sociale delle comunità: senza la terra manca una fonte di sussistenza autonoma, si determina la necessità di ricorrere al lavoro salariato per la sopravvivenza e si corrompono quelle che sono la caratteristiche della vita sociale ed economica delle comunità indigene. L’economia comunitaria indigena si discosta infatti dall’economia capitalista per due fattori in particolare: il lavoro e la proprietà. Il lavoro non viene inteso come merce di scambio, non è valorizzato in sé, ma viene considerato semplicemente come un mezzo per raggiungere obiettivi di consumo e sussistenza. Il concetto
di salario è estraneo alla cultura indigena in cui il lavoro, che sia per la propria famiglia o per la propria comunità, è visto anche come fattore di redistribuzione, attraverso il lavoro volontario per la comunità, l’aiuto e l’interscambio di forza lavoro nei periodi di raccolto in base al calendario agricolo, la messa a disposizione
Il lavoro, che sia per la propria famiglia o per la propria comunità, è visto anche come fattore di redistribuzione, attraverso il lavoro volontario per la comunità
di parte del raccolto gratuitamente a beneficio della comunità. La proprietà, d’altro canto, è sempre collettiva. La terra può distinguersi fra terra comunitaria, gestita direttamente dalla comunità attraverso i suoi organi, e terra assegnata alle famiglie per la loro sussistenza. Quest’ultima, però, non può essere disposta a piacimento da parte della famiglia, poiché non ne ha la proprietà esclusiva, ma solo il possesso: non può essere venduta o alienata se non a familiari e in caso la famiglia decida di emigrare le terre coltivate dalla stessa tornano a disposizione della comunità; inoltre la gestione delle coltivazioni familiari può essere influenzata da parte della comunità per seguire la differenziazione delle culture tipiche della comunità indigene latinoamericane. Questa usanza ha diversi vantaggi per la comunità: la possibilità di avere



più varietà agricole coltivate internamente, il fatto che il terreno rimane ricco di sostanze nutritive e infine la possibilità di avere tempi di maturazione e quindi di raccolto diversi fra le varie colture, in modo da permettere lo scambio di forza lavoro fra le famiglie per supportare il maggior carico in questi periodi.
La logica di produzione segue dunque la legge del sostentamento collettivo, non solo familiare, sia attraverso il consumo diretto della merce prodotta, sia attraverso lo scambio della produzione per ottenere altri prodotti non producibili internamente. In entrambi i casi la razionalità produttiva è sempre rivolta al consumo e mai all’accumulazione.
Per riassumere quanto fin qui esposto, potremmo dire che la cooperazione si è imposta nella matrice culturale di queste popolazioni, poiché ha permesso un benessere maggiore rispetto a una gestione individualista, situazione dimostrata dai fatti oltre che, per citarne una argomentazione teorica, fulcro delle tesi esposte da Kropotkin nell’opera Il mutuo appoggio, un fattore dell’evoluzione. Su queste basi, già prima della sollevazione del 1994, le comunità indigene afferenti all’organizzazione zapatista avevano sviluppato una gestione autonoma dei territori, raggiungendo in pochi anni l’autosufficienza grazie al sistema dei campi collettivi.
Ogni comunità, governata collettivamente dall’assemblea comunitaria, gestisce dei campi collettivi coltivati da tutte le famiglie che fanno parte della comunità. Il raccolto risultante è direttamente a beneficio della comunità stessa: viene usato per alimentare chi non ha raccolto, come chi ha assunto una carica (promotore o promotrice di salute, promotore o promotrice di educazione, etc.) o chi non può autosostentarsi, come chi possiede un qualche tipo di disabilità o gli anziani non mantenuti dai figli. Oltre a ciò, la vendita nei mercati dell’eccedenza deve servire alle necessità pratiche della comunità, dalle infrastrutture all’agibilità politica, oltre che per gli investimenti collettivi, motore di tutte le altre attività economiche della comunità: dall’allevamento all’artigianato si produce con investimento collettivo e le entrate vanno a sostenere la comunità stessa.
Organizzazione assemblearia
Fin dal 1994, le comunità sono state suddivise in municipi autonomi, che amministrano il territorio a loro spettante. Anche qui l’organo decisionale è l’assemblea municipale (a cui partecipano rappresentanti di tutte le comunità che fanno parte di uno specifico municipio) e anche qui troviamo la presenza di campi collet-
dell’assemblea.
L’organo decisionale è l’assemblea municipale e anche qui troviamo la presenza di campi collettivi, coltivati a turno dalle comunità che fanno parte di quel municipio
tivi, coltivati a turno dalle comunità che fanno parte di quel municipio. Il raccolto risultante viene venduto e utilizzato secondo le indicazioni dell’assemblea: può essere utilizzato per ulteriori compensazioni a comunità che hanno basse risorse, ma anche per le infrastrutture più esose, come le cliniche autonome. È proprio il poter contare su due livelli di governo autonomo ciò che ha garantito il grande sviluppo dei territori autonomi negli anni ‘90. Nel 2003, per ovviare a uno squilibrio che iniziava a sorgere fra gli oltre trenta municipi, i livelli di governo sono divenuti tre: sono stati fondati i primi cinque caracoles (divenuti dodici nel 2019), centri direzionali e politici che gestiscono una zona di loro competenza con diversi municipi all’interno. Contestualmente, sono state fondate le Giunte di buon governo, cariche elettive e rotative elette dall’assemblea di zona (assemblea di tutta la zona facente parte di un singolo caracol) per compierne il volere, secondo il famoso «comandare obbedendo» zapatista. Anche in questo caso sono stati fondati campi collettivi coltivati a turno dai vari municipi afferenti alla zona di un caracol. I proventi vengono gestiti dalla Giunta di buon governo su mandato
Il carattere di novità è però rappresentato da un altro aspetto dell’autonomia zapatista. Un’amministrazione autonoma che si muova dal basso ha ovviamente l’obiettivo di migliorare la qualità della vita della propria popolazione di riferimento. In Chiapas




le condizioni di vita sono sempre le state le peggiori di tutto il Messico, proprio per l’alta porzione indigena e il completo disinteresse dello Stato ad attuare investimenti pubblici nei servizi essenziali. Energia elettrica, acqua corrente, accesso all’educazione o alle cure erano praticamente inesistenti prima del 1994. L’organizzazione civile zapatista ha quindi creato varie commissioni incaricate di occuparsi ognuna di un tema specifico: educazione, salute, giustizia, agroecologia, produzione, questione di genere, trasporti, comunicazione. Queste commissioni sono supervisionate dalla giunta di buon governo di riferimento, e possono proporre mozioni da votare in assemblea.
Costruzione dell’autonomia
In questi 28 anni la costruzione dell’autonomia ha incontrato migliaia di ostacoli, a volte esterni ma spesso interni. Per mancanza di competenze specifiche in alcuni campi, molte commissioni si sono rette per diversi anni sul supporto di volontari e volontarie della società civile messicana e internazionale. Un esempio emblematico è il grandissimo supporto ricevuto da personale medico specializzato solidale. Il progetto ambizioso era quello di ricondurre le piante medicinali tradizionali a un uso più scientifico, potendo trarre i benefici di entrambi i modelli (tradizionale ed occidentale). Attualmente possiamo dire che l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto, l’accesso alle cure è ora generalizzato e una
Il progetto ambizioso era quello di ricondurre le piante medicinali tradizionali a un uso più scientifico, potendo trarre i benefici di entrambi i modelli (tradizionale ed occidentale)
nuova generazione di promotrici e promotori di salute gestiscono in autonomia le cliniche autonome, alcune delle quali presentano attrezzature all’avanguardia anche per intervenire a livello chirurgico. La gestione durante la pandemia è stata cosciente e oculata, registrando nel 2020 un numero di morti per problemi polmonari statisticamente irrilevante grazie alla chiusura delle comunità.
Anche per quanto riguarda il sistema educativo da diversi anni non sono più presenti volontari esterni, ma l’intero processo è gestito in completa autonomia dalle comunità per le comunità. Su questo tema specifico, consiglio caldamente la lettura de Il sistema educativo nella resistenza zapatista di Lorenzo Faccini.
La costruzione dal basso di quell’«altro mondo possibile» e la creazione di risposte concrete alle ragioni del levantamiento hanno portato l’esperienza zapatista a espandersi senza l’uso di armi. Il sistema giudiziario autonomo basato sulle riparazione e non sulla pena, ad esempio, ha avvicinato moltissime famiglie che nel 1994 non scelsero la via armata per la loro liberazione, ma che hanno riconosciuto nel modello zapatista qualcosa a cui affidarsi e in cui non ritrovare il razzismo e la burocrazia delle istituzioni messicane che continuano a considerare gli indigeni cittadini di serie b.
La rivoluzione zapatista, insieme alle mille sfaccettature di cui si compone, è anche questo: una rivoluzione delle pratiche, un modello a cui aderire, un’altra via che ci viene mostrata. Per noi qui in Europa sicuramente è non un modello esportabile asetticamente, ma la conferma che se puede, che un mondo diverso è possibile e necessario.
Bibliografia
L. FACCINI, Il sistema educativo nella resistenza zapatista: Storia, memoria, identità, Metelmi, Milano 2022
P. KROPOTKIN, Il mutuo appoggio. Un fattore dell’evoluzione [1902], elèuthera, Milano 2020




Conversazione con Riccardo Gatti
a cura di UrLa
Riccardo Gatti (1978) è da anni impegnato nei soccorsi in mare. Attualmente collabora in qualità di consulente SAR – Search and Rescue - come responsabile dei soccorsi a bordo della nave Geo Barents, di Médecins sans Frontiéres (MSF), attiva nel Mediterraneo centrale.
Nel 2015 ha iniziato a lavorare con MSF nel mar Egeo come pilota di imbarcazioni di soccorso.
Nel 2016 è stato operativo nel Mediterraneo Centrale sulle navi della ONG spagnola Open Arms, inizialmente come comandante, poi come capo missione, ricoprendo contemporaneamente il ruolo di presidente di Open Arms Italia. Dal 2021, conclusa l’esperienza con Open Arms, ha continuato a collaborare con diverse ONG nelle operazioni di soccorso nel Mediterraneo centrale.
Incontriamo Riccardo Gatti presso l’Ateneo Degli Imperfetti a Marghera e iniziamo con lui una conversazione in occasione della presentazione del suo libro Conversazioni in alto mare, scritto in collaborazione con il Prof. Marco Aime, docente di Antropologia Culturale (elèuthera),
Perdona l’ovvietà della domanda, ma come hai iniziato questo percorso che da un Comune della Lombardia ti ha portato a comandare le navi da soccorso in mare?
Mi sono trasferito in Spagna circa 20 anni fa. Ho lavorato come educatore sociale a progetti di appoggio a persone a rischio di esclusione sociale, poi ho collaborato con associazioni per la protezione dei minori, in particolare di minori migranti non accompagnati. Dopo vari anni mi sono preso una pausa e ho cominciato a lavorare con un amico che si occupava di barche.

Successivamente ho fatto esperienze sugli yacht, ma quel mondo non mi piaceva non vedevo l’ora di andarmene. Il tutto comunque solo d’estate, d’inverno studiavo psicologia. Venni a sapere che a fronte degli sbarchi di migliaia di persone che cercavano di rifugiarsi in Europa scappando dalle guerre in Siria, Iraq e Afghanistan, c’era un progetto di MSF di soccorso in mare operativo in Grecia. Cercavano persone con esperienza nel sociale, specialmente con migranti, munite di patente nautica e con esperienza in mare. Sembrava tagliato su di me, così sono partito per la Grecia, alla volta di un’isoletta di fronte alla Turchia. Eravamo suddivisi in due squadre, con due lance di soccorso. La prima uscita, fatta di notte, di nascosto della guardia costiera greca, riuscimmo a portare in salvo 159 persone.
Proseguiamo questa conversazione chiedendo a Riccardo di raccontarci, nei punti principali, la storia delle operazioni dei soccorsi in mare a partire da Mare Nostrum (2013) sino ad oggi. Raccontare brevemente questo tema è difficile, sia per l’ampiezza dell’argomento, sia per la ricchissima capacità narrativa di Riccardo.
I grandi naufragi del 2013 hanno dato l’avvio all’operazione Mare Nostrum. Ricordo il forte impatto che ebbero sull’opinione pubblica le operazioni di soccorso, la vasta eco che ottenevano nei media. In quel periodo stavo lavorando su uno yacht e ascoltavo la radio spagnola. Sentivo l’inviata della radio intervistare i pescatori, che raccontavano come venivano svegliati di notte dalle grida che provenivano dal mare. Qualche anno dopo, quand’ero comandante di una delle navi da soccorso, passammo sul punto del naufragio nei pressi di Lampedusa proprio il giorno del triste anniversario della tragedia che causò 368 morti. Non riesco ancora a descrivere le sensazioni che provammo, quando ci rendemmo conto della breve distanza che ci separava dalla costa. Anche sulla scorta di questi impatti emotivi che agivano sull’opinione pubblica il governo italiano presieduto da Letta diede avvio all’operazione Mare Nostrum, operazione che utilizzava i mezzi militari, navi da guerra, elicotteri per le missioni di soccorso. L’operazione è durata un anno al costo di 9 milioni di euro al mese e copriva tutta l’area del Mediterraneo centrale. Mare Nostrum venne chiusa dopo un anno, a seguito del rifiuto dell’Europa di partecipare al progetto e venne sostituita dall’operazione Triton di Frontex (programma a guida UE). Frontex copriva un’area più ristretta rispetto a Mare Nostrum, inizialmente 30 miglia dalla costa, area che venne successivamente aumentata, ma la differenza sostanziale rispetto alla precedente è che Mare Nostrum era un’operazione SAR, mentre Frontex era un’operazione di polizia di frontiera: da quel momento, le operazioni di soccorso in mare sono diventate operazioni di controllo delle frontiere e sicurezza in mare.
Dal 2014 al 2016 diverse ONG (MSF, Sos Méditerranée, Sea Watch, lifeBoat, Open Arms e altre) operarono nel Mediterraneo in coordinamento e aiuto alla guardia costiera. Erano operative 9 ONG con 12 navi, alle quali vanno aggiunte almeno 3 navi della guardia costiera, più altre navi della marina militare. Insomma, una buona presenza. Quanti operavano lo facevano sottostando semplicemente all’obbligo di soccorso in mare, una legge universale che deve essere rispettata in qualunque situazione. All’incirca fino alla metà del 2017 si operò sotto il coordinamento e il supporto della guardia costiera, che indicava i porti di destinazione, i tempi di navigazione, le situazioni di crisi e provvedeva anche agli imbarchi dei profughi. Tutto questo entrò in crisi a seguito dell’accordo tra il governo italiano, la Comunità europea e la Libia, siglato dall’allora Ministro dell’interno Minniti.
È da questo periodo che si è modificato l’atteggiamento verso le ONG: che cosa è cambiato? È cambiata la comunicazione?
I passaggi non sono stati chiari, i cambiamenti sono avvenuti a poco a poco, sottotraccia. Si è iniziato opponendo ostacoli



di tipo operativo, poi legale e infine burocratico. Le navi delle ONG sono state sottoposte a controlli amministrativi assurdi, ad esempio sulla quantità di persone imbarcate, sul numero di servizi igienici, etc. Richieste incredibili, considerato che raccogliamo naufraghi in condizioni estreme. Sono stati imposti codici di condotta da sottoscrivere, da siglare con il governo italiano. Se tu devi firmare un codice di condotta, vuol dire che la tua condotta viene messa in discussione, come mi fece presente l’ex senatore Luigi Manconi.
MSF, SeaWatch e Iuventa si erano rifiutate di firmare e a livello pubblico era passato il messaggio che le ONG non volessero firmare un codice di condotta, per oscuri motivi. Da quel momento è iniziato a cambiare l’atteggiamento nei riguardi delle ONG, con pesanti risvolti pratici.
È cominciato un cambiamento di comunicazione da parte delle amministrazioni pubbliche e della politica e ha preso l’avvio un processo di criminalizzazione delle ONG, che sono state accusate di traffici sulla pelle dei migranti. L’infame definizione di «taxi del mare» testimonia il livello raggiunto. È venuta poi meno poco a poco la collaborazione con la guardia costiera italiana che ha interrotto i rapporti con le ONG. Non sono state più segnalate le imbarcazioni in pericolo, non sono stati più indicati i porti di accoglienza, insomma dalla iniziale collaborazione si è passati a un atteggiamento ostile ed è emerso il programma che si stava mettendo in atto e cioè la volontà di eliminare le ONG dalle operazioni di salvataggio, per sostituirle col nuovo corpo di guardia costiero libico. Forte delle dotazioni messe a disposizione dell’Italia, si stava spingendo per creare un corpo di polizia costiera libico, con le navi fornite dall’Italia.
A volte la guardia costiera libica si dirigeva sui barconi, sparava e ammazzava e poi portava i superstiti in Libia, in modo illegale, confinandoli in veri e propri campi di concentramento. Io stesso mi sono trovato di fronte alle armi spianate da questi personaggi ed è evidente che hanno mano libera di operare.




Quindi se da una parte è aumentata la criminalizzazione delle ONG ed è venuta meno la collaborazione e la presenza attiva dell’Italia, dall’altra sono aumentati i fondi e i mezzi destinati ai libici. Insomma ai libici è stato dato mandato di operare cercando di sostituire ed eliminare la scomoda presenza delle ONG.
Poi è iniziato il fronte legale, con denunce, procedimenti aperti e poi quasi tutti archiviati in fase di indagine preliminare: fino ad oggi non c’è stata nessuna condanna. La mia compagna Ani è stata accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (pena prevista 20 anni) e di violenza privata al ministro degli interni.
Infine è iniziata la fase degli intoppi amministrativi, con difficoltà sempre più pesanti e controlli a nave ed equipaggio che sono divenuti per un certo periodo sistematici ogni volta che la nave toccava un porto, con fermi prolungati. È uno strumento lecito, ma è stato utilizzato in modo discriminatorio, considerato che alle altre navi (ad esempio mercantili) non sono state fatte le stesse richieste. Sono state addirittura stabilite quarantene per il Covid. Anche se bordo tutti risultavano negativi, venivi comunque fermato per 15 giorni.
Uno dei risultati di tutto ciò è stata la sparizione delle ONG più piccole che non potevano sostenere le spese legali. Anche se alla fine vieni prosciolto, gli avvocati devi pagarli, ed inoltre questa violenta campagna ha fatto sì che diminuissero notevolmente le donazioni.
In tutto questo tempo quello che sono riusciti a fare è tenere lontane le navi di soccorso dal mar Mediterraneo, quindi meno salvataggi e più morti, questo è il drammatico bilancio del quale non conosceremo mai i numeri. Nel frattempo si è continuato a dare soldi alla guardia costiera libica, costruendo questa forza d’intercettazione e respingimento ed eliminando la presenza delle navi ONG che sono scomodi testimoni. Considera che i giornalisti sono sempre presenti sui mezzi delle ONG, mentre è ovviamente preclusa loro la presenza sulle motovedette (a meno che non raccontino una realtà falsata).

Continuano i blocchi amministrativi, che sono applicabili alle navi finché non escono dal porto e dalle acque territoriali. Quindi gli ispettori possono venire a bordo e fare i controlli e non sai mai quello che è cambiato, cosa pretendono.
Per i soccorsi sono state anche utilizzate navi private. I governi mettono in discussione il fatto che una nave privata possa fare i soccorsi, così le navi private hanno smesso di farlo. Un altro impedimento è dato dal negare il permesso di lasciare il porto, semplicemente non rispondendo alla richiesta. Una nave privata ha bisogno del permesso per lasciare il porto, se tu non ricevi il foglio per uscire, devi fare ricorso e possono passare fino a 3 mesi, poi magari dopo 2 mesi e mezzo ti danno il permesso.
Poi vengono fatte delle richieste specifiche alla nave: devono essere certificate per un certo numero di persone, allora si fanno tutte le prove, ad esempio di stabilità, etc. e nel frattempo non si può andare in mare. Le autorità storpiano la realtà, considerando le imbarcazioni non come navi da soccorso ma come un mix tra navi passeggeri e navi mercantili. Non c’è nessuna chiarezza nelle regole, hanno fatto così passare l’idea che le persone soccorse non sono propriamente naufraghe, ma, più o meno, passeggeri di un traghetto.
Non considerare le persone come naufraghi significa che non necessitano di essere soccorse nell’ambito di operazioni SAR. Le autorità non devono sottostare agli obblighi delle convenzione SAR che impongono lo sbarco nel più breve tempo possibile. I naufraghi vengono inseriti nell’ambito di operazioni di polizia e con ciò si storpia la realtà anche riguardo al loro status (migranti VS naufraghe). Si arriva a richiedere alle ONG dotazioni di bordo ad hoc per navi che non rientrano in nessuna classificazione. Richiedono ad esempio la certificazione per un numero massimo di persone da imbarcare, e poi il 30% di letti rispetto al numero di persone e anche un certo numero di bagni. Può accadere, perciò, che hai portato in porto 300 persone ma la nave



è certificata per 100 ed è inutile cercare di fare capire che è un soccorso di naufraghi in mare. Che cosa dovevamo fare con gli altri naufraghi, lasciarli lì? Questa normativa non esiste a livello internazionale, è solo una richiesta fatta durante le ispezioni negli ultimi due anni e mezzo. È stato tutto studiato per creare difficoltà insormontabili.
Quindi è diventato difficile capire come attrezzare le navi per fare soccorso, ma di base c’è che le persone non vengono considerate naufraghe, ma migranti. Questo cambio di status da naufraghi a migranti fa sì che queste persone non siano più protette dalle norme internazionali che impongono che siano accolte nel più breve tempo possibile, portate in un porto sicuro, curate, riconosciute nei loro diritti. Non è più un’operazione umanitaria, bensì una questione di polizia di frontiera. Infatti non sono più state aperte operazioni di soccorso, ma operazioni di polizia che opera controlli e respingimenti, non assistenza e aiuto.
Hanno messo degli ostacoli che impediscono di operare, secondo una politica di esclusione: il loro obiettivo è il respingimento?
Certo che lo è, è un respingimento attivo, chi sta formando la guardia costiera libica è l’Unione europea, l’Italia dà le navi alla Libia, chi fa coordinamento è una nave di marina italiana ormeggiata nel porto di Tripoli.
Adesso intercettano le imbarcazioni dei naufraghi, la cui posizione viene segnalata non più alle ONG, bensì ai libici. Nascondendosi dietro al fatto che bisogna chiamare le autorità competenti nella zona dei soccorsi, guidano i libici dall’aereo e le persone vengono riportate in Libia, in contrasto con la Convenzione di Ginevra. E poi sai che queste persone in Libia, scompaiono, non si sa bene che fine facciano, semplicemente spariscono, entrano nel circolo vizioso e remunerativo del traffico di persone.
La realtà è che noi a bordo si parla con i naufraghi, i ragazzi sono spaventatissimi, dicono: «questi (della marina libica) sono gli stessi che mi hanno fatto partire, che in Libia mi hanno torturato, violentato».
Chi spinge in questa direzione è l’Unione Europea, che utilizza i fondi fiduciari per l’Africa. L’Italia è attiva in questo, Italia e Frontex. Si preferisce una soluzione militare e stanno emergendo infatti i rapporti tra Frontex (che gestisce miliardi di Euro) e le industrie belliche. A questo proposito è stata aperta un’inchiesta che possiamo immaginare troverà qualche capro espiatorio, senza mettere sotto accusa il sistema.
Si assiste forse oggi ad una sorta di indifferenza, di assuefazione, nonostante i reportage, e le inchieste (la giornalista Francesca Mannocchi, il programma Rai Report) che denunciano l’orrore dei campi in Libia e le azioni della marina militare libica?
Pensa al lavoro di comunicazione fatto ripetutamente, tutti i giorni. Ad esempio tutti i giorni senti parlare di taxi del mare ed invasione, una vera e propria strategia della comunicazione che crea assuefazione, che genera poi disinteresse. Direi c’è interesse a far perdere interesse, gridare e creare scompiglio, come ha fatto Salvini. Agitare la paura manteneva un certo livello di attenzione, poi il silenzio, tutto passa, la gente non ha più voglia di seguire questa cosa, che viene messa sempre di più sullo sfondo. L’impatto emotivo del 2015, quando è stato trovato morto sulla spiaggia Alan Kurdi, il bambino siriano di 3 anni, oggi non c’è più, tutto viene silenziato o portato avanti dicendo che «è meglio che non partano…».
Pensa che quando iniziarono le operazioni di soccorso, le richieste di arruolamento in guardia costiera e la marina militare furono tantissime. Adesso sono in picchiata: andare a soccorrere era un valore che incentivava i ragazzi, era consono ai valori etici della marina, adesso lo è molto meno.
I soccorsi fatti con l’operazione Mare Nostrum della marina militare e le ONG erano molto interessanti, molto coinvolgenti. Suscitavano, specie nei giovani, interesse, empatia voglia di aiutare di partecipare.




Perché la presenza delle ONG poteva attirare l’attenzione e puntare i riflettori su attività e traffici che vogliono essere tenuti nascosti?
Guardando i numeri delle persone soccorse, mi chiedevo perché ci fosse tutta questa rabbia nei confronti di queste poche persone. Poi sono iniziati ad emergere gli accordi fatti con trafficanti di armi, di droga e di esseri umani. Queste cose sono saltate fuori grazie alla presenza delle ONG che ospitano a bordo giornalisti. Io credo che tutto questo sforzo per far sparire le ONG ha reso molto difficile, se non impossibile, documentare quello che è accaduto e che sta accadendo.
Ci sono dei video che mostrano i soldati della marina libica che sparano contro i migranti, ma questi video sono stati fatti dai giornalisti a bordo delle ONG, sono immagini di come anche noi siamo stati sequestrati, c’erano i giornalisti presenti.
Parli di accordi, di che tipo, quali?
Anche il giornalista di «Avvenire» Nello Scavo ha scritto di quel comandante della guardia costiera libica, coinvolto nel traffico degli essere umani, ricercato a livello internazionale che nel 2017 era seduto ad intavolare accordi con il governo italiano. Ci sono documenti che testimoniano i fatti, ma queste denunce non hanno nessun esito. È stato messo tutto a tacere, personaggi coinvolti nel traffico di essere umani, di armi… Poi c’è un altro filone, in cui compare l’ENI che fa funzionare le piattaforme petrolifere in accordo con l’agenzia idrocarburi libica, sotto la protezione gestita da famiglie di trafficanti libici. È evidente che gli accordi fatti a sostegno di tutto quello che sta accadendo vedono soggetti trafficanti di armi, di droga, di esseri umani, di petrolio.
Io credo che tutto questo sforzo per far sparire le ONG abbia reso molto difficile, se non impossibile, quel tipo di soccorso che comunque, in qualche modo, si riesce a fare rispettando gli obblighi di legge al riguardo oltre che etici.
Tu all’inizio sei stato definito un eroe, poi ti sei sentito accusare di complicità con trafficanti del mare, come hai vissuto questo passaggio?
Io non mi sentivo proprio a mio agio con l’eroicizzazione, anche se è ovvio che quando ricevi applausi o compari sulla stampa hai il problema di gestire il tuo ego, da tenere a bada. Mi sentivo arrabbiato quando mi attaccavano, poi ho iniziato a preoccuparmi nel vedere come la manipolazione abbruttiva le persone, che diventavano cattive, che vivevano sotto la sensazione di una possibile invasione da parte dei migranti, e questa paura li rendeva ancora più manipolabili.
Questo mi ha spaventato, vedere chiaramente il sistema di potere nella sua capacità di manipolazione, la persona al bar di casa che prima mi applaudiva è la stessa persona che mi ha insultato perché crede che io sia un trafficante. Mi fa paura il potere in mano a queste persone che distruggono e modificano la realtà, che sono responsabili di omicidi, perché non soccorrere vuol dire condannare le persone a morte.
Per tornare alla domanda di come ho vissuto questo passaggio, io mi sono sempre mosso nei movimenti sociali sia di estrema sinistra che anarchici. Ciò mi ha aiutato a diffidare del potere stabilito e anche ad odiarlo. Quando poi sei in mezzo al mare, dove hai modo di pensare, vedi le cose con maggior chiarezza e ritrovo rinvigorita questa diffidenza e quest’odio.
Ritieni che la paura continuamente alimentata sia diventata il vincolo che regge la comunità e genera il rifiuto dell’accoglienza?
In effetti questa è la rappresentazione del disprezzo per la vita umana da parte del potere. La costante del sistema in cui viviamo è creare paura e la paura è facilmente gestibile. E poi la gente si stanca e non continua a lottare per appoggiare le ONG, che non sono neanche più argomento da prima pagina e nemmeno da bar.




È questo il frutto dell’assuefazione e del silenzio. Ciò si nota anche dai curriculum che arrivano, dopo sette anni non c’è molta gente professionista che fa richiesta, perché da una parte è caduto l´interesse e dall’altra tante persone hanno vissuto sulla loro pelle le difficoltà del soccorso, del vedere morire le persone e della lotta contro i governi che te lo impediscono, criminalizzandoti e distruggendoti, si sono dovute fermare per riuscire a riprendersi e sopravvivere in modo salutare. In passato le persone, i volontari volevano venire a fare l’esperienza di soccorrere, dedicarsi a ciò, nelle ONG, adesso invece non c’è molta gente che si propone.
Il tuo essere libertario come si esprime nella pratica dei salvataggi in mare? Ti sei trovato di fronte a delle contraddizioni?
Credo che le contraddizioni che si incontrano siano quelle che ti ritrovi nella vita di tutti i giorni. Ad esempio sono assolutamente contrario a qualsiasi forma di potere, però in questa esperienza mi sono ritrovato ad essere capo missione, comandante della nave, capo gommone etc. Penso che il soccorso sia in sé la rappresentazione del mutuo appoggio. Se io ad esempio esco con la barchetta e vedo che c’è qualcuno in difficoltà, debbo prestargli soccorso, senza chiedermi chi è, anche se magari conoscendolo gli starei lontano ma io devo soccorrerlo, e questo dovere nasce da di dentro, in modo naturale, non è qualcosa di imposto socialmente. La società attuale impone invece, spesso, l’indifferenza e la diffidenza. Lo stesso vale in montagna. Mi è piaciuto molto quello che ha detto una coordinatrice che avevamo a bordo, che le veniva la pelle d’oca nel vedere come persone che non si conoscono e che non hanno mai lavorato insieme riescono a salvare un sacco di persone mettendo in atto una operazione di soccorso altamente rischiosa e difficile, con un’alta probabilità di perdere la vita. E rimaneva stupita nel vedere come l’essere umano è capace di mettere da parte qualsiasi cosa e in quel momento esplode quella forza quasi naturale che è il mutuo soccorso, ed è una cosa bellissima.
Questo pensiero non è sempre condiviso da tutti, è una cosa che può nascere nell’emergenza?
La risposta nasce dall’emergenza, poi diciamo il pensiero razionale, intellettuale che deriva in parte anche da un posizionamento ha il suo peso. Certo, siamo tutte persone che hanno una loro collocazione politica, io ho avuto problemi anche grossi a lavorare con certe persone, gli stessi problemi che si potrebbero trovare anche in un centro libertario se si mettono in atto degli atteggiamenti autoritari che non c’entrano. Poi ho la fortuna che in questa situazioni ci sono tante persone che hanno la mia linea di pensiero libertario, magari inconsapevolmente e lo scoprono in quella situazione, confrontandosi con la realtà.
La cosa bella è che non l’hanno elaborato razionalmente, ma si trovano a chiedersi cosa significhi essere libertari e chiarirsi nella pratica del mutuo soccorso quotidiano, e questa idea dà ulteriore senso alle cose che si fanno.
E in questa buia e liquida distesa, spazio infinito senza confini, in questa immensa lastra che cela il dramma di un mondo senza vergogna, che non vuole vedere migliaia di persone disperate morire senza un nome, in questo mare Riccardo ha deciso che il mestiere di salvare vite umane è il mestiere più bello che c’è. Grazie Riccardo, mare calmo e buon vento.


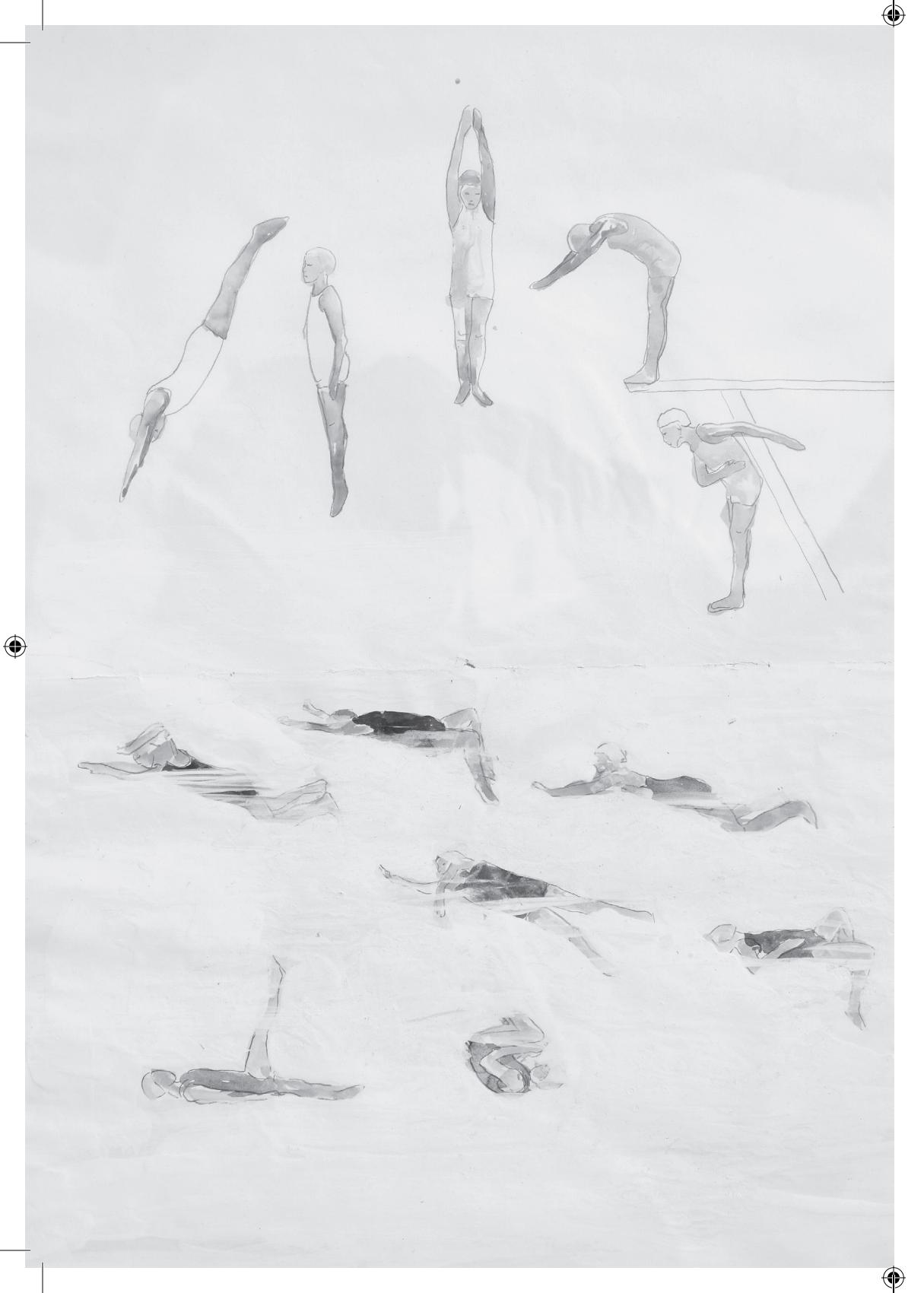

La produzione di soggettività nel lavoro contemporaneo: bullshit jobs, lavoro immateriale e la corrosione del carattere
Óscar del Castillo Sánchez
Molti degli studi realizzati negli ultimi decenni sul carattere del lavoro contemporaneo giungono a conclusioni simili, nonostante i diversi punti di vista: il lavoro oggi non sembra essere tanto un mezzo per oggettivarsi o per costruire un’identità personale, quanto un’attività spesso debilitante, che induce al consumo di merce e favorisce soggettività funzionali al sistema. Il necessario cambiamento storico che la situazione attuale richiede avrà invece bisogno di identità solide e di un «pensiero forte» in un mondo che si sostiene su processi ugualmente forti.
Negli ultimi decenni è comparsa una copiosa bibliografia dedicata ad esaminare criticamente le caratteristiche delle forme di lavoro sorte dopo la crisi del modello di produzione fordista. Buona parte di queste analisi si occupa non tanto della dimensione economica dei nuovi lavori, bensì delle conseguenze che essi hanno sulla psiche del lavoratore. In base alla presenza del tema psicologico in questi studi, si direbbe che c’è qualcosa negli impieghi attuali che concerne la questione spirituale molto di più che nei lavori del passato. Per esempio, secondo Richard
Sennett, la flessibilità che si esige al lavoratore o la sua costante esposizione al rischio, spesso associate ai lavori in voga, deteriorano il suo benessere animico e danno origine a quello che questo autore ha denominato «corrosione del carattere» (Sennett 2004).
Buona parte di queste analisi si occupa non tanto della dimensione economica dei nuovi lavori, bensì delle conseguenze che essi hanno sulla psiche del lavoratore



Maurizio Lazzarato, appoggiandosi su alcune delle analisi di André Gorz per quanto riguarda la progressiva smaterializzazione dei lavori, mostra come il proposito di ciò che denomina «lavoro immateriale» non consiste più nel produrre oggetti tangibili, bensì nella produzione di soggettività, in primo luogo della soggettività del proprio lavoratore (Lazzarato 1996). D’altra parte David Graeber ha rivelato come nella nostra epoca una parte significativa degli impieghi consista di attività non necessarie che il sistema crea per ridurre il livello di disoccupazione, nell’ambito pubblico o nel privato, come una forma
David Graeber ha rivelato come nella nostra epoca una parte significativa degli impieghi consista di attività non necessarie che il sistema crea per ridurre il livello di disoccupazione, nell’ambito pubblico o nel privato, come una forma di reinversione incomprensibile
di reinversione incomprensibile in una logica produttivista. In molti casi la sua inutilità, apparente o reale, ha importanti conseguenze psicologiche per il lavoratore (Graeber 2018). Ciascuna di queste analisi rileva aspetti particolari del lavoro contemporaneo; alcune sono più attuali di altre. Sennett pubblicò la sua opera a fine anni Novanta, e possiamo dire che le forme di lavoro sono cambiate sostanzialmente da allora. Alcune riguardano certi lavori più in una logica produttivista Le nuove «tecnologie di
di altri: non tutti i lavori immateriali sono automaticamente bullshit jobs né provocano necessariamente un deterioramento della personalità. In altre occasioni le questioni coincidono: il «lavoro del cavolo» è spesso un lavoro immateriale e di solito implica ciò che si può chiamare «corrosione del carattere». Spesso queste dimensioni compaiono nei lavori contemporanei in diverse misure, interagendo in modi anche complessi. Ma nonostante le loro diversità, tutte hanno un effetto soggettivo simile: quello di generare soggettività affini al sistema produttivo e ostacolare quelle distanti dal sistema.
La corrosione del carattere
Per quanto riguarda le posizioni di Richard Sennett, abbiamo anticipato alcune delle sue idee sull’effetto che hanno sull’individuo le condizioni di lavoro attuali. La denominata «corrosione del carattere», il deterioramento psicologico a cui portano spesso le nuove forme di lavoro, si può considerare come un altro aspetto di quello che Kenneth Gergen identificò come il «sé saturato», quell’umore particolare suscitato dalle «tecnologie della saturazione» tipiche della nostra epoca. Questo soggetto «multifrenico», diviso tra interessi, opinioni e tendenze spesso in conflitto fra loro, deriva dall’esposizione alle molteplici influenze dei diversi mezzi di comunicazione, della rete crescente dei nostri contatti sociali o come conseguenza della frammentazione delle società contemporanee. Queste influenze, spesso incoerenti e disconnesse tre loro, spingono il sé in direzioni diverse e lo mantengono in tensione costante. Il «sé autentico» della modernità, dotato di caratteristiche riconoscibili e di un’identità stabile, solida, «genuina», scompare. Le nuove «tecnologie di saturazione» creano una perso-
nalità frammentaria, volubile, che non riesce a intraprendere progetti a lungo termine; creano soggetti malleabili, proprio ciò di cui ha bisogno un mercato del lavoro che premia la disposizione del lavoratore a piegarsi alle esigenze dei flussi di capitale. Queste condizioni impediscono la costruzione di un’identità permanente, cosa che invece favorisce un lavoro fisso. Di fronte al tempo frammentato della nuova economia, l’attenzione rimane para-
saturazione» creano una personalità frammentaria, volubile, che non riesce a intraprendere progetti a lungo termine; creano soggetti malleabili, proprio ciò di cui ha bisogno un mercato del lavoro che premia la disposizione del lavoratore a piegarsi alle esigenze dei flussi di capitale



lizzata sul momento presente. Risulta impossibile consolidare il carattere in narrazioni durature. L’esposizione continua al rischio può, allo stesso modo, erodere la nostra sensazione di possedere una personalità definita (Gergen 2006). Le teorie di Sennett e Gergen arrivano quindi a confluire: le tecnologie della saturazione collaborano con il sistema nella misura in cui promuovono personalità affini ai lavori che la produzione reclama. Il lavoro di formazione della soggettività iniziato dalle tecnologie della saturazione continua quindi sul posto di lavoro. Entrambi collaborano quindi alla creazione di un nuovo tipo di persona.
Una persona che, tra l’altro, deve risultare adeguata sia per il lavoro nella nuova economia sia per il consumo dei «beni» che produce. Poiché il lavoratore deve diventare anche consumatore, come osserva Andrè Gorz1 . L’industria dei beni di consumo – o di consolazione, sarebbe il caso di dire - è un complemento necessario ad un lavoro in cui risulta impossibile affermarsi come soggetto e in cui è impossibile trovare reali soddisfazioni. Un lavoro che genera frustrazione, incertezza e timore verso il futuro e porta a cercare consolazione nella merce.
Fu sempre Gorz a sottolineare la qualità immateriale del lavoro contemporaneo. Un lavoratore attualmente non si occupa quasi mai di produrre oggetti tangibili. L’automatizzazione relega l’operaio al ruolo di mero supervisore/spettatore di un processo che fondamentalmente non dipende da lui (Gorz 1995). Non servono più le sue abilità, le sue conoscenze, la sua esperienza, poiché deve intervenire solo quando la macchina sbaglia, e anche in quei casi interviene secondo determinati protocolli, senza grande margine di iniziativa. Come ci racconta Gorz, a fine giornata, quando il lavoratore lascia il suo posto, si chiede in cosa ha investito il suo tempo e non trova nessuna risposta tangibile. L’artigiano che compone oggetti ad esempio a fine giornata ha un risultato concreto della sua attività: un oggetto che mostra l’impronta del suo autore, una presenza tangibile che incarna il pensiero e l’estro di chi l’ha creato. Il lavoratore immateriale, invece, non ha la possibilità di lasciare la sua impronta nel mondo. Il suo tempo sembra trascorrere invano, senza che i suoi sforzi diano risultati visibili2 .



1 Gorz sottolinea quest’idea varie volte nella Metamorfosi del lavoro: «Un modello di organizzazione fondato nella suddivisione funzionale dei compiti non può quindi fare appello né alla coscienza professionale né allo spirito di cooperazione dei lavoratori. Inizialmente deve ricorrere alla coercizione (…) È possibile ridurre la coercizione se si riesce a motivare i lavoratori con dei ‘regolatori incitanti’ non possono quindi offrire, nel quadro perché si prestino di buon grado a (…) un lavoro che è impossibile amare (…) Questi regolatori d’incitamento nel quadro dei compiti suddivisi non possono quindi offrire altro che delle compensazioni fuori dal lavoro alle coercizioni, frustrazioni e sofferenze inerenti al proprio lavoro funzionale (…) La coercizione al lavoro non può essere attenuata se non quando: 1° la ricchezza sociale è sufficiente perché vengano offerte ai lavoratori delle compensazioni materiali, e 2° quando i lavoratori accettano di considerare il loro lavoro come un mezzo per procurarsi quelle compensazioni»…(Gorz 1995: 64-65).
2 Su questo argomento, osserva Aditya Chakrabortty a proposito della deindustrializzazione della Gran Bretagna: «Fabbricare cose provocava una gran soddisfazione (…) tra tutti quelli che offrivano dei servizi, che si trattasse dei banchieri locali con il loro credito; o degli uffici locali di design. Quando una nave veniva varata in [un’impresa di Newcastle] tutti i bambini della scuola locale andavano a vedere ciò che avevano costruito i loro genitori (…) risulta molto evidente che le ricompense promesse da questo futuro post-industriale non si sono concretizzate. Ciò che si è venduto come modernizzazione economica ha portato ad una decadenza industriale senza che nulla la sostituisse (…) La cultura qui è stata tradizionalmente di produzione, radicata in fabbricare cose e poi venderle. La rivoluzione de-industriale ha obbligato, nel nord-est e in altri luoghi, ad adottare una cultura consumista – comprare cose invece che fabbricarle» (Chakrabortty, 2011).

Lavoro immateriale
D’altra parte, Maurizio Lazzarato, nel suo importante saggio sul lavoro immateriale, analizza la progressiva intellettualizzazione degli impieghi. Una delle peculiarità del lavoro post-fordista consiste nella produzione non più di oggetti bensì di soggettività. Il suo rendimento si misura in emozioni, gusti, mode, maniere di percepire e di sentire, in forme di esistenza. Le attività di cura personale, le industrie pubblicitarie o dell’intrattenimento sono alcuni esempi di questa nuova produzione. Ma questo cambiamento della natura del lavoro esige un cambiamento corrispondente nella persona che lavora. Esige un nuovo lavoratore, come afferma Lazzarato, anche in quei ruoli tradizionalmente meno intellettuali, che oggi incorporano un elemento di relazio-
Non basta più prestare il proprio corpo, o essere attento, capace, abile. Bisogna prestare anche l’anima
ni pubbliche che in passato non avevano. Non basta più prestare il proprio corpo, o essere attento, capace, abile. Bisogna prestare anche l’anima (Lazzarato 1996: 134). In un certo senso, il lavoratore diventa un politico, poiché come sottolinea Paolo Virno, la produzione post-fordista ha
incorporato molti caratteri dell’azione politica, e il lavoratore, come il politico, deve «saper mettere in pericolo la salute della propria anima» (Virno 2003: 50)3 . E questo, come osserva Lazzarato, implica una nuova forma di totalitarismo.
Inoltre il lavoratore deve operare in un contesto comunicativo predeterminato unilateralmente dalla dirigenza (Lazzarato 1996: 134). L’ambiente lavorativo spesso costituisce una specie di comunità chiusa, caratterizzata, nello specifico, dall’utilizzo di un suo linguaggio: un repertorio di termini, concetti, strutture inferenziali che il lavoratore deve fare proprie per poter realizzare i suoi compiti. Il contesto lavorativo risulta essere un ambiente in cui si emettono e si ricevono continuamente messaggi elaborati secondo certe regole e modelli imposti. Il puro esercizio della comunicazione in questo ambiente istituisce, conferma e rafforza i concetti e le strutture inferenziali - ovvero i modi di pensare – impliciti in quel linguaggio. Il contesto in cui si passa la maggior parte del proprio tempo vitale esige l’aver assimilato delle forme comunicative: delle forme che hanno un contenuto ideologico che si contribuisce a trasmettere e perpetuare con la sola immersione in quell’ambiente. In questo caso ha luogo quello che, secondo Jürgen Habermas, succede nel mondo delle comunicazioni sociali: una produzione e riproduzione del (di un) mondo della vita (particolare) attraverso il mezzo linguistico (Habermas 1992). Si può immaginare come l’interiorizzazione e l’uso di tale strumento comunicativo per quaranta ora alla settimana abbia un effetto di conformazione sulla soggettività. E dato che il lavoro immateriale consiste soprattutto in attività comunicative, il suo effetto sarà ben più forte che negli impieghi tradizionali. Se il lavoro immateriale ha il compito di produrre soggettività, produce, in primo luogo, quella del lavoratore stesso nello svolgimento dei propri compiti. Il contesto lavorativo risulta essere un ambiente di educazione in valori e attitudini che esige la nuova economia: attraverso i compiti realizzati quindi, come indica Lazzarato, «la prescrizione e definizione di compiti diventa una prescrizione di soggettività» (Lazzarato 1996: 134), dell’impostazione politica che implica il compito, e anche del linguaggio e delle forme di comunicazione utilizzate nel suo svolgimento. E, come afferma Gorz, la progressiva perdita di contatto con il mondo materiale legata a questa smaterializzazione del lavoro, porta le persone ad avere sempre meno capacità di trasformare il proprio ambiente fisico. Sempre meno persone sono capaci di costruire cose con le loro mani. In questo modo si perdono delle abilità molto utili in una società in cui il lavoro salariato sarà sempre meno, e in cui la decentralizzazione impo-



3 Virno qui fa una parafrasi di un’espressione di Max Weber inclusa nel suo noto saggio sulla politica come vocazione (2001: 175).

sta da un prevedibile rincaro dell’energia richiederà la capacità di produrre localmente e in cooperazione - il lato positivo del lavoro immateriale, secondo Toni Negri e Michael Hardt risiede nella formazione generalizzata in tecnologie della soggettività, che si trasforma in un general intellect e di conseguenza in qualcosa di molto vicino alla proprietà collettiva dei mezzi di produzione (Negri e Hardt 2002: 273) –. Qualcosa di molto utile in una società con tempo per attività libere e di autoformazione che possano sfruttare queste conoscenze, attività i cui risultati si possono divulgare, condividere e possono acquisire un senso sociale grazie a delle reti di telecomunicazioni universalmente accessibili.
Il lavoratore deve svolgere compiti apparentemente inutili, a volte addirittura ridicoli, o rimanere semplicemente disoccupato.
La persona si sente superflua, incapace di dare un senso al suo lavoro, e ancora meno, di costruire un’identità attraverso queste attività
Bullshit jobs
I bullshit jobs, identificati da David Graeber nel libro omonimo, forse non si propongono espressamente di generare forme soggettive determinate, come succede invece nel lavoro immateriale. Ma non per questo i suoi effetti psicologici sono minori. Le testimonianze raccolte da Graeber di chi ha
sofferto le conseguenze animiche di questi impieghi ne sono la prova. Se da una parte prospettive tanto diverse come il marxismo o l’etica puritana considerano il lavoro come un mezzo perché l’io si oggettivi nei prodotti del suo lavoro, formi il suo carattere (Graeber 2018), o acceda alla condizione di cittadino (Gorz 1995), non sembra che i bullshit jobs permettano nulla di tutto ciò. Infatti in questi impieghi il lavoratore deve svolgere compiti apparentemente inutili, a volte addirittura ridicoli, o rimanere semplicemente disoccupato. La persona si sente superflua, incapace di dare un senso al suo lavoro, e ancora meno, di costruire un’identità attraverso queste attività. E, come succede con il lavoro flessibile, il bullshit job incita a consumare beni di consolazione (Graeber 2018) che, come sostitutivi alla bella vita, aspirano a compensare le frustrazioni provate. Troviamo qui di nuovo la relazione tra lavoro alienante e consumo del superfluo, la necessaria complementarietà tra il consumismo e la natura del lavoro contemporaneo.
Ma questo non è altro che uno dei modi in cui il bullshit job produce soggettività affini al sistema. Quando siamo occupati in attività che sappiamo inutili, che non ci permettono di sviluppare le nostre attitudini; nelle quali dobbiamo fingere inoltre che sono importanti e necessarie; quando perdiamo la metà del nostro tempo vitale in un contesto di falsità e ipocrisia consustanziale all’attività (Graeber 2018) e quando infine per sopportare la situazione ci diciamo che in fin dei conti «non è male» - ovvero quando ci convinciamo di quella che Sartre aveva definito «mala fede» (Sartre 1993: 91) – sembra evidente che tutto ciò avrà un effetto sulla soggettività e sull’identità. Il bullshit job ci costituisce quindi come soggetti – come succede tra l’altro per qualunque attività o qualunque esperienza, solo che questa lo fa in modo particolarmente distruttivo –.
Secondo una delle testimonianze raccolte da Graeber, un universitario suggeriva che la banalità e inutilità dei lavori che gli studenti devono realizzare all’università forse costituisce una forma di addestramento per la futilità dei futuri impieghi che troveranno. Su questa linea quindi il bullshit job si proporrebbe in maniera esplicita di costruire forme soggettive determinate. Ma l’idea si può estendere ai bullshit jobs in generale. Queste attività potrebbero costituire una specie di acclimatamento per la vita in un sistema in cui l’istituzionalizzazione totale riduce il cittadino alla paralisi4 ; per la vita in una società in cui si può agire solo in alcune direzioni guidate, che seguano percorsi predeterminati



4 Sull’istituzionalizzazione dell’esistenza vedi Gorz (1995: 69). Il tema viene trattato con maggiore profondità per esempio in Illich (1970).

– e spesso strumentalizzati – dai diversi poteri. Si può dire che alcuni dei bullshit jobs analizzati da Graeber hanno obiettivi simili a quelli dei lavori immateriali analizzati da Lazzarato. Non succede questo con i «ricucitori» o «barracaselle», invece sì con i «tirapiedi» o gli «sgherri». In questi lavori spesso si tratta di generare apparenze, che sia mettere in scena un’immagine di perizia o efficacia di un’istituzione, o di fingere un livello sociale o professionale che non si possiede (Graeber 2018: 63). Si tratta quindi di creare un immaginario – e quindi una soggettività – in un modo analogo a ciò che fa l’industria dell’intrattenimento. Non a caso, alcuni dei settori in cui più abbondano i «lavori del cavolo» appartengono all’industria pubblicitaria o cinematografica, come riferisce Graeber.
Industrie che, a detta di Lazzarato, costituiscono il paradigma del lavoro immateriale (Lazzarato 1996: 137); poiché, come ha segnalato Paolo Virno, la nuova produzione immateriale si basa sul modello dell’industria culturale (Virno 2003:54). Il proposito di questi lavori apparentemente inutili sarebbe, in un certo senso, quello di rappresentare «realtà» fittizie con l’obiettivo di creare falsa coscienza. Una cosa molto in linea con la società dello spettacolo (Debord 2009) e con l’importanza dell’immaginario nell’ipercapitalismo estetico (Lipovetsky e Serroy 2016) – un’importanza che, in definitiva, risulta dalla condizione immaginaria della merce, già svelata da Marx -. Questi lavori, nonostante la loro apparente inutilità e la sensazione di futilità che generano a chi li compie, sarebbero comunque funzionali al sistema. Non contraddicono la razionalità economica poiché non rispondono alla logica produttivista, dato che la loro logica è un’altra: quella della produzione spettacolare. In questo modo capiamo perché i tagli in officina vengano compensati da nuove spese in personale d’ufficio apparentemente non necessario. I reinvestimenti non vengono più destinati a migliorare i macchinari o le strutture, come in un regime di produzione. Vengono invece destinati a produrre immaginario; qualcosa che, nella nostra epoca, ha molto più peso. Di conseguenza questi lavori spesso non hanno proprio nulla di superfluo. Per una produzione basata sull’immaginario, risultano più convenienti rispetto a produrre oggetti tangibili. Cosa che non toglie che il lavoratore si senta in colpa di collaborare con l’inganno di altri o che deplori buttare via il suo tempo in attività del genere, come indicano alcune delle testimonianze raccolte da Graeber. D’altra parte Graeber segnala che è la paura di una rivolta popolare come quelle degli anni Sessanta a frenare la riduzione della giornata di lavoro mediante la ripartizione del lavoro. Mantenendo le persone occupate e remunerate si evita che «pensino» o «cospirino contro il sistema», un metodo già utilizzato dai signori feudali nel Medio Evo (Graeber 2013 e 2018). Mantenere gli individui in ambienti nei quali devono comunicare, comportarsi e a volte anche vestirsi in modi predefiniti, spesso spersonalizzanti, ha delle profonde conseguenze per l’identità personale e favorisce abitudini consumiste. Si può addirittura affermare che questi impieghi evitano effetti forse più negativi per il sistema. Come osserva Gorz, l’ozio offre l’occasione per praticare attività libere e autonome nelle quali si fa quel che si vuole e nelle quali si ottiene qualcosa di impossibile nel lavoro salariato: realizzare attività che costituiscono un fine in sé stesse e che quindi mettono in discussione la logica economica dominante.
Si tratta di attività in cui la persona si oggettiva nel suo prodotto, plasmando nella realtà materiale aspetti del suo essere, oggetti che mostrano i segni del tempo vissuto e goduto nella sua creazione; dei compiti che sfidano l’etica del lavoro e che, in conclusione, aiutano a costruire un’identità autonoma, e a dare senso all’esistenza. L’ozio, inteso in questo senso, può essere scuola di vita, di un’altra vita, che rifiuti il consumismo consolatorio, l’edonismo commercializzato o i divertimenti standardizzati. L’ozio offre un’occasione per coltivare delle forme soggettive che risultano incompatibili con le richieste del sistema: «Proviamo a pensare allo shock che sarebbe per la nostra società se la creatività, la convivialità, l’estetica e il gioco prevalessero sui valori di efficacia e rendimento legati al lavoro» (Gorz 1995: 233). Da qui il suo potere rivoluzionario.




Il soggetto debilitato e l’avvenire di un «nuovo Illuminismo»
Se l’esperienza del bullshit job per alcuni è molto negativa, per altri l’ozio imposto offre l’occasione di realizzare attività libere e autoaffermative
Gli aspetti del lavoro contemporaneo esaminati fin qui – il lavoro flessibile postfordista di Richard Sennett, il lavoro immateriale di Maurizio Lazzarato, i bullshit jobs di Graeber – nonostante
le differenze sembrano coincidere su qualcosa di cruciale: il loro effetto psicologico, cercato o no5 , è quello di produrre un soggetto passivo, senza desideri, impulsi o progetti personali; un io debilitato, incapace di costruire una narrazione forte di sé, di affrontare iniziative prolungate nel tempo. In ogni caso non si può dire che le condizioni sociali determinino la soggettività. La persona non sperimenta l’influenza della situazione come qualcosa di inevitabile. La realtà viene vissuta sempre come realtà imparata, interpretata, come qualcosa di cui il soggetto si appropria e che alla fine trasforma all’appropriarsene. Così spiegano alcune delle storie raccolte da Graeber. Se l’esperienza del bullshit job per alcuni è molto negativa, per altri l’ozio imposto offre l’occasione di realizzare attività libere e autoaffermative. Probabilmente queste verrebbero realizzate meglio fuori dal lavoro, ma in ogni caso è meglio rispetto ad un’attività alienante. Ma, come fa notare Graeber, c’è bisogno di un certo contesto culturale e vitale per riuscire a far fronte e a sfruttare questo tipo di situazioni; e le circostanze specifiche del lavoro non sempre lo permettono (Graeber 2018). Comunque si tratta di una circostanza negativa che, nel migliore dei casi, complica ciò che potrebbe altrimenti avere uno sviluppo completo.
In tutto ciò che abbiamo commentato, la nostra epoca rivela strane somiglianze con il mondo del Barocco. Come racconta José Antonio Maravall, le monarchie assolute del XVII secolo misero fine alle promesse di liberazione risvegliate dal Rinascimento per la paura di una rivolta popolare. Attualmente le politiche neoliberali hanno distrutto le aspettative create dalla social-democrazia, qualunque esse fossero. Il clima di pessimismo dominante ha poi dato luogo a temperamenti specifici: angoscia vitale, pathos esaltato, attitudini ciniche e disinganno (Maravall 2008). Oggi la razionalizzazione totale della vita, l’incertezza, l’ambiente di crisi perenne o i caratteri dei lavori attuali qui citati hanno delle conseguenze psicologiche analoghe.
La ragione illuminata mise fine al periodo barocco e al suo pecu-
liare temperamento. Forse oggi, allo stesso modo, possiamo provocare la venuta di un «nuovo Illuminismo» (Muñoz 2013: 27). Come indica Jacobo Muñoz ciò richiederà un pensiero forte in un mondo che si basa su processi ugualmente forti. Sarà necessario un io robusto, capace
di costruire narrazioni solide, durature e stabili. Non si tratta, osserva il professor Muñoz, di tornare al soggetto enfatico della modernità, un soggetto forse adatto agli impegni imperialisti, ma inopportuno nel mondo plurale di oggi. Si tratta di coltivare, di fronte alle «tecnologie della saturazione» un pensiero capace di forgiare identità autonome, di affrontare progetti a lungo termine e di metterli in pratica per avere una vita migliore. Da qui l’importanza di comprendere come le forme di lavoro del presente si oppongano alla costituzione di una soggettività forte; da qui l’importanza di scongiurare i suoi effetti per quanto possibile.



5 Su questo tema Graeber ci anticipa contro la tentazione delle teorie cospiratorie, sia nel suo libro del 2018 che nel suo articolo del 2013. Anche Gorz cita il carattere autoregolativo e non premeditato - almeno in origine - di questi processi (Gorz 1995: 53).

92 93
Bibliografia
- A. CHAKRABORTTY, Why doesn’t Britain make things anymore?, «The Guardian», 16 novembre 2011 (trad. it.: http://www.theguardian.com/ business/2011/nov/16/why-britain-doesnt-make-things-manufacturing)
- G. DEBORD, La sociedad del espectáculo, Doble J., Siviglia 2009 (trad. it.: La società dello spettacolo, Massari Editore, Bolsena (VT) 2002)
- K. GERGEN, El yo saturado. Dilemas de identidad en el mundo contemporáneo, Paidós, Barcellona 2006
- A. GORZ, Metamorfosis del trabajo, Sistema, Madrid 1995 (trad. it.: Metamorfosi del lavoro, Bollati Boringhieri, Torino 1992)
- D. GRAEBER, Trabajos de mierda.Una teoría, Ariel, Barcellona 2018 (trad. it.: Bullshit jobs, Garzanti, Milano 2018)
- D. GRAEBER, On the phenomenon of bullshit jobs, «Strike» n. 3, agosto 2013 (trad. it.: https://www.strike.coop/bullshit-jobs)
- J. HABERMAS, Teoría de la acción comunicativa. II Crítica de la razón funcionalista. Taurus, Madrid 1999 (trad. it.: Teoria dell’agire comunicativo. II. Critca della ragione funzionalistica, Il Mulino, Bologna 2017)
- I. ILLICH, La sociedad desescolarizada. Barral, Barcelona 1975 (trad. it.: Descolarizzare la società. Una società senza scuola è possibile?, Mimesis, Milano 2009)
- M. LAZZARATO, Immaterial labor, en P. Virno y M. Hardt (eds.), Radical Thought in Italy: A Potential Politics, University of Minnesota Press, Minneapolis 1996 (trad. it.: Lavoro immateriale. Forme di vita e produzione di soggettività, Ombre corte, Verona 1997)
- G. LIPOVETSKY, J. SERROY, La estetización del mundo. Vivir en la época del capitalismo artístico,Anagrama Barcelona 2016 (trad. it.: L’estetizzazione del mondo. Vivere nell’era del capitalismo artistico, Sellerio, Palermo 2017)
- J.A. MARAVALL, La cultura del Barroco. Análisis de una estructura histórica, Ariel Barcelona 2008
- J. MUÑOZ, Filosofía y resistencia. Intervenciones, Biblioteca Nueva, Madrid 2013
- A. NEGRI y M. HARDT, Imperio, Paidós, Barcelona 2002 (trad. it.: Impero, Rizzoli, Milano 2002)
- J.P. SARTRE, El ser y la nada. Ensayo de ontología fenomenológica, Losada, Buenos Aires 1993 (trad. it.: L’essere e il nulla, il Saggiatore, Milano 2014)
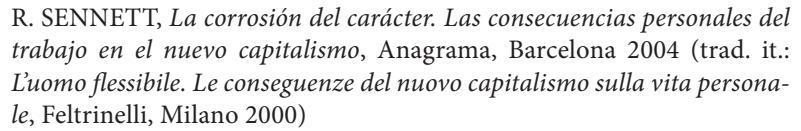
P. VIRNO, Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas, Colihue, Buenos Aires 2003 (trad. it.: Grammatica della moltitudine. Per una analisi delle forme di vita contemporanee, Deriveapprodi, Verona 2002)
M. WEBER, El político y el científico, Alianza, Madrid 2001 (trad. it.: La scienza come professione. La politica come professione, Einaudi, Torino 2004)
Traduzione di Valeria Giacomoni. Articolo originale pubblicato su Libre Pensamiento n°107, estate 2021, rivista della Confederación General de Trabajo (CGT). Ringraziamo l’autore Óscar del Castillo Sánchez e la redazione della rivista per la disponibilità e la collaborazione.





Mary Wollstonecraft (1759-1797)
Francesco Berti
Due sono i grandi temi, tra loro strettamente intrecciati, che attraversano la riflessione politica di Mary Wollstonecraft, straordinaria figura di pensatrice che ha anticipato il movimento femminista; moglie, alla fine della sua breve ma intensa esistenza, del primo teorico del pensiero anarchico, William Godwin e madre dell’autrice del Frankenstein, Mary Shelley. Nell’opera di Wollstonecraft, pensatrice in cui la tradizione radicale inglese si fonde con la cultura illuminista europeo-continentale, emergono, quali elementi distintivi, da un lato la difesa dei diritti dell’uomo e nello specifico l’elaborazione di una dottrina dei diritti delle donne, dall’altro il rapporto tra educazione e rivoluzione.
Formatasi intellettualmente intorno al gruppo dei rational dissenters, intellettuali inglesi radicali, tra i quali figuravano Richard Price, Joseph Priestley e appunto William Godwin, Wollstonecraft esordì come scrittrice alla vigilia della Rivoluzione francese, evento che scosse alle fondamenta la società d’antico regime, imprimendo una accelerazione senza precedenti, su scala dapprima europea e poi mondiale, allo sviluppo dell’idea e della pratica dell’uguaglianza, politica e sociale.
Non a caso durante la Rivoluzione francese presero piede clubs femminili e grazie ad essa notevoli figure di donne acquisirono visibilità nell’arena culturale e politica: Catherine Macaulay Graham, Helen Maria Williams, Marie-Jeanne Roland, Olympe de Gouges, più tardi Madame de Staël.
Proprio intorno al tema dell’uguaglianza, forse ancor più che a quello della libertà, si incentra il pensiero proto-femminista di Wollstonecraft, sostenitrice di una visione universale dell’eguaglianza e assertrice di una redistribuzione egualitaria della proprietà. Nel suo più importante scritto sul tema, Una riven-



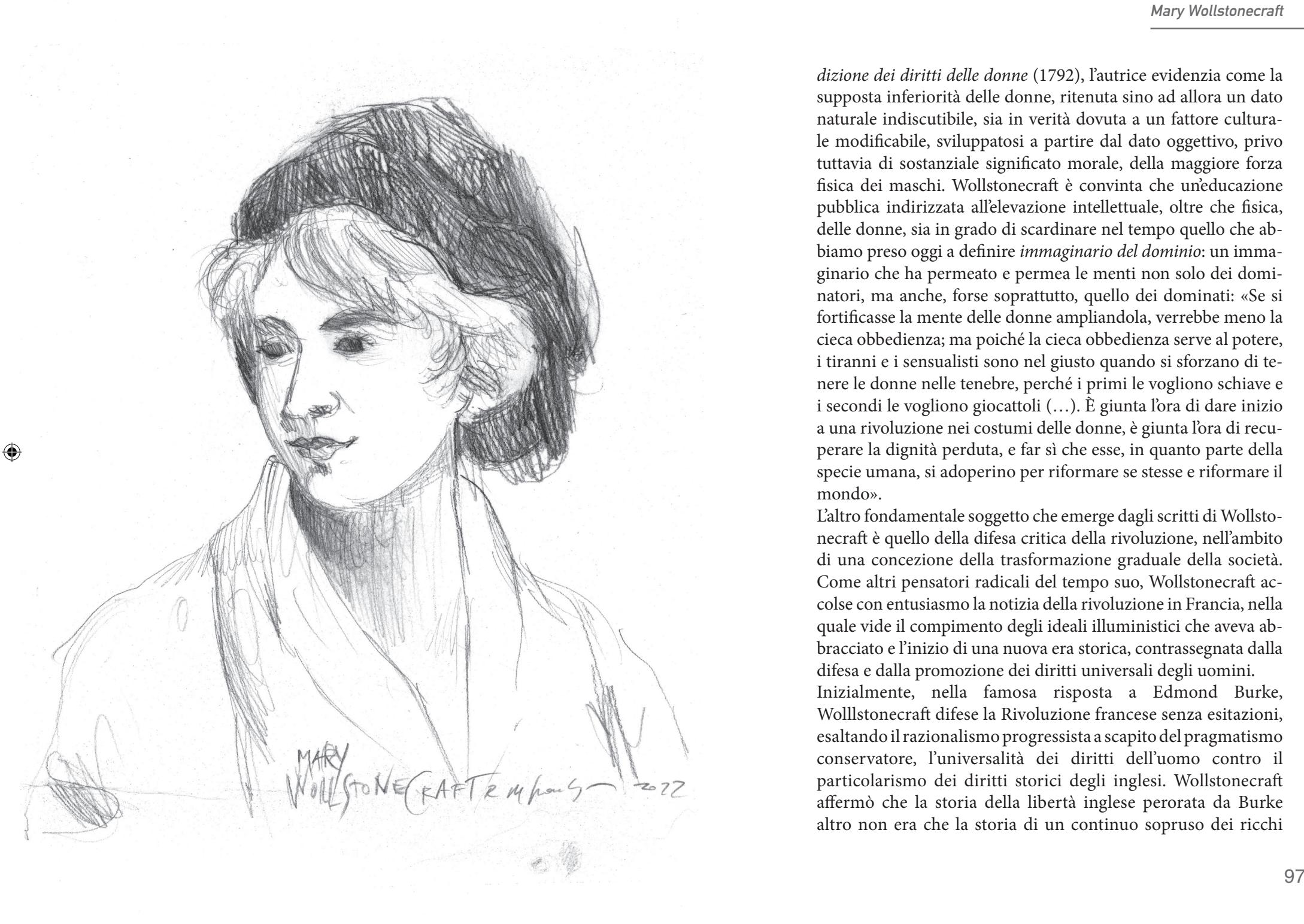
dizione dei diritti delle donne (1792), l’autrice evidenzia come la supposta inferiorità delle donne, ritenuta sino ad allora un dato naturale indiscutibile, sia in verità dovuta a un fattore cultura le modificabile, sviluppatosi a partire dal dato oggettivo, privo tuttavia di sostanziale significato morale, della maggiore forza fisica dei maschi. Wollstonecraft è convinta che un’educazione pubblica indirizzata all’elevazione intellettuale, oltre che fisica, delle donne, sia in grado di scardinare nel tempo quello che ab biamo preso oggi a definire immaginario del dominio: un imma ginario che ha permeato e permea le menti non solo dei domi natori, ma anche, forse soprattutto, quello dei dominati: «Se si fortificasse la mente delle donne ampliandola, verrebbe meno la cieca obbedienza; ma poiché la cieca obbedienza serve al potere, i tiranni e i sensualisti sono nel giusto quando si sforzano di te nere le donne nelle tenebre, perché i primi le vogliono schiave e i secondi le vogliono giocattoli (…). È giunta l’ora di dare inizio a una rivoluzione nei costumi delle donne, è giunta l’ora di recu perare la dignità perduta, e far sì che esse, in quanto parte della specie umana, si adoperino per riformare se stesse e riformare il mondo».
L’altro fondamentale soggetto che emerge dagli scritti di Wollsto necraft è quello della difesa critica della rivoluzione, nell’ambito di una concezione della trasformazione graduale della società. Come altri pensatori radicali del tempo suo, Wollstonecraft ac colse con entusiasmo la notizia della rivoluzione in Francia, nella quale vide il compimento degli ideali illuministici che aveva ab bracciato e l’inizio di una nuova era storica, contrassegnata dalla difesa e dalla promozione dei diritti universali degli uomini. Inizialmente, nella famosa risposta a Edmond Burke, Wolllstonecraft difese la Rivoluzione francese senza esitazioni, esaltando il razionalismo progressista a scapito del pragmatismo conservatore, l’universalità dei diritti dell’uomo contro il particolarismo dei diritti storici degli inglesi. Wollstonecraft affermò che la storia della libertà inglese perorata da Burke altro non era che la storia di un continuo sopruso dei ricchi


e dei potenti a danno dei poveri e dei deboli. In questa fase, Wollstonecraft rifiutava la tradizione in quanto espressione di una società diseguale.
Recatasi a Parigi nel dicembre del 1792, scioccata dalla radicalizzazione in senso terroristico e violento della rivoluzione, ebbe modo di rivedere ampiamente il suo giudizio sugli eventi francesi. Vicina ai girondini, radicalmente ostile ai giacobini, alla loro prospettiva illiberale e alla loro concezione autoritaria e terroristica della rivoluzione, Wollstonecraft recuperò molte delle critiche alla rivoluzione avanzate da Burke. Sviluppando una prospettiva che sarà successivamente resa celebre da autori liberali come Constant e de Staël, Wollstonecraft interpretò la Rivoluzione francese come una degenerazione di princìpi giusti, anticipando la visione del dérapage della rivoluzione che troverà la sua più compiuta elaborazione negli studi di François Furet. In questa prospettiva, la rivoluzione liberale e libertaria del 1789 venne contrapposta a quella giacobina e autoritaria del 1793.
Ma come spiegare e sottoporre a critica questo vero e proprio tradimento della promessa di liberazione determinatosi con lo sviluppo del processo rivoluzionario?
A tale proposito, la grande scrittrice sviluppò una serie di considerazioni davvero fondamentali, in una prospettiva di valorizzazione dei semi sotto la neve. Anticipando un punto di vista che verrà approfondito successivamente da pensatori come Tocqueville nel XIX secolo e da autrici come Hannah Arendt nel XX, Wollstonecraft ritiene che la Rivoluzione francese abbia in certa misura riprodotto, mutandone solo la forma - «sono cambiati i nomi e non i principi» - un modo di concepire i rapporti di potere e di praticare la politica tipico del regime che aveva abbattuto. Per esempio, ciò si è determinato in merito all’uso della violenza sistematica come metodo di governo: il popolo è stato portato a eccessi di violenza durante la rivoluzione, poiché è stato governato per secoli con la violenza. In altre parole, i rivoluzionari hanno risposto alla violenza del governo monarchico con gli unici mezzi che conoscevano e avevano sperimentato sulla loro pelle.
Poco importa qui evidenziare come alla Wollstonecraft sembri sfuggire in parte il fatto che la violenza rivoluzionaria, prodotto di una visione ideologica del mondo, presenti, sul piano qualitativo e quantitativo, caratteristiche nuove rispetto a quella esercitata dai poteri tradizionali. Piuttosto, vale la pena sottolineare il fatto che la pensatrice inglese interpreti ora la storia non solo come manifestazione del dominio, ma anche come realizzazione, sia pure parziale e imperfetta, della libertà. Di qui, come aveva insegnato Burke, la “superiorità” della rivoluzione americana, ispirata a una «sapienza concreta» e perciò capace di rinnovare la società nel solco della tradizione culturale e istituzionale inglese delle libertà, su quella francese, guidata prevalentemente dalla teoria. Errato le appare perciò il perfettibilismo rivoluzionario, la pretesa di rimodellare il mondo sulla base di una visione astratta, avulsa dalla realtà.
Wollstonecraft non arrivò tuttavia a rinnegare la rivoluzione in quanto tale, continuò anzi a sottolinearne il carattere esemplare, anche sul piano della pedagogia della libertà. Grande merito della Rivoluzione francese era stato infatti a suo avviso non solo quello di aver scardinato una struttura di potere arcaica e ingiusta, ma anche quello di aver operato «una rivoluzione nelle menti degli uomini». La rivoluzione ha reso edotti gli oppressi della loro oppressione, di cui perlopiù non avevano contezza: «i contadini non solo hanno perso la loro cieca devozione per i signori e si lamentano (…) di oppressioni che neanche definivano tali». Wollstonecraft giunse però alla convinzione che i veri e più duraturi cambiamenti sociali e politici non possano che darsi nel tempo, gradualmente, e siano il frutto di una continua sperimentazione, fatta di tentativi ed errori, di una selezione progressiva. Solo così i mutamenti sociali e politici potranno davvero essere profondi, perché saranno «il frutto graduale dello sviluppo di una nazione, maturati attraverso il tempo e non forzati da uno sviluppo innaturale».




Per approfondire
M. WOLLSTONECRAFT, Tempo di rivoluzioni. Sui diritti degli uomini e delle donne. Con un discorso di Emma Goldman, a cura di G. Vivian, Edizioni Spartaco, Napoli 2004
M. WOLLSTONECRAFT, Scritti sulla Rivoluzione francese, a cura di R.A. Modugno, Rubbettino, Soveria Mannelli 2007
M. WOLLSTONECRAFT, Sui diritti delle donne, a cura di B. Antonucci, Rizzoli, Milano 2008
M. WOLLSTONECRAFT, Lettere scritte durante un breve soggiorno in Svezia, Norvegia e Danimarca, a cura di M. La Torre, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011
W. GODWIN (a cura di), Postumous Works of the Author of “A Vindication of the Rights of Woman”, Joseph Johnson, London 1798

Martin Buber (1878 – 1965)
Mary Wollstonecraft
Furio Aharon Biagini
Si potrebbe dire che Buber ha fallito […], eppure i suoi sforzi sono stati immensamente fruttuosi. […] Si potrebbe dire che anche alcuni dei profeti ebraici fallirono; ma i loro scritti tormentano ancora l’umanità. Il successo non è una prova di virtù, neppure il fallimento. Ma se si mira abbastanza in alto, il fallimento è inevitabile. Kaufmann, Martin Buber: The Quest for You
Dalla sua morte, avvenuta nel 1965, sono passati quasi sessanta anni, ma ancora oggi Martin Buber è considerato uno dei maggiori rappresentanti del pensiero ebraico moderno, il filosofo che meglio di altri è riuscito a ricollegare il mondo uscito dal secondo conflitto mondiale con la visione dei profeti, da un lato, e la politica contemporanea, dall’altro.
Buber, intellettuale atipico, non classificabile, al tempo stesso socialista religioso, sionista fautore di uno Stato bi-nazionale arabo-ebraico nella Palestina mandataria, ebreo credente ma lontano da ogni ortodossia religiosa, spesso in contrasto con le idee dominanti, anche all’interno della sua stessa comunità, è soprattutto noto come l’autore di Io e tu, pubblicato nel 1923, in cui teorizza il principio dialogico come filosofia relazionale: un’interpretazione teologica della relazione tra sé e l’altro che metteva l’accento sull’assoluta necessità del dialogo con gli altri esseri umani e il «Tu» divino, che è il «tutto altro» e il «tutto vicino». Secondo Buber, l’uomo non può vivere senza dialogo, solo chi incontra un «Tu» può pienamente essere considerato un essere umano. La realtà umana è relazione, ma chi si addentra nell’universo del dialogo deve avere la consapevolezza del rischio che si assume esponendosi al rifiuto o al rigetto totale. Inoltre, la realtà





umana è relazione e il dialogo trova la sua compiuta manifestazione nel rapporto che si instaura fra l’Io e Dio.
Pensatore che coniuga diverse tradizioni alla base della cultura occidentale, la rivelazione biblica ebraica e la filosofia greca, Martin Buber nacque a Vienna nel 1878 in una famiglia di letterati ed ereditò una educazione rigorosa dal nonno Salomon, famoso erudito e talmudista. Dopo gli studi di filosofia a Vienna, Leipzig, Zurigo e Berlino riscoprirà il giudaismo attraverso il progetto sionista che, pensato in una ottica culturale e spirituale, per lui rappresenterà una opportunità e un rinnovamento del mondo ebraico come sosterrà nei famosi discorsi al circolo «Bar Kochbà» di Praga.
Nel 1924 otterrà l’insegnamento di Etica e scienze religiose ebraiche all’Università di Francoforte, divenendo così il primo docente ebreo di una disciplina universitaria tedesca consacrata al giudaismo. Con la salita al potere del nazismo, nel 1933 rinuncerà all’incarico e, nel 1938, lascerà la Germania per raggiungere Gerusalemme dove gli fu affidata una cattedra creata ad personam nel dipartimento di sociologia dell’Università ebraica. «Buber era una figura controversa. Evocava opinioni appassionate, spesso contrastanti sulla sua persona e sul suo pensiero», scrive Paul Mendes-Flohr nella sua biografia, Martin Buber: A Life of Faith and Dissent (2019). C’erano sempre lettori che diffidavano delle sue riflessioni sull’ebraismo, che erano provocatoriamente innovative e antitradizionali, e molti si chiedevano se fosse davvero un grande pensatore o solo un carismatico divulgatore di idee. Negli anni Venti, quando Judah Magnes, rettore della neonata Università Ebraica di Gerusalemme, tentò di fargli avere un posto come professore, la facoltà rifiutò più volte di assumerlo, non ritenendolo un vero e proprio studioso, come ricorda Dominique Bourel nella sua prefazione a Martin Buber: sentinelle de l’humanité (2015).
Agli inizi della Prima guerra mondiale risale l’elaborazione di Buber di un socialismo comunitario di ispirazione religiosa. Fondamentale il suo incontro agli inizi del 1900 con l’anarchico tedesco Gustav Landauer, l’amico fraterno, di cui sarà l’esecutore testamentario dopo il suo assassinio, che l’orientò verso il pensiero libertario. Con Landuaer, al quale fornirà un quadro del pensiero ebraico, condivideva il rifiuto di ogni sistema rigido e l’idea che il socialismo dovesse ispirarsi al giubileo mosaico come rovesciamento permanente: la rivoluzione come suo fondamento. Buber affermava che «la religione senza il socialismo è un’anima privata di corpo, e per conseguenza non è una vera anima, allo stesso modo il socialismo senza religione è un corpo senza anima e dunque non è un vero corpo» (Buber 2009). Nella sua opera troviamo la dimensione religiosa e quella antistatale, anche se su quest’ultimo punto si distingue dalla tradizione anarchica, poiché non sostiene l’abolizione dello Stato, ma solo la soppressione delle sue eccessive competenze. Ammiratore di Ferdinand Tönnies, che individuava due forme diverse di organizzazione sociale - la comunità (Gemeinschaft) un rapporto reciproco sentito dai partecipanti, fondato su di una convivenza durevole, intima ed esclusiva, e la società (Gesellschaft) dove gli individui vivono per conto loro, separati, in un rapporto di tensione con gli altri e ogni tentativo di entrare nella loro sfera privata viene percepito come un atto ostile di intrusione - studierà le relazioni comunitarie apolitiche e manifesterà un’attrazione profonda per le correnti mistiche e populiste. La sua avversione verso lo Stato crescerà nel periodo tra le due guerre e con l’avvento dello stalinismo (Shlomo, Michel 1992).
Dopo la fine della Seconda guerra mondiale il sentimento di simpatia verso l’Unione sovietica da parte degli ebrei di Palestina, in particolare da parte del movimento dei kibbutz, comprensibile dopo gli orrori della Shoah, fu percepito da Buber come un pericolo, quello cioè di vedere il comunismo russo «chiamato col maestoso nome di Mosca» imporsi come modello universale e al tempo stesso esercitare una egemonia su tutto il pensiero socialista. Da queste riflessioni, nel 1947, scaturirà l’opera Sentieri in utopia. Come scrive Michael Löwy, il titolo è importante poiché l’immagine che scelse per descrivere il cammino verso l’utopia non era quella di una ferrovia percorsa da una veloce locomotiva né quella di una autostrada su cui sfrecciavano moderne vetture,



ma più semplicemente quella di modesti sentieri, al plurale, lungo i quali singoli individui o gruppi di persone si incamminavano per valicare alte montagne o attraversare fitte foreste. Sentieri spesso inesistenti tracciati dagli stessi viaggiatori nel momento in cui avanzavano a tentoni in quei territori inesplorati (Löwy 2008).
Nel saggio, Martin Buber confronta il pensiero libertario, tra cui annovera l’anarchismo, per la radicalità della sua concezione rivoluzionaria, che consiste nel voler «sostituire lo Stato con la società», con quello di Marx e Lenin, per riabilitare alla fine la tradizione del socialismo utopista. Nel momento in cui lo scientismo occupava una posizione dominante nel pensiero sociale in particolare nelle correnti socialiste, tanto che il termine aveva assunto un significato unicamente negativo, polemico e «l’aggettivo ‘utopista’ era diventato l’arma più forte nella lotta del marxismo contro il socialismo non marxista, Buber rivalutava la tradizione utopica. Per lui, lontano dal corrispondere a una fase infantile della storia del pensiero socialista, l’utopia costituiva piuttosto un aspetto immanente di ogni volontà di progresso, ogni mente che pianifica è, in senso positivo, utopica. Il progresso scientifico non faceva scomparire l’utopia sociale di cui Buber riaffermava la dimensione moderna sottolineando che se essa nasce con la Rivoluzione francese, fili nascosti la legano a un passato lontano risalente all’escatologia antica.
In pagine illuminanti, Buber analizza l’ostilità e l’incomprensione dei comunisti verso i tentativi di realizzazione pratica dell’utopia socialista. Secondo lui, la Rivoluzione russa era fallita poiché i soviet erano stati concepiti da Lenin e i bolscevichi solo come strumenti del potere politico e non come l’embrione di una società nuova. Da qui la loro incapacità di comprendere il movimento dei soviet come di quello cooperativo. Ora, Martin Buber accorda un grande interesse all’esperienza storica delle comunità collettive, all’interno delle quali individua la volontà - caratteristica secondo lui dell’utopia socialista - di cercare di costruire la società libera del futuro. Se i vari tentativi utopici erano usciti sconfitti nel corso della storia, i kibbutz, i villaggi cooperativi ebraici in Palestina, gli




sembrarono, malgrado i loro limiti, se non un successo, almeno un «non fallimento» esemplare. Nel kibbutz vedeva una alternativa al socialismo sovietico, un esempio a cui dovevano guardare le società europee per ricostruire il loro tessuto economico e sociale dopo la catastrofe della seconda guerra mondiale. Naturalmente si rendeva conto dei problemi e delle contraddizioni dei kibbutz e vedeva il principale pericolo non solo nel mondo circostante, che rifiutava lo stile di vita delle comunità rurali, ma soprattutto nell’attrattiva che questi esercitava su di loro spingendole all’assimilazione. Come scrive Michael Lövy, oggi non possiamo che constatare la pertinenza di questi avvertimenti.
La riflessione sui kibbutz è importante, poiché era centrale anche nella discussione sul sionismo, Israele e il popolo ebraico. Buber aveva sottolineato l’importanza dell’idea messianica nel giudaismo e del kibbutz, come base della società utopica e redentiva del popolo ebraico. Egli insisteva che un insediamento ebraico centrale in Palestina avrebbe avuto senza dubbio un grande significato se avesse generato le uniche cose da cui si aspettava che emergesse l’assoluto: un ritorno e una trasformazione che producessero un cambiamento in tutti gli aspetti della vita. Il disagio di Buber nei confronti del sionismo crebbe man mano che la prospettiva di uno Stato ebraico diventava più reale e, anche dopo la nascita dello Stato di Israele, nel 1948, continuò a criticare le sue politiche e la sua leadership su molte questioni, incluso, in particolare, il trattamento riservato ai rifugiati arabi, diventando una spina nel fianco di David Ben-Gurion, allora Primo ministro. Buber non avrebbe rinunciato all’ideale sionista solo perché deluso dalla sua realtà. «Ho accettato come mio lo Stato di Israele, la forma della nuova comunità ebraica che è sorta», avrebbe detto a un amico. «Ma colui che servirà veramente lo spirito […] deve cercare di liberare ancora una volta la strada bloccata verso un’intesa con i popoli arabi». Naturalmente vedeva i pericoli di una politica secolare messianica che agiva ai limiti dell’etica e rifiutava una azione dialogica, che per lui avevano un fondamento religioso. I timori di Buber diventarono reali con la radicalizzazione di una parte considerevole del sionismo religioso a partire dalla Guerra dei sei giorni.
Oggi molti degli odierni scenari politici, in particolare nel Medio Oriente, originano da politiche religiose messianiche e dall’azione di differenti gruppi fondamentalisti radicali religiosi. La strada indicata da Buber per affrontare questi problemi è più attuale che mai, l’unica per salvare l’uomo strappandolo dalle fauci del principio politico.
Bibliografia
·Selezione di scritti di Martin Buber
Israele e Palestina. Sion: storia di un’idea, Marietti, Genova 2008 Una terra e due popoli: sulla questione ebraico-araba, Giuntina, Firenze 2008 Sentieri in utopia: sulla comunità, Marietti, Genova 2009 Il chassidismo e l’uomo occidentale, Il nuovo Melangolo, Genova 2012 Rinascimento ebraico: scritti sull’ebraismo e sul sionismo (1899-1923), Mondadori, Milano 2013
Umanesimo ebraico, Il Melangolo, Genova 2015
·Studi
D. BOUREL, Martin Buber: sentinelle de l’humanité, Albin Michel, Paris 2015 E. LÉVINAS, Martin Buber, Castelvecchi, Roma 2014
W. KAUFMANN, Martin Buber: The Quest for You, in Discovering the Mind, vol. 2: Nietzsche, Heidegger, and Buber, McGraw-Hill Book Company, New York 1980
S. SHLOMO, B. MICHEL, Martin Buber, Proudhon et la «vérité de demain», in Proudhon, l’éternel retour, «Mil neuf cent», n. 10, 1992, pp. 86-93. M. LÖWY, Messainisme e utopie dans la pensée juive européenne entre les deux guerre, in Europa e Messia: paure e speranze del XX secolo in eredità, «B@belonline/print, Rivista semestrale di filosofia», n. 4, 2008, pp. 189-197 M. LÖWY, Redenzione e utopia: figure della cultura ebraica mitteleuropea, Bollati Boringhieri, Torino 1992
P. MENDES-FLOHR, Martin Buber: A Life of Faith and Dissent, Yale University Press, New Haven; London 2019



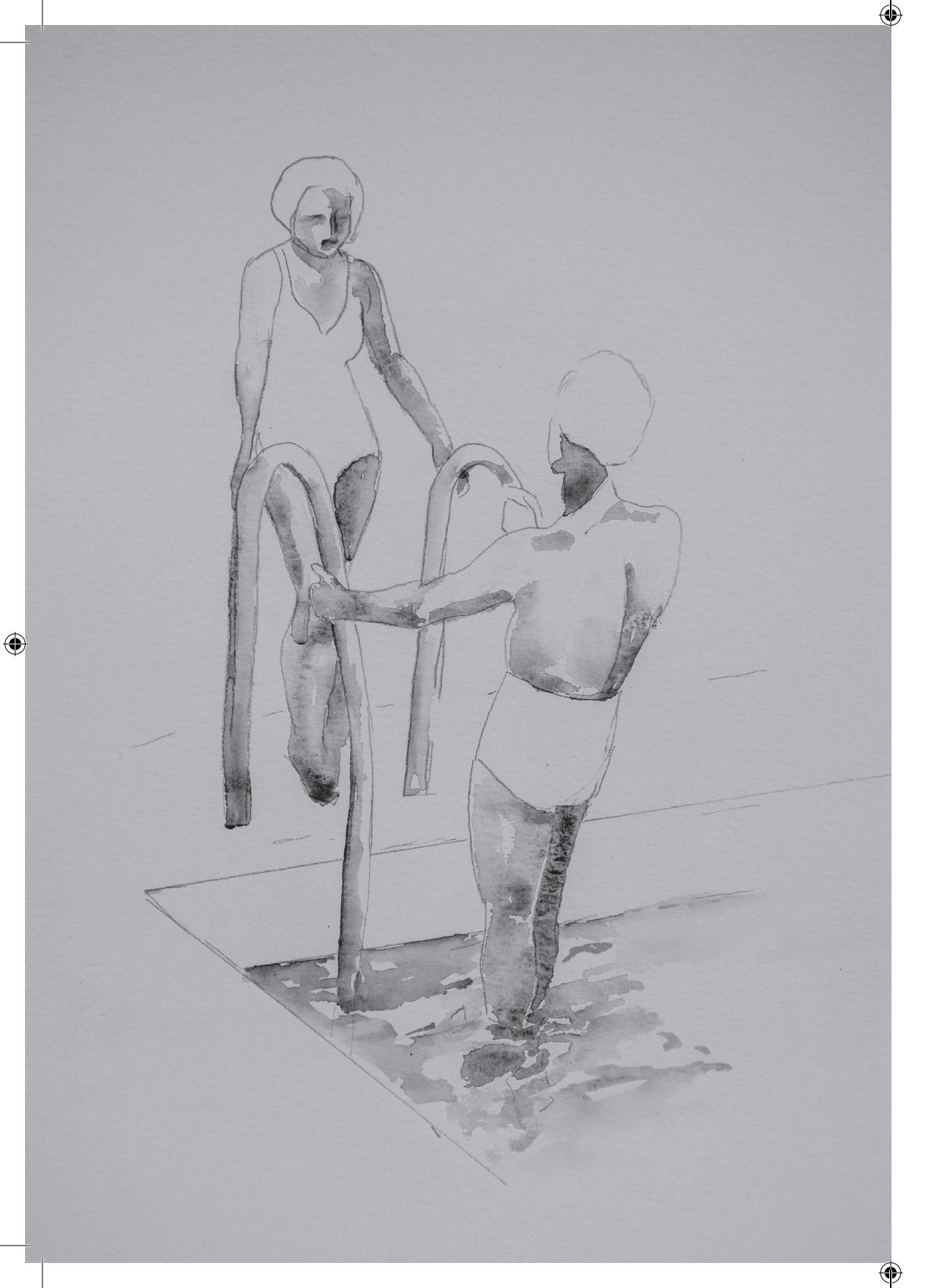

1968: Suoni e visioni di un’esplosione inevitabile
Felice Liperi
«L’anno che ha fatto saltare il mondo», come ha definito il ‘68 lo scrittore Mark Kurlansky, in Italia non è stato solo l’anno di «Azzurro», «Delilah» e «Contessa», ma un torrente impetuoso di suoni spesso lontani dalla dimensione melodica. Un’ondata non casuale cresciuta nel biennio ‘66-‘67 in cui montava nel nostro paese l’impegno politico e la conquista dello spazio pubblico da parte delle nuove generazioni. In quegli stessi anni, invece, sul fronte statunitense, dopo l’ubriacatura del folk politico il mondo della musica sembrò aver trovato nell’underground e nella nuova canzone d’autore la parola chiave dell’innovazione creativa. Una scelta ispirata dai sogni cupi ed estremi del gruppo rock «The Velvet Underground» attivo nelle viscere newyorkesi sotto la guida artistica di Andy Warhol. La formazione dei «Velvet», già nella struttura, si presentava fuori dagli schemi, guidata, com’era, da una ex modella e un gruppo di performer che aveva trovato nel rock il messaggio ideale per mettere in pratica un progetto denso di invenzioni sonore e immagini di morte, sesso e alienazione, lanciato con il celebre show «Exploding Plastic Inevitable» che nel 1966 a New York offriva chiare indicazioni sulla prospettiva creativa elaborata da Andy Warhol. Dai sotterranei urbani di New York emergeva un messaggio aspro ma fortemente innovativo che avrebbe influenzato anche l’Italia che, in perfetta coincidenza di tempi, sempre nel biennio ‘66-‘67, incrociando arte moderna e musica, dava vita a un progetto «underground» tutto italiano. Come Warhol, il pittore Mario Schifano, nella veste di sperimentatore di nuovi linguaggi, era l’ispiratore di «Dedicato a» un album realizzato da un gruppo psichedelico, che in suo onore aveva preso il nome di «Le Stelle» di Mario Schifano, dove si mostrava una condivisione di sentimenti e gusti, probabilmente determina-



ta dalle frequentazioni della «Factory» di Warhol e dell’ambiente rock più innovativo da parte di Schifano. Anche le esibizioni del gruppo romano ricalcavano perfettamente le formule multimediali proposte da Warhol negli Stati Uniti: celebre quella del 1967 presso la sede romana della compagnia teatrale di Dacia Maraini dove il concerto delle «Stelle» accompagnava la proiezione di un lungometraggio di Schifano. Ma è curioso come questa dimensione multimediale abbia proposto, sempre in quell’anno, numerosi appuntamenti importanti e totalmente nuovi per la realtà italiana, abituata a manifestazioni come Il Cantagiro, attiva dal 1962 al 1974, utile a far evadere la musica leggera dai tradizionali luoghi di ascolto e ad avvicinare i divi al pubblico ma non a esprimere i valori sovversivi del rock. Non a caso alcuni passaggi, talvolta fugaci, di stelle, queste sì sovversive, come Jimi Hendrix, Rolling Stones, Pink Floyd passarono quasi inosservati o come fenomeni di costume. L’eccezionalità di questi appuntamenti sta nel fatto che dopo il passaggio dei Beatles nel 1965 nessuna grande rockstar era passata per l’Italia, quindi anche solo l’eco degli assolo di Hendrix nel suo tour italiano del ‘68, artista di potenza straordinaria non solo per la qualità tecnica ma anche per il portato creativo in senso assoluto, ebbero un’eco ridotta, anche se fondamentale per i futuri cambiamenti. Così anche i servizi dedicati al viaggio in India dei «Fab Four» del febbraio'68, lasciarono forti sensazioni sulle generazioni emergenti. È come se grazie a questi concerti avvenisse una nuova sprovincializzazione del nostro paese storicamente lontano dal grande giro dei concerti e si proponesse come piccola anteprima di ciò che sarebbe accaduto negli anni ‘70 con l’era dei grandi concerti. Eventi e manifestazioni, poi seguiti da una serie di altri appuntamenti in pieno ‘68, che confermano come l’anno della «rivoluzione» non può essere appiattito solo su una dimensione musicale strettamente politica e militante. Se, infatti, i progetti di musicisti impegnati come Giovanna Marini, Paolo Pietrangeli, Ivan Della Mea, Michele Straniero si rivelarono fondamentali per il loro supporto funzionale al movimento di protesta giovanile e operaio, la dimensione creativa più innovati-
va di quell’ anno si presentava, oltre che nell’underground, nella canzone d’autore, territorio che pure dal clima e dalla sensibilità degli anni ‘60 aveva preso ispirazione. Un mondo di mezzo fra canzone leggera e ballata folk che della prima utilizzava la forma e della seconda il contenuto dal quale emergeva la dimensione più matura della canzone d’autore, fino a far azzardare che in Italia il ‘68 sia stato proprio l’anno zero della canzone d’autore intesa come opera matura e non più solo messaggio dell’attività di musicisti. Ciò anche per ragioni tecnologiche, dato che proprio in quell’anno l’album soppiantava il singolo a 45 giri perché gli autori cercavano un mezzo più ampio per esprimersi come se il «racconto breve» anche se in musica non fosse più sufficiente a raccontare i sentimenti più profondi. Così anche il mondo della musica voltava pagina, e se la canzone politica proponeva nuove narrazioni sociali presenti nelle piazze e nei luoghi di lavoro, i protagonisti del rock e della canzone d’autore cominciavano a utilizzare l’album per immaginare opere e visioni sonore molto più ambiziose. Protagonista di questa rivoluzione poetica è stato Fabrizio De André con due progetti particolarmente innovativi: «Senza orario senza bandiera» e «Tutti morimmo a stento». Il primo come LP che metteva insieme la poesia del poeta anarchico Riccardo Mannerini, rielaborata da Fabrizio De Andrè, e la musica del gruppo dei New Trolls, il primo grande gruppo rock italiano già da tempo fortemente influenzato dai lampi sonori portati nel nostro paese da Jimi Hendrix. «Tutti morimmo a stento» invece, era, un album tematico, dove De André proponeva un inno ai diseredati e a tutti i bisognosi di pietà, realizzato con la produzione musicale di Gian Piero Reverberi: «un inno agli antieroi ispirato alla poesia di Brassens e Villon. Ma anche Battisti capisce presto le potenzialità espressive dell’album come corpus unico e nel suo primo vero LP ‘Amore e non amore’, propone una solitaria riflessione sui drammi provocati dalla società dei consumi. L’idea dell’album monotematico si rivela un grande stimolo per la musica d’autore perché finalmente propone la canzone come arte popolare» (Liperi 1994: 15).


Così anche, proprio all’inizio dell’anno, Enzo Jannacci, uno di nostri autori più irregolari, lancia «Vengo anch’io no tu no», una canzone che aveva creato grande curiosità per la sua bizzarra struttura lirica e musicale. Scritta ancora con Dario Fo e da un romanissimo Fiorenzo Fiorentini effettivamente «Vengo anch’io no tu no» si presentava come un brano del tutto anomalo, trasgressivo e surreale, proposto con il tipico stile stralunato del cantautore. Per questo l’entrata nella classifica dei dischi più venduti di un cantautore così anticonformista, e per certi versi antimelodico perché più attento alle storie che alle musiche, rappresenta un segnale del cambiamento dei gusti del pubblico verso titoli caratterizzati da uno spirito non convenzionale. Anche se va ricordato che il brano per poter essere trasmesso da Radio Rai venne purgato dalla censura che fece tagliare l’ultima strofa perché troppo provocatoria e antipatriottica,
«Si potrebbe andare tutti in Belgio nelle miniere Vengo anch’io? No tu no a provare che succede se scoppia il grisù venir fuori bei cadaveri con gli ascensori fatti su nella bandiera del tricolor»
È lo stesso Jannacci a rivendicare la sua appartenenza a un mondo di autori diverso e indipendente che ha a cuore la vita dei più umili e diseredati come racconta presentando la canzone «la storia di questo poveretto che vorrebbe aggregarsi alla comitiva e viene inesorabilmente respinto non è meno amara di quella del barbone trasognato di ‘El portava i scarp del tennis’ o di quella del brav’uomo paziente […] de l’Armando» (Radiocorriere 1968: 52-53). Ma proprio ai primi del 1968, anche Giorgio Gaber con l’album «L’asse d’equilibrio» cominciava a costruire quel passaggio che l’avrebbe portato di lì a poco alla stagione del Teatro Canzone con Sandro Luporini e alla nascita del «Signor G». Titoli come «Una canzone come nasce», «Canta», «La vita dell’uomo», scritti insieme a Herbert Pagani nel 1968, entrano nell’album «L’asse di equilibrio» che Gaber presenta come «una specie di confessione, di esposizione sincera di quello che penso […] perché io sono in pericolosa sospensione in quanto presento canzoni molto pericolose per il gusto della gente abituata a canzoni normali» (Neri 2007: 36). Anche «canzoni pericolose» è un’espressione inimmaginabile fino a qualche anno prima quando le canzoni dovevano rassicurare e non denunciare o raccontare questioni attinenti allo sfruttamento, alla diversità, alla repressione. Ma è evidente che quell’anno simbolo aveva contribuito a far maturare una sensibilità nuova nella generazione dei cantautori che voleva utilizzare la canzone non più solo come strumento di intrattenimento ma per riflettere, pensare, raccontare. Certamente già dieci anni prima, nell’altro magico ‘58, in cui era emersa con Domenico Modugno la canzone d’autore poi sviluppata a Genova e Milano, gli intenti degli autori erano quelli di realizzare una canzone dai contenuti più poetici solo che in essa mancava quella coscienza politica che emergerà nel ‘68. Insieme a De André sarà Gaber il musicista che farà maggiore tesoro di questa stagione con l’arrivo del «Signor G» il 21 ottobre del 1970, maturato negli anni precedenti come racconta la moglie Ombretta Colli: «Non credo che la svolta si possa spiegare come una folgorazione […] Giorgio aveva intrapreso un cammino, a livello interiore, iniziato anche prima del ‘68. Poi, a partire dal ‘68-‘69, nel mondo era successo di tutto. Il maggio francese, le università occupate, le rivendicazioni operaie, le proteste per il Vietnam […] i giovani erano scesi in piazza […] c’era, ovunque e fortissima, l’esigenza di cambiare. Lo sentivano i giovani [… ed era ovvio che lo avvertisse anche Giorgio. Per la sua speciale sensibilità» (Neri 2007: 47-48).
Dopo anni di musica leggera, anzi leggerissima, si apre un capitolo fondamentale per la cultura italiana contemporanea che troverà nella lunga stagione del «Signor G» uno dei progetti più attenti e sensibili a mutamenti politici e sociali del secondo dopo guerra, in cui ci sarà spazio anche per i progetti rock di gruppi innovativi sul piano musicale e lirico come New Trolls, Stormy Six, Area, PFM, Banco e Osanna.



L’avvento del folk d’autore
Se, come abbiamo visto, la narrazione politica dei cantautori emersi dall’esperienza di «Cantacronache» e del «Nuovo Canzoniere Italiano» – le Marini, Ronchini e i Pietrangeli, Della Mea, Straniero, Bertelli, Assuntino - ha preceduto il ‘68, non si deve dimenticare come abbia contribuito al crescere di un canto importante coniugato con la canzone d’autore e il folk americano. Ne fu testimone il critico e musicista Leoncarlo Settimelli con il suo lavoro e le riflessioni presenti nel libro Il ‘68 cantato (e altre stagioni) (Settimelli 2008) nel quale racconta sentimenti e passioni di quel decennio. Particolarmente interessante il capitolo che Settimelli dedica agli Stati Uniti dove descrive il sentimento ambivalente che animava il popolo della sinistra nei confronti della nazione americana responsabile di molte crisi del dopo guerra, ma anche patria del grande cinema, di Woody Guthrie e Malcolm X, e, soprattutto del rock’n’roll. Così scrive Settimelli: «Nel 1968 riuscii a realizzare il sogno che nonostante tutto ciò che in quel momento gli Stati Uniti rappresentavano di negativo per tutti noi, era in cima ai miei desideri: andare negli Stati Uniti, andare da dove era venuta tanta musica che aveva contribuito alla mia formazione, dal rock and roll a Diana, da Glenn Miller al jazz freddo di Chet Baker […] da dove erano venuti film memorabili, come West Side Story e memorabili canzoni, ultime delle quali quelle di Bob Dylan» (Settimelli 2008: 34). La testimonianza di Settimelli è molto importante per fornire qualche chiarimento anche sul rapporto talvolta ambiguo e disinformato della sinistra tradizionale nei confronti della musica. Se, infatti, con grande difficoltà in quel mondo si accettava il repertorio della canzone folk americana, a causa di una censura automatica nei confronti di tutto ciò che proveniva dalla «nazione imperialista», in un altro momento del saggio Settimelli aggiunge: «A una manifestazione del partito cantai insieme con tutti gli altri. La parte musicale precedeva il comizio, poiché assicurava il crescere di un clima d’entusiasmo. Poi, davanti al microfono, fu la volta di Alicata e tutto sembrava finito lì. Ma il giorno dopo egli mi convocò nella sua stanza e mi disse con estrema durezza: ‘Io non posso vedere un mio redattore (allora era il direttore dell’Unità ndr.) con la chitarra in mano, hai capito? La rivoluzione non si fa con le vostre canzoni. Si fa con Mozart’» (Settimelli 2008: 28).
Confusione e ignoranza della politica nei confronti della canzone, confermate dal fatto che anche la carriera degli artisti legati al mondo della musica leggera abbia avuto un rapporto spesso superficiale con l’esplosione del ‘68, come racconta il cantautore e scrittore Gianfranco Manfredi: «A ben vedere, la musica leggera incrocia il Sessantotto nel 1967, l’anno del disperato gesto anti-Festival di Luigi Tenco, l’anno in cui per la prima volta si sente pronunciare in canzonetta la parola Vietnam (‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’ canzone di Migliacci - Lusini portata al successo da Gianni Morandi) […] Si poteva supporre che dopo simile annata quella successiva sarebbe stata un diluvio di impegno e rinnovamento. Non fu così. Quali sono allora i brani del Sessantotto in questo 1968 restaurativo della canzonetta? Anzitutto ‘Visioni’ dei New Trolls, primo e unico esempio di psichedelico italiano, con tanto di chitarra suonata coi denti e ugola ai confini della realtà, brano destinato a restare cult nella storia del pop di casa nostra. Ma il vero segno del tempo lo marca Enzo Jannacci con ‘Vengo anch’io no tu no’, subito doppiato da ‘Ho visto un re’. Quando, in pieno sessantotto, ‘Vengo anch’io no tu no’ di Jannacci-Fo scalò le vette della classifica, il militante medio del Movimento studentesco si sentì finalmente vendicato. A chi se non a lui, si era sempre risposto: No, tu no?» (Manfredi 1988: 111-112).
Caso tutto diverso e originale è quello di Francesco Guccini, folk singer capace di mantenere un forte legame con le generazioni cresciute nel decennio dell’impegno in una dimensione però più autoriale e non strettamente militante dove la musica acquista sempre maggior spessore: «Ho cominciato, come molti altri




all’epoca, guardando alla Francia, i modelli erano Brel, Brassens, poi è arrivato Dylan e con lui un modo diverso di rapportarsi alle cose del mondo e della musica […] Dylan fu il primo segnale. Poi cominciarono ad arrivare le notizie degli studenti di Berkeley che si battevano contro la guerra in Vietnam, ed anche per noi le cose cambiarono. Ma già prima del 1968 cantavamo cose importanti, io avevo scritto ‘Auschwitz’, ‘Noi non ci saremo’, ‘Dio è morto’ che nascevano sull’onda del lavoro di Dylan. Mi ricordo che ci fu una copertina di Time dove ci si chiedeva se Dio era morto […] insomma erano anni in cui veniva avanti una nuova ideologia proprio sulla ‘morte di Dio’. Così io presi spunto dalle nostre discussioni e da quella copertina per fare una canzone. Avevo due punti di partenza ‘Urlo’ di Allen Ginsberg e una mia poesia, intitolata ‘Le tecniche da difendere’, versi in cui si parlava di abbandono generazionale […] Quando la scrissi non mi resi conto di quello che la canzone aveva dentro, non mi resi conto subito che esprimeva davvero una cultura, un modo di pensare che all’epoca coinvolgeva una gran parte del mondo giovanile […] i temi che trattavo erano certamente un fatto generazionale, io lo sentivo così. Ci sentivamo diversi, volevamo esserlo, vivevamo in una maniera che non era quella degli ‘altri’» (Assante 1994: 13-15).
L’intervista è particolarmente preziosa anche per vedere come un artista che si muoveva nell’ambito della canzone d’autore valutava il lavoro dei protagonisti della canzone politica, proponendo un raro scambio fra due mondi così vicini per tempi e sensibilità, ma lontani sul piano della comunicazione. A proposito del confronto con la canzone politica Guccini aggiunge: «Mi sembrava di fare cose più quadrate, ero convinto di fare di più di quello che faceva Pietrangeli, ‘Contessa’ era troppo facile, non mi sembrava la realtà. Io ero d’accordo con Pasolini sui fatti di Valle Giulia. Però le canzoni politiche sono state importanti, ce ne sono alcune che mi hanno segnato, ma me ne sono accorto dopo, addirittura con un certo stupore». Però «La locomotiva», il suo brano più celebre, del 1972, divenne invece il prototipo di una canzone «politica» dal volto nuovo, legata e ispirata a un repertorio antico: «La locomotiva - racconta ancora Guccini - nasce facendo il verso alle canzoni anarchiche di Pietro Gori. All’epoca si suonava molto con gli amici e avevamo un grandissimo repertorio di canzoni anarchiche. ‘La locomotiva’ […] per me non è mai stata una canzone politica tout court, ma il valore che dai tu a una canzone non coincide sempre con quello del pubblico. È anche una canzone popolare, ne ha lo spirito. È stato un momento straordinario, animato da un entusiasmo incredibile, una gran voglia di fare cose nuove» (Assante 1994: 15-18).
C’è poi un altro aspetto da ricordare del lavoro e del ruolo di Francesco Guccini in questa fase della canzone e dell’impegno, quello di Guccini autore «colto» capace di tenere insieme melodia, poesia e letteratura che, infatti, nel 1992 riceverà il Premio Montale per la canzone. Un riconoscimento che rappresenta una rara eccezione di quella che un attento studioso del cantautore emiliano come Paolo Jachia definisce «cultura del disprezzo nei confronti di un’arte, quella della canzone, che invece, come dimostra il valore e la ricchezza dell’opera di Guccini, nulla ha da invidiare per altezza di risultati contemporanei ad altre sue più fortunate sorelle, dalla poesia al romanzo al cinema. Nelle canzoni di Guccini possiamo infatti riconoscere un fortissimo influsso della poesia novecentesca italiana – da D’Annunzio e Pascoli a Gozzano e Montale – che si combina e si armonizza con le tradizioni degli chansonnier e degli esistenzialisti francesi con quelle americane del folk e del beat, da Ginsberg a Kerouac a Bob Dylan […] Vi è sempre in Guccini e nella sua arte un’attenta osservazione della realtà contemporanea sia essa cittadina o popolare e contadina» (Jachia 2002: 15-16).
Ancora un segno evidente di come il ‘68 fu un anno «esplosivo» perché ha seminato un campo ricchissimo di musiche dove però le canzoni di Pietrangeli e Ronchini stavano insieme a quelle di Stormy Six e New Trolls, Jannacci e Guccini.




Bibliografia
- E. ASSANTE, L’anno di fuoco, intervista sul ‘68 a Francesco Guccini, in L’Italia del Rock, vol. 3, Il sound delle piazze, La Repubblica, Roma 1994 P. JACHIA, Introduzione a F. Guccini, 40 anni di storie romanzi canzoni,
- Editori Riuniti, Roma 2002 F. LIPERI, La ballata lunga un album, in L’Italia del Rock, vol. 3, Il sound
- delle piazze, La Repubblica, Roma 1994 G. MANFREDI, Sessantotto nel juke box, in Storia dei giovani. Prima, durante e dopo il Sessantotto, inserto di «Panorama» del 31 gennaio 1988
- S. NERI, Gaber. La vita, le canzoni, il teatro, Giunti, Firenze 2007
- «Radiocorriere TV», 21/27 aprile 1968
- L. SETTIMELLI, Il ‘68 cantato (e altre stagioni), Edizioni Zona, Arezzo 2008


